Qualche giorno fa sono incappata in una infografica di un’utente instagram che esortava a diventare attivisti. Come? Raccontando la propria esperienza in uno spazio sicuro in cui ci si sente capiti e poi ascoltare le storie altrui. È bizzarro come il termine attivismo abbia perso la componente di attività insita nella parola stessa. Basta postare un quadrato nero o delle elaborate infografiche su uno sfondo arcobaleno e immediatamente si diventa attivisti di una causa. Anzi, di varie cause, perché l’intersezionalità – cornice accademica utile per analizzare le intersezioni di diverse dimensioni sociali e identitarie applicandole ai grandi numeri – sui social trova terreno fertile per abbracciare con le infografiche qualunque causa esistente. Per il clima, contro il catcalling, contro l’omotransfobia, contro l’utilizzo di parole offensive, contro il razzismo, contro la feticizzazione dei corpi, per il body positive, contro la plastica.
Grazie all’intersezionalità applicata agli individui è sia possibile calcolare la percentuale di handicap che ognuno di noi si porta dietro, 60% acqua, 40% categoria discriminata, sia essere attivisti per una causa qualunque che viene dissezionata fino all’ultimo atomo di modo da produrre più post, nutrire l’algoritmo e, incidentalmente, guadagnare follower. L’attivismo, un tempo collettivo, è diventato appannaggio dei singoli svuotando di significato gli -ista che lo descrivono. Ogni lotta è declinata sul sé, ognuno la intende a proprio modo, e nessuno è in grado di non personalizzare l’ideale a cui sostiene di credere.
Su instagram sono tutti empatici (una nota sull’empatia, parola che dovrebbe essere multata a ogni utilizzo; se si è empatici si empatizza con tutti, addirittura con gli incel senza per questo dare per giusto l’universo schizofrenico che si sono creati. Non si empatizza solo con gli appartenenti alla propria categoria. Quello si chiama cerchiobottismo). Su instagram sono tutti buoni. Tutti portano il proprio sentire. Tutti hanno i pronomi con i quali vorrebbero essere appellati (malgrado nessuno abbia il minimo dubbio il novantanove percento delle volte). Tutti postano infografiche dal tono moralista in cui spiegano perché una cosa è giusta e perché è sbagliata.
A volte, senza che nessuno lo chieda (tipo il meme nobody) compaiono lunghi post in cui ci si sfoga per lo stress di stare sui social, si sottolinea quanto si stia sacrificando la propria mental health in nome delle infografiche di cui sopra. È un sacrificio imprescindibile, sono tutti martiri per la propria causa online. Nei commenti la parola più usata è “Grazie”, seguita da “Finalmente” e infine “Necessario”. Se il mondo reale rispecchiasse instagram i nostri problemi sarebbero finiti. Niente caporalato, fast-fashion abbattuto, plastica sterminata.
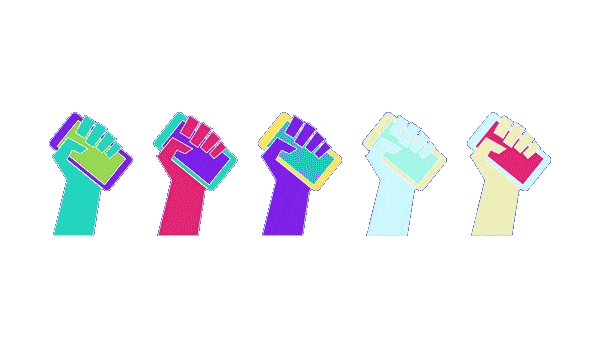
La cosa più divertente (o amara?) che ho visto ultimamente è una di queste infografiche a favore degli influencer. Il titolo è: The reality behind sponsored content. Seguono numerose slide in cui con tono svenevole si descrive la dura vita di chi fa branded content su instagram. Le contrattazioni con il cliente, l’algoritmo che non premia i contenuti sponsorizzati. L’influencer cerca disperatamente di veicolare informazioni intrise di valori positivi alla propria community: mettete like, commentate, ripostate nelle stories per aiutare la nostra categoria contro l’algoritmo che penalizza i contenuti sponsorizzati.
ogni lotta è un mercato del sé
Su instagram siamo tutti vittime. Forse il vittimismo è l’unica cosa che ci distingue da un brand a livello di comunicazione. I brand non sono vittime e vanno sempre guardati con sospetto. Quello che fanno i brand è sostenere le vittime cercando tramite queste ultime di vendersi alle community. Come mi ha detto al telefono una persona più grande di me che ha visto il mondo cambiare sotto i propri occhi, il mercato ora è il mercato del Sé. Per essere ammessi al gioco bisogna cedere brandelli di intimità in cambio di fama e follower.
Talvolta un brand è accusato di fare washing di qualcosa, ossia di camuffarsi eticamente (pinkwashing se la maschera è il femminismo, greenwashing se ambientalista) allora parte il call out. Il call out è lo strumento per stanare i colpevoli di essere falsi e non moralmente probi, un po’ come da Maria De Filippi. Se si riceve un call out ci si cosparge brevemente il capo di cenere, si sparisce per un mesetto durante il quale il percorso di espiazione è vivere la propria vita senza instagram, e poi si torna come se non si fosse mai mentito sui propri titoli o sul proprio passato.
I brand (ma anche le persone, ché su instagram non c’è differenza) si lavano in continuazione per rinascere con la pelle splendida di ciò che è di tendenza in un dato momento. Questo fenomeno fa sì che io riceva script da brand improvvisamente attivisti che sembrano scritti da un’intelligenza artificiale che cerca di spacciarsi per umana al Turing test. Se un giorno l’umanità fosse colta da un virus il cui sintomo principale è rendere gli uomini bramosi di prodotti chiusi in confezioni di plastica, ecco che i brand non esiterebbero a fare del plastic-washing.
Nell’attivismo performativo ogni lotta è declinata sul sé e nessuno è in grado di non personalizzare l’ideale a cui sostiene di credere.
L’attivismo performativo non è una novità. Esiste da prima dei social, ma ha visto nuovo lustro grazie alla pandemia e a una spropositata quantità di tempo trascorsa a chiedersi come essere visti e far carriera. Assistiamo attoniti a quel conoscente un tempo ignavo che improvvisamente ha iniziato a farsi paladino di una qualunque causa etica pescata dal mazzo, di solito quella più vicina alla propria identità – niente è più semplice di parlare di se stessi. A onor del vero si tratta di solito di donne, suppongo perché siamo ancora noi a dover essere brave e buone, il diritto a fare schifo non ce lo siamo ancora guadagnato, e di questo passo non credo avverrà presto.
Instagram, azienda privata che ci affitta uno spazio di rappresentazione in cambio dell’estrazione delle nostre informazioni per fini di marketizzazione nel migliore dei casi, è stato pensato per rendere le persone brand, e anche questa non è una novità. Quando si costruisce un brand si fanno due cose principalmente: si scelgono i valori da attribuire al brand e il posizionamento di mercato. Da qui si inizia a sviluppare la brand identity, ossia gli elementi che concorrono a rendere il brand facilmente riconoscibile dal consumatore, a partire dal naming, il payoff (per esempio il Just do it della Nike), il logo, la vision (gli obiettivi) e la mission (la messa in pratica).
Questi ultimi due punti non sono espliciti per il consumatore, ma lo sono per chi lavora dietro le quinte. Tutte queste dimensioni confluiscono infine nel tono di voce. Su instagram c’è il naming, c’è l’immagine del profilo, c’è il payoff e la volontà della persona a postare un numero di stories adeguate per le bizze algoritmiche (i mesi di lavoro in ambito mediatico e pubblicitario sono scanditi dai capricci algoritmici. Ogni tanto qualcuno viene in ufficio annunciando che è tutto cambiato.
Ora il social premia poche stories e non vuole la ricondivisione di post sulle stories, pena l’arretramento di popolarità nel feed altrui). Con le nostre personalità organizzate in categorie dai confini rigidi, siamo molto più semplici da leggere per chi ci vuole vendere qualcosa. E infatti i brand hanno solo guadagnato dalla marketizzazione identitaria. Sanno che è meglio vendere un sapone body positive che una volgare saponetta, e mi ritrovo in riunioni che mostrano slide con donne di ogni forma e dimensione che sorridono con una saponetta in mano (salvo poi avere, come testimonial concrete, delle ragazze che non sono modelle ma sono comunque bellissime).
Alcuni brand organizzano chiacchierate tra donne splendide nelle quali queste ultime mostrano le proprie cicatrici o i propri invisibili difetti. Invece di dire alle ragazze che non per forza devono coincidere con la propria immagine, gli abbiamo detto che il diritto che gli spetta è quello di apparire ovunque e comunque. Le donne rimangono oggetti, anche se ora sono oggetti di qualunque taglia. Era questo che volevamo? Continuare a coincidere con la nostra identità di femmina? Continuare a truccarci, comprare, decorarci, a vestirci e a guardarci ossessivamente?
Inoltre, sia chiaro, non sta cambiando ciò che ci attrae, né stiamo facendo meno attenzione a come siamo fatti. Per quanto ci affanniamo a gridare che i corpi sono tutti uguali, i tempi di reazione calcolati dagli algoritmi dei social conoscono ciò che ci erotizza, e così su TikTok lo stesso algoritmo premierà la gioventù, le tette grosse e il vitino da vespa.
DIVENTARE BRAND
Rappresentarsi non ha una connotazione negativa o positiva. Lo facciamo di continuo quando scegliamo come vestirci, quando ci presentiamo a qualcuno. Gli psicologi lo sanno da sempre, viviamo seguendo dei copioni strutturati che immaginiamo comunichino agli altri ciò che speriamo di essere. Solo che un tempo la performance aveva una fine e quella fine era il momento in cui ce ne tornavamo a casa e ci mettevamo in mutande a fare schifo. Qualche volta si sente ripetere la frase per cui non si possono giudicare le persone dai social network. Non credo sia vero. Credo anzi che ciò che si posta sui social sveli più cose di quanto non si immagini perché ciò che si sta creando è una narrazione del sé. Se la narrazione non coincide con la competenza la parola che affiora più spesso sulle labbra mentre si scrolla è: che mitomane. A chi ha occhi per vedere, instagram trabocca di persone in mutande che pensano di indossare abiti elegantissimi.
Non credo che le persone che si brandizzano siano in malafede, banalmente perché la scissione di un Sé virtuale buono e di un Sé reale critico è appannaggio di persone particolarmente acute o particolarmente scisse. La malafede consapevole è più rara di quanto non si creda. Il nostro cervello fatica a essere incoerente e preferisce impigrirsi su una narrazione infiocchettata. Dando per vero l’assunto per cui ciò che si è coincide con ciò che si fa tutto il giorno, se tutto il giorno si scrivono banalità su slide colorate difficilmente si ha il tempo di essere altro.
Originariamente però le persone erano complicate. In teoria lo sono ancora. Sono contraddittorie, possono compiere una buona azione e subito dopo una cattiva – se si vuole mantenere la struttura manichea dei social. La nostra identità è composita. Sui social diventa monolitica ed essenziale. Si è donne, si è queer, si è vittime di, si è neri, si è portatrici di hijab. Cerchiamo di liberarci del genere e ci rimaniamo attaccati come resina sui tronchi di pini. La community segue in virtù dell’identità del seguìto, e questa identità non può contenere troppe incongruenze. Se si è femministi si è solo femministi (qualunque cosa significhi).
Se si è vegani lo si è fino al midollo. È svilente sentire di esistere solo in base alla caratteristica che più definisce all’apparenza ma non riusciamo a farne a meno, perché in fondo è più facile coprire le proprie lacune identitarie con un unico grande telo piuttosto che affrontare i conflitti che ci fanno sentire sospesi. Philip Bromberg, uno dei pensatori più lucidi nel Novecento sui temi della malattia mentale, sosteneva che il sintomo del disagio è la rigidità. Il benessere coincide con il fluttuare tra le anime che ci abitano, il malessere invece è rimanere intrappolati in un’unica dimensione. Con i social ci siamo chiusi a chiave nella stanza della nostra identità sulle cui pareti si specchia il nostro volto mentre il pubblico applaude.
Siamo un milione di cose diverse, e l’identificazione coatta con un solo elemento è una gabbia dalla quale scappare anche quando ci fa guadagnare migliaia di euro, perché nel momento in cui le persone diventano brand permettersi di cambiare idea, di farsi attraversare dalle cose che si vedono o si pensano, è impossibile. Mio nonno diceva che la coerenza appartiene agli scemi. Sui social bisogna essere coerenti. Estremisti. O si è dentro o si è fuori, e chiunque dica qualcosa che sfugge dall’universo morale del bene e del male viene escluso.
Trovare nuove parole per descrivere il mondo che ci circonda è un fenomeno ineluttabile. Ma ciò che si chiede di fare adesso è forzare il linguaggio ad assumere la silhouette di una realtà che ancora non esiste.
Qualche settimana fa sono stata invitata in una room di clubhouse di persone che lavorano in pubblicità a seguito di un articolo che avevo scritto per Wired. Secondo il loro punto di vista il call out tra singoli e contro i brand è ottimo, perché serve a educare entrambi. Siamo consumatori prima che cittadini, il modo per cambiare il mondo è selezionare ciò che si compra. Il welfare è morto, mi hanno detto (come dargli torto). Quando qualcuno ti dice di non comprare più noci dentro confezioni di plastica che hai incautamente fotografato e postato, tu non le compri più. Ho obiettato che magari smetti di fotografarle. Impossibile. Perché l’altra faccenda è che, sebbene ripetiamo ossessivamente che ciò che vediamo sui social non è vero, la nostra coscienza lo dà per vero. Quindi crediamo a tutto quello che ci viene detto e mostrato e la facoltà di definirsi è in mano a coloro che si definiscono.
Martina Big è una modella (?) tedesca che a un certo punto ha deciso di sottoporsi a un milione di operazioni chirurgiche per diventare nera. La comunità nera è insorta, ma questo caso è interessante perché da un certo punto di vista Martina Big fa esattamente quello che facciamo tutti su instagram. Si definisce e si trasforma a seconda della definizione scelta. È libera di farlo tanto quanto lo siamo tutti.
Mobilitazione social
Uno dei saggi più belli che abbia mai letto è di Eagle, si intitola Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. È un testo che analizza come è cambiata la psicanalisi parallelamente al mutamento di paradigma che ha accompagnato sommessamente il novecento. Dalla Rivoluzione Francese fino a una settantina di anni fa, ciò che veniva cercato ossessivamente era la verità. L’Illuminismo era all’affannosa ricerca della verità oggettiva, la verità scientifica, la razionalità. Anche la psicanalisi funzionava così: andavi dall’analista per scoprire la verità, che era una. I sogni volevano dire una cosa (il cazzo), e l’isteria celava sempre un unico problema (più o meno sempre il cazzo).
La verità era una perché si dava per scontato che fossimo tutti uguali. Con l’insorgere dell’individualismo – mi secca anche solo scriverlo – le verità si sono moltiplicate e la psicanalisi, per esempio, è diventata relazionale. Con il passaggio a questa nuova filosofia che ci sottende tutti non cerchiamo più la verità collettiva, cerchiamo ognuno, individualmente, la nostra verità. Sarebbe stupido giudicare questo mutamento fisiologico, che come tutti i mutamenti si porta dietro aspetti positivi e aspetti negativi, ma vale la pena analizzarlo per provare a indovinare la direzione verso la quale stiamo, ciascuno per conto proprio, andando.
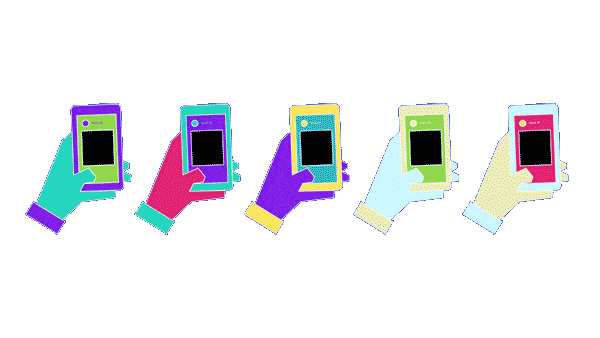
Una mia amica più saggia di me sostiene che per capire le persone non si dovrebbe mai ascoltare ciò che dicono ma solo guardare a ciò che fanno. Nei test psicologici a risposta multipla molte delle domande sono traditrici. Non si prende in considerazione ciò che la domanda chiede ma come il soggetto risponde. Questo perché si è visto che quando ci viene chiesto di descriverci, lo facciamo cercando di dare un’immagine smagliante di noi stessi. In un’altra intervista clinica che viene usata per valutare l’attaccamento adulto, ossia la qualità del legame che si è sviluppato tra caregiver e bambino durante l’infanzia, ciò che si valuta non è ciò che il paziente racconta, ma come il paziente racconta. Spesso quando viene chiesto alle persone del proprio rapporto con la madre, queste rispondono che la relazione era meravigliosa. Se gli si chiede di raccontare un singolo episodio a dimostrazione di questa affermazione non sanno farlo. Mai fidarsi di ciò che ci raccontiamo e raccontiamo agli altri.
Eppure sui social è ciò che facciamo perché l’unico elemento al quale possiamo fare affidamento è il linguaggio. Possiamo attaccarci solo alla lingua, unica testimone della verità. E possiamo farlo anche perché allo stesso tempo non esiste una classe politica degna di questo nome che cerchi di incidere sulla realtà. Si cercano fonemi, desinenze, nomi di categoria via via più sottili con la speranza che queste ultime cambino il pensiero collettivo. Non è certo una teoria nuova quella del linguaggio che modella il pensiero, ma in quest’era di semplificazione pare che basti quello a trasformare una società ingiusta in una impeccabile. Il parlato cambia di continuo in maniera naturale azzuffandosi e mescolandosi con la realtà che muta.
Trovare nuove parole per descrivere il mondo che ci circonda è un fenomeno ineluttabile. Ma ciò che si chiede di fare adesso è forzare il linguaggio ad assumere la silhouette di una realtà che ancora non esiste. Le parole hanno iniziato a farci paura, invece di svuotarle del loro significato consumandole fino all’usura, le abbiamo caricate di significati orrendi. Le persone che rientrano nella norma – vale la pena specificare: non una norma morale, una norma statistica – si affannano a capire come alcune minoranze preferiscono essere chiamate, dando per scontato che queste minoranze siano un unico grande blocco di persone che si definisce tramite un unico termine e tramite l’unica caratteristica che secondo chi non ne fa parte li definisce. In una realtà che controlliamo sempre di meno, l’unica cosa che possiamo cambiare è la lingua, e questo mi rende triste.
Qualcuno obietterà che proprio in questi giorni c’è stata una mobilitazione social per il ddl Zan. Vero e giusto, ma la campagna per il ddl Zan ha i toni di un reality accecante. Pillon sembra un cattivo Disney che si spaccia con un sorriso da Rattigan per Enzo Miccio. È il villain contro i buoni di instagram: Chiara Ferragni, principessa morale del paese, fresca di rinascita femminista con la maglia di Dior We should all be feminists, madre e imprenditrice, e il marito Fedez che da anni coltiva la sua politica annacquata da radicale ingenuo da cui si dirama la scia di mani di famosi cosparse di pennarello. Benvenga la legge Zan, di facile comprensione e scintillante tendenza.
Hanno ragione i colleghi di clubhouse: ora che siamo brand non siamo più cittadini, siamo consumatori. Non chiediamo più allo Stato di fare qualcosa, lo chiediamo ai brand (e quindi a noi stessi) a cui non costa nulla parlare dell’unica cosa che ci è rimasta e che potenzialmente può darci lavoro: la politica dell’individuo. Nessuno ha idea di cosa stia facendo Mario Draghi al governo – che non piace, ma almeno ha l’intelligenza di non frequentare i social – come usciremo dalla crisi economica che ci attende, come verrà organizzato il recovery fund. Tutti, mentre sgomitiamo per trovare un lembo identitario ancora intonso che possa portare gli occhi degli altri su di noi, sappiamo però quanto è sbagliato non rappresentare una taglia 46 in una pubblicità di saponette.










