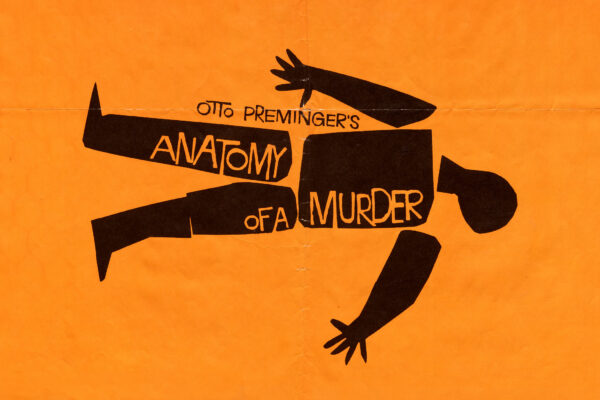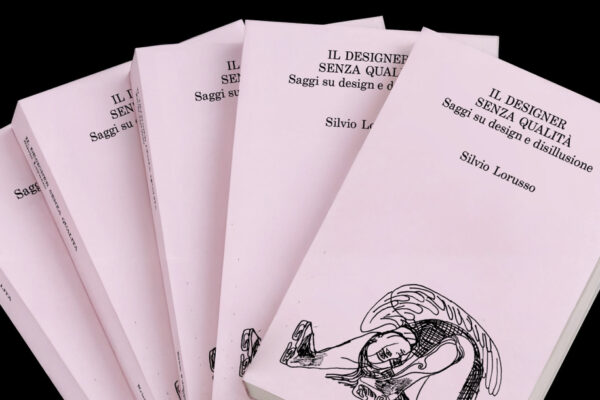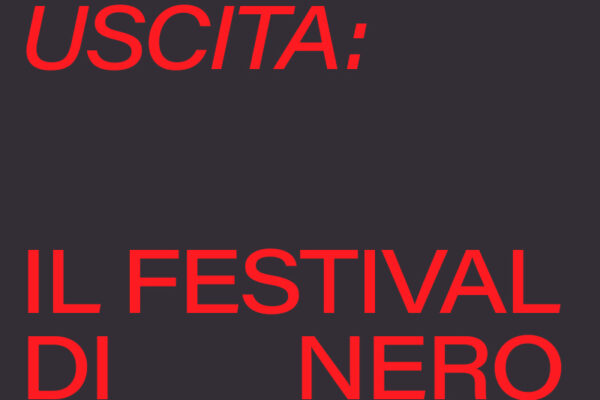Ogni epoca italiana ha avuto il suo mostro: una figura oscura che emerge dal fondo della cronaca e, per un po’, sembra racchiudere tutte le ossessioni di un popolo. Come se il Paese, per capire se stesso, avesse bisogno di immaginare un volto da accusare, da esorcizzare o da compatire.
Oggi, mentre una nuova serie Netflix diretta da Stefano Sollima riporta in vita il caso del Mostro di Firenze, se osserviamo bene, dietro la storia resta la domanda antica: perché certi racconti non smettono di colpirci?
La risposta breve è che il vero “mostro” non è mai stato un uomo solo, ma lo specchio che la società costruisce per non vedere se stessa. Dal fascismo agli anni della contestazione, dal dopoguerra all’era digitale, ogni “mostro” italiano ha incarnato le contraddizioni del Paese. Girolimoni, Cianciulli, l’assassino di Firenze, Olindo e Rosa, sono nomi diversi per un’unica funzione simbolica: il mostro è l’ombra che proiettiamo alle nostre spalle.
Gino Girolimoni e la macchina del colpevole
Roma, anni Venti. L’Italia del regime si traveste di ordine e disciplina. Le strade devono essere pulite, i giornali devono rassicurare. I treni… lo sappiamo. In questo paesaggio, tra il monumentale e la retorica cringe, si apre una crepa: tra il 1924 e il 1927, quattro bambine vengono uccise nei quartieri popolari della capitale. Il popolo, educato alla fede nel Duce e nella patria, chiede un colpevole.
La polizia trova Gino Girolimoni, un fotografo, un uomo qualunque. Ha il volto giusto per la paura: non troppo povero da ispirare pietà, non troppo potente da risultare intoccabile. In poche settimane diventa “il mostro di Roma”. I titoli dei giornali lo condannano con zelo patriottico: la giustizia fascista ha trovato il suo uomo.
Ma Girolimoni è innocente. Nel 1928 viene prosciolto con formula piena: “per non aver commesso il fatto”. Mussolini probabilmente ordina che dell’assoluzione non si parli più: solo un quotidiano dedica poche righe alla notizia. Girolimoni morirà pochi anni dopo, distrutto dalla calunnia.
Il “mostro” serve come atto di purificazione collettiva: il male è incarnato in un singolo individuo, così lo Stato – lo stesso Stato che aveva ammazzato Matteotti nel 1924, durante i primi omicidi delle bambine – può dichiararsi puro. Il regime aveva bisogno di un mito del male per confermare la propria idea del bene. Così Girolimoni fu sacrificato sull’altare del fascismo nascente.
Leonarda Cianciulli e la maternità spaventosa
Tra il 1939 e il 1940, mentre l’Italia fascista marcia verso la guerra, in una casa di Correggio si consuma una serie di omicidi che raccontano un’altra Italia: quella della miseria, della superstizione, della marginalità femminile. Leonarda Cianciulli uccide tre donne – Faustina Setti fu uccisa nella primavera del 1939, Francesca Soavi nel settembre 1939, e Virginia Cacioppo nel settembre 1940 – attirandole con false promesse. Poi ne scioglie i corpi, ne ricava sapone e dolci.
È passata alla storia come “la saponificatrice di Correggio”
Ma dietro questa atrocità c’è qualcosa di più della follia individuale. Leonarda crede nelle maledizioni, nei tarocchi, nelle formule che promettono protezione. Ogni omicidio è per lei un sacrificio per salvare i figli dalla guerra.
Quando il processo si apre, il 12 giugno 1946, l’Italia intera si affolla attorno ai giornali. C’è curiosità, e forse anche riconoscimento: in quella donna si legge un Paese ancora intriso di credenze ancestrali. Il caso funziona come schermo su cui proiettare un’Italia “contadina e superstiziosa” da espellere nel nuovo dopoguerra. La copertura mediatica trasforma Leonarda in “strega” e il processo in favola nera, separando la modernità repubblicana nascente da un passato da esorcizzare.
In qualche maniera, l’orrore della guerra rientra in casa: corpi smembrati, bolliti, “sapone” e “pasticcini” trasformano la violenza collettiva in rituale domestico. Il caso offre un modo di parlare della guerra senza parlarne, spostando l’angoscia su una figura singola e femminile. I racconti dei giornali inquadrano la figura femminile dentro archetipi antichi – la strega, l’alchimista di cucina – facendo del focolare il luogo dell’orrore. Una maniera anche di disciplinare il femminile.

Il mostro di Firenze e il corpo scandaloso
Poi arrivano gli anni Settanta e Ottanta, e l’Italia cambia pelle. Tra il 1974 e il 1985, sette coppie vengono uccise nelle campagne fiorentine mentre cercano intimità lontano dagli sguardi. L’ultimo delitto avviene nella notte tra il 7 e l’8 settembre 1985. Il mostro di Firenze forse è lo spettro di una doppia morale che ancora agita il corpo del paese: da un lato l’emancipazione sessuale, dall’altro la paura che la libertà porti il caos.
I giornali parlano di sesso e di morte con la stessa ansia con cui la televisione dell’epoca mostrava le forme femminili e poi le censurava. Il Mostro è il guardiano tremendo di un ordine morale che fatica a morire. Negli anni in cui l’Italia dibatte di divorzio (1970 la legge, 1974 il referendum abrogativo), i diritti civili, l’aborto (1978), l’assassino delle coppiette sembra punire proprio quel desiderio di libertà.
Le indagini – caotiche, contraddittorie, con piste esoteriche (la presunta setta esoterica, i ‘compagni di merende’) e persino complotti internazionali – riflettono la crisi di uno Stato incapace di proteggere i cittadini. La paranoia collettiva che avvolgeva il Paese negli anni del terrorismo rosso e dello stragismo fascista trova nel Mostro una rappresentazione perfetta: una pallottola o un esplosivo che può colpire chiunque.
La figura del contadino toscano “con il physique du rôle” (Pacciani) funziona anche come bersaglio sociale. La violenza è povera, rurale e ignorante; il ceto medio si autoassolve.
Inoltre, la figura unica del “Mostro” permette di non guardare alla violenza maschile ordinaria (stalking e femminicidi non seriali): isolando il male in un’entità eccezionale, si evita il discorso strutturale su genere e potere. La conseguenza simbolica è che la violenza non appare come prodotto di norme e rapporti di forza, ma come devianza individuale.
In fondo, la caccia al colpevole è più rassicurante della scoperta che il male è diffuso, condiviso, ordinario.

Piccoli mostri da talk show
La stagione recente sposta il “mostro” dal bosco all’open space televisivo, e trasforma il laboratorio forense in un nuovo palcoscenico morale.
Cogne. La mattina del 30 gennaio 2002, nella tranquilla località montana di Cogne, il piccolo Samuele Lorenzi, tre anni, viene trovato morto nel suo letto, ucciso con violenti colpi alla testa. In casa ci sono solo la madre, Annamaria Franzoni, e il fratellino. L’omicidio di un bambino in un contesto familiare borghese, apparentemente sereno, scatena un’attenzione mediatica senza precedenti.
Il caso Cogne inaugura una nuova era: quella in cui il processo non si svolge più solo in tribunale, ma si consuma simultaneamente in televisione. I programmi di cronaca nera e i talk show del prime time diventano aule parallele dove si discutono perizie ematiche, schizzi di sangue sui muri, tracce biologiche sui vestiti, tempistiche delle telefonate. Si analizzano pubblicamente valutazioni psichiatriche, si commentano espressioni facciali, si teorizzano dinamiche familiari. La perizia diventa spettacolo, il perito diventa ospite fisso, il pubblico da casa diventa giuria popolare.
Annamaria Franzoni viene condannata definitivamente nel 2008 a 16 anni; tornerà libera nel 2018. La copertura mediatica sposta continuamente il focus tra “madre-mostro” e “errore giudiziario”, con il saliscendi emotivo tipico del talk. Cogne segna il momento in cui la giustizia italiana diventa intrattenimento seriale: non più solo informazione, ma dramma collettivo da commentare, consumare, rivivere a ogni anniversario.
Erba. Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2006, quattro persone vengono uccise in una palazzina di Erba (Como): Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, sua madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini. Olindo Romano e Rosa Bazzi, coppia di vicini, vengono arrestati, confessano e poi ritrattano. Nel 2011 arrivano le condanne definitive all’ergastolo.
Ma il caso non si chiude. Negli anni successivi diventa un “cold case mediatico” ancora aperto: docuserie (come quella di Netflix), podcast investigativi, campagne social e petizioni online alimentano il dubbio. Emergono testimonianze contestate, perizie rivalutate, ipotesi di complotti o errori giudiziari. La narrazione si biforca: da un lato la giustizia che ha fatto il suo corso, dall’altro un pubblico che continua a interrogarsi, a cercare falle, a proporre versioni alternative. Nel 2024 la Corte d’Appello respinge la revisione; nel marzo 2025 la Cassazione chiude la porta e a maggio 2025 deposita motivazioni: “prove solide” e riscontri “minuziosi”. La saga conferma che spesso la caccia alla verità sopravvive alla verità giudiziaria.
Garlasco. Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi viene trovata morta nella sua casa di Garlasco (Pavia), uccisa con un oggetto contundente mai identificato né ritrovato (forse un martello o un attizzatoio da camino). Il fidanzato Alberto Stasi, studente di economia, viene indagato. Il caso diventa subito mediatico: perizie balistiche, analisi delle tracce ematiche, ricostruzioni dei tempi di percorrenza, testimonianze contraddittorie. Nel 2015 arriva la condanna definitiva all’ergastolo per Stasi.
La sentenza chiude il processo, ma non la storia. Nel 2025, diciotto anni dopo l’omicidio, la Procura di Pavia riapre l’inchiesta. Nuove analisi genetiche portano all’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, ex compagno di scuola di Chiara. I vecchi atti processuali, i “dati grezzi” custoditi per anni nei laboratori forensi, e le tecnologie di sequenziamento genetico di nuova generazione che permettono di rileggere tracce considerate un tempo insufficienti.
L’attenzione si concentra sulle micro-tracce: DNA ritrovato sotto le unghie della vittima, frammenti biologici microscopici che solo oggi possono essere isolati e identificati con precisione. La scienza forense diventa protagonista assoluta. L’Italia chiede alla genetica ciò che un tempo chiedeva alla confessione: non solo prove oggettive, ma rassicurazione, chiusura, senso.
E intanto il caso si trasforma in serie ongoing: dossier giornalistici a puntate, incidenti probatori annunciati e poi rinviati, fughe di notizie seguite da smentite istituzionali in tempo reale sui social. Ogni nuova perizia diventa un episodio, ogni deposizione un cliffhanger. Garlasco è il caso che mostra come la giustizia contemporanea sia diventata spettacolo tra laboratorio e streaming.
Come nel film Zodiac di Fincher), il vero protagonista diventa l’indagine: dossier, perizie, profili, “nuove piste”. L’infinito investigare rassicura più della soluzione: la società si contempla nello specchio della propria ossessione conoscitiva.

E adesso, cosa stiamo cercando su Netflix?
Nel 2025, la serie tv di Sollima riapre la ferita collettiva del mostro di Firenze. Perché proprio ora? Proviamo a buttare giù qualche ipotesi:
1) Nostalgia di un male identificabile. All’epoca pensavamo che arrestare “un volto” bastasse a chiudere la storia; oggi viviamo minacce diffuse (riscaldamento globale, precarietà economica, guerre di droni, algoritmi impredicibili). Il Mostro ci riporta a un mondo in cui il Male aveva forma umana — quindi sembrava controllabile.
2) Bisogno di una narrazione chiusa. Le serie danno ciò che la realtà nega: inizio-sviluppo-fine. Anche quando il caso resta irrisolto, la struttura consola: non vende “la verità”, ma l’ordine del racconto. Obiettivo che nel contesto sempre più frammentato dei social media, della post-verità e dei deepfake irriconoscibili sembra avere una funzione di comfort psichico non indifferente.
3) La partecipazione allo spettacolo del dolore. Dai talk show ai feed social ogni vittima è un personaggio, ogni perizia un thread. Commentiamo in tempo reale, ci sentiamo parte dell’indagine. Il confine tra empatia e voyeurismo svanisce. Tuttavia, banalmente, ci riconosciamo differenti dai mostri. È una partecipazione che ci rassicura come il gossip al rinfresco dopo un funerale.
Eppure forse può esserci utile anche volgere lo sguardo a quasi un secolo fa, quando il cinema era lo spettacolo popolare per antonomasia.
Gli ultimi fotogrammi di M – Il mostro di Düsseldorf sono una domanda sulla giustizia. Il film di Fritz Lang è del 1931, due anni prima della presa del potere definitiva di Hitler in Germania.
Il filosofo e critico cinematografico Siegfried Kracauer scrisse dei brani fondamentali sull’argomento (oggi si possono trovare in Da Caligari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco. Lindau): M, insieme ad altre pellicole della Germania di Weimar, fu proiezione dell’inconscio politico in grado di rivelare pulsioni autoritarie. Nel film la polizia appare impotente; la “giustizia” passa a organizzazioni parallele (la rete dei mendicanti, le organizzazioni criminali).
Il mostro è capro espiatorio che ovviamente non cura le vere cause della violenza e del caos sociale. E, come nel periodo nazista, può essere replicato su scala di massa creando tanti nemici sociali.
Ogni epoca proietta le sue ossessioni. Adesso sappiamo che il mostro non è mai un uomo solo, ma forse fatichiamo ancora a capire cosa ci sta dicendo. La parola latina monstrum significa certamente “creatura mostruosa”, ma anche “prodigio, presagio e avvertimento”.