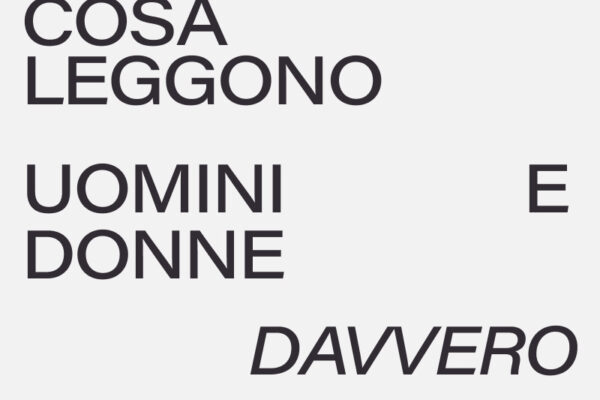“Sono una gif!” esclama Terry, un personaggio della serie I May Destroy You di Michaela Coel, quando si ritrova online, trasformata in un supporto grafico dopo la partecipazione ad un evento mediatico.
Terry è trionfante e vittoriosa di fronte alla metamorfosi digitale, non solo perché le dona visibilità (è aspirante attrice), ma anche perché la cosiddetta “memefication” rappresenta, almeno secondo la morale autocritica della serie, la definitiva attestazione di esistenza – online come offline, pubblica e privata – in un mondo che ci fa continuamente dubitare di noi. Se prima bisognava darsi un pizzicotto per accertarsi di esistere, oggi forse basta cercarsi su Google.
Noi però come ci comporteremmo, se un’istantanea della nostra esistenza venisse asportata a caso e gettata online senza alcun tipo di riferimento? La decontestualizzazione può produrre equivoci pericolosi e immense frustrazioni. Non bisogna neanche citare fake news o i numeri pescati alla rinfusa durante la graficomania che ci ha investiti durante la pandemia. Basta pensare a quella puntata di Curb Your Enthusiasm, dove Larry David viene fotografato dall’autovelox.
Il caso di Terry è il più puro (e anche il più improbabile): quello di una persona comune che assiste alla trasformazione del proprio sé in oggetto digitale. Praticamente la mercificazione dei due secondi di celebrità, senza però che essi abbiano alcun valore economico (a meno che Terry non decida di convertirsi in NTF – ma quella sarebbe tutta un’altra storia). Raramente di un meme si rivendica la paternità o si è interessati a rintracciarne la genesi, come è successo a Hide the Pain Harold e alla rana dell’alt-right. Le battaglie legali legate alla proprietà dell’immagine sembrano essersi fermate all’epoca del Techno Viking. In pochi sapranno che il meme Distracted Boyfriend nasce da una foto stock del fotografo Antonio Guillem poi rimaneggiata da un gruppo prog rock turco nel 2017. Per come è concepito il suo personaggio, Terry non considera la rimozione del proprio contesto fisico e culturale come uno svantaggio, anzi. Gioisce della moltiplicazione del sé e fantastica della possibilità di altri individui di rivedersi in lei, esattamente come lei fa con contenuti social preesistenti. È come se, in un certo senso, diventasse padrona di ciò che gli studiosi dei media e sociologi chiamano il “collasso del contesto,” e cioè il crollo delle barriere fisiche e concettuali connesse alla fruizione dei media e il conseguente riversamento di tanti pubblici diversi all’interno di un unico terreno di riferimento comune.

Prima che internet mutasse i contenitori tradizionali in una gigantesca vasca di palline colorate, un altro mezzo ha cominciato ad abbattere i confini di riferimento: la TV. Nel 1980 un lunghissimo articolo occupò interamente un numero del New Yorker.
Si intitolava “Within the context of no-context” e il suo autore George W.S. Trow esplorava, con uno stile lirico lontano dalla prosaicità consueta della testata, il panorama mediatico degli Stati Uniti. Trow identificava un cambio socio-culturale paradigmatico e suggeriva analogie tra la diffusione della televisione, il collasso della dimensione pubblica e privata nei media di massa e il riflettersi di questo processo nei contenuti audiovisivi nonché nella loro fruizione. La TV avrebbe rimpiazzato una cosiddetta distanza mediana tra lo spazio domestico-privato (“the grid of intimacy”) e lo spazio nazionale condiviso (“the grid of two hundred million”, la popolazione statunitense all’epoca). Ciò perché certe attività sociali potevano, a partire dal tubo catodico, venir eseguite individualmente, in solitudine, talvolta rimpiazzandone altre di tipo fisico. Ma anche perché la presenza del mezzo accelerava la segmentazione della popolazione in gruppi demografici che diventavano consumatori di riferimento. Così le generazioni nate dal dopoguerra in poi cominciarono a identificarsi non più in un’idea di popolazione variegata ma “coesa nel suo procedere uniforme lungo l’asse temporale-storico”, bensì in vari gruppi di mercato progressivamente sganciati da contesti temporali e spaziali precedentemente considerati essenziali.
Prima che internet mutasse i contenitori tradizionali in una gigantesca vasca di palline colorate, un altro mezzo ha cominciato ad abbattere i confini di riferimento: la TV.
Internet ha evidentemente esacerbato questo processo, sofisticandone possibilità e sovrapposizioni, e facendo sfumare i confini tra chi crea e chi è usato, tra chi vende e chi consuma, tra chi guarda e chi è guardato. Come anticipava Trow, oggi è demograficamente più pertinente se ci identifichiamo in istanze sincroniche particolari – tipo i contenuti a cui mettiamo like o la preferenza di certe emoji su altre – piuttosto che in esperienze storiche condivise – tipo se da generazioni leggiamo il Corriere dello Sport invece della Gazzetta o se da bambini guardavamo Non è la Rai. Bersaglio di Trow era anche il linguaggio pubblicitario, che “rubava” il registro intimo del privato per sfruttarlo in un contesto pubblico e orientato a scopi commerciali. Come esempio portava il famoso slogan “I Like Ike”, per la campagna elettorale di Eisenhower, in cui per la prima volta una figura autorevole veniva chiamata confidenzialmente col nome proprio, trasformando la propaganda politica in una specie di jingle musicale. Per Trow l’efficacia di questo motto si doveva alla cosiddetta “estetica della hit”, che suscitava un attaccamento e una vicinanza quasi empatica per contenuti mediatici asportati dal loro tessuto iniziale. È «L’attrazione [che proviamo] nei confronti di un modo inappropriato di esprimere attenzione, aspirazione e affetto verso un luccichio [che] fa scaturire (…) una nebbiolina di energia che assomiglia all’amore ma è banale, che ricorda un senso di familiarità ma tende a scomparire».
Nella sua critica alla sparizione del contesto sociale e culturale, Trow vedeva un declassamento, esprimendo un giudizio moralistico oggi sorpassato. Ma trovo che la sua frase descriva bene il rapporto ambivalente che intratteniamo con internet, soprattutto nelle sue manifestazioni più spontanee come meme, gif, screenshot e nell’uso che facciamo di questi oggetti, con cui interagiamo senza inibizioni e allacciandovi uno strano legame, quasi affettivo. L’internet-feticismo di Terry riflette questo attaccamento, che valorizza la spinta democratica legata alla genesi popolare di questi contenuti nonché la loro ribellione rispetto al contesto, mentre ne ignora aspetti meno nobili (come ad esempio l’impoverimento semantico o l’omologazione delle potenzialità espressive se tutti usiamo gli stessi supporti o sistemi di riferimento). Viene perciò da chiedersi se l’assenza di contesto non possa anche diventare un’opportunità, una forma di ricchezza o la nascita di qualcosa di nuovo.
Come al personaggio di I May Destroy You, a tutti sarà capitato di utilizzare contenuti social per comunicare le proprie emozioni. Non è raro identificarsi in un meme in modo più istantaneo e gratificante di quanto si possa fare descrivendo compiutamente uno stato mentale, soprattutto perché attinge a un bacino collettivo e porta dunque la promessa di una “connessione” migliore.
Spesso, il mercoledì, con un caro amico mi spedisco un link a questo profilo Twitter: ci basta per comunicarci che la settimana non sta andando granché bene. Se dovessi parlare solo tramite meme, lo farei con un altro account Twitter, Boris out of context , una delle tante iterazioni di pagine social-umoristiche che condividono frammenti di un prodotto noto, privato di contesto. Ci sono quelli puramente testuali, come ad esempio l’ora interrotto ma sempre ilare @NYTMinusContext, oppure screenshot con sottotitoli nel caso di film o serie, come @nocontextbuffy. L’eccezionalità di Boris, la serie televisiva di cui si sta girando la quarta stagione, con la sua acuta rappresentazione della società italiana, meriterebbe un articolo a parte. Ma commentare online fatti di attualità politica con “Non leggo niente e sto benissimo” o lamentandosi via chat con un’amica perché “Voglio la merda del passato” fa crollare e allo stesso tempo ribadire i sistemi di riferimento in un atto che può essere sia liberatorio che fuorviante. Stiamo sguazzando nella piscinetta della cosiddetta contextomy, la pratica della citazione impropria.

L’arte di citare fuori contesto – “contextomy” appunto, per i teorici della comunicazione – esiste da sempre, ma forse solo di recente è osservata all’infuori del campo legale o scientifico-accademico. Tra gli esempi più inoffensivi c’è il modo in cui opera il marketing delle uscite cinematografiche, che abbellisce trailer e poster con virgolettati delle recensioni isolando una parola positiva tratta da una stroncatura. Dall’avvento dei social media via il Russia Gate & co., fino alla pandemia e oltre, l’agilità con cui tutti, anche fonti autorevoli, fruiscono contenuti decontestualizzati è corresponsabile di fenomeni deleteri come la proliferazioni di trolling e teorie del complotto. Superficialmente però, la maggior parte di contenuti come meme e co. conservano la loro natura “innocua” – nel senso che adempiono perlopiù a fini umoristici. Il che non significa che non possano veicolare significati offensivi o pericolosi, e che a volte non sia difficile distinguere la loro artificialità dalla realtà in cui viviamo. Ad esempio, il video della reazione di Trump, allora presidente, alla morte di Ruth Bader Ginsburg. Ripreso su una specie di pista d’atterraggio, vicino a un aereo, Trump commenta «She was an amazing woman» proprio mentre Tiny Dancer di Elton John risuona in sottofondo, “pretty eyes… pirate smile…”. Guardandolo così senza contesto e sapere che la traccia veniva utilizzata per chiudere i suoi raduni, sembrava un falso, un video editato a posteriori. Quasi un meme “cresciuto spontaneamente” in natura.
Nel suo romanzo No One Is Talking About This, la scrittrice e critica Patricia Lockwood articola proprio la confusione tra reale e falso, certezza e dubbio, stupore e delusione che anima la vita online. Riecheggiando il formato breve e frammentario di alcuni suoi testi più noti apparsi su Twitter come poesie, il libro è una sequela di frasi e paragrafi perlopiù slegati tra loro, narrati da un soggetto che oscilla tra pronomi e prospettive diverse che descrive, inventa e infine diventa contenuti e comportamenti tipici dell’online. Quasi citando Trow, la Lockwood scrive: «Era in questo luogo, proprio quando eravamo sul punto di perdere i nostri corpi, che il corpo è diventata la cosa più importante, era in questo luogo di immensa scioglievolezza che è diventato importante sapere se da piccoli chiamavate l’acqua frizzante o gasata (…) e se avevate quel particolare tipo di Tupperware interamente macchiato d’arancione. Venivate ingranditi a livello di pixel, venivate lanciati nello spazio, era la fratellanza del genere umano e per certi versi non eravate mai stati scagliati così lontani gli uni dagli altri. Si zoomava e zoomava sul tepore di quel pixel finché non appariva freddo come la luna». Disturbante ma anche realistico, l’oggetto del romanzo è internet, che progressivamente si assimila a soggetto della narrazione, materializzando perciò letterariamente quel collasso del contesto di cui si faceva bella Terry diventata gif. No One Is Talking About This vocalizza la mimesi con “il portale”, facendolo parlare con una lingua nuova che rivela bellezza e poeticità mentre rappresenta qualcosa di vero. Si trasforma, volendo, in arte.
Non è raro identificarsi in un meme in modo più istantaneo e gratificante di quanto si possa fare descrivendo compiutamente uno stato mentale, soprattutto perché attinge a un bacino collettivo e porta dunque la promessa di una “connessione” migliore.
Naturalmente Patricia Lockwood non è l’unica artista a vocalizzare questa simbiosi. La performer croata Nora Turato, ad esempio, prende spunto sia dal tono confessionale tipo influencer che svela i propri segreti in un post, sia dal registro solenne applicato a eventi triviali come un trailer degli Avengers. Le sue opere sono esibizioni di spoken word e giganteschi murales colorati che infondono una sensazione di familiarità ma anche disagio perché distorcono e sfidano le aspettative legate all’impiego di certi atteggiamenti formali. L’artista Isabella Toledo, principalmente attiva su Instagram, pubblica brevi video in cui si fa “doppiare” da spezzoni più o meno noti di film, interviste, apparizioni televisive. Invece di prestare la sua voce a un’immagine, la si vede indaffarata in attività banali come pettinarsi o piegare il bucato, mentre le sue labbra sono sincronizzate sulle voci di Lauren Bacall o Fran Lebowitz. Rispetto ai lavori di Turato, l’effetto straniante c’è ma vira più sul comico grazie alla nuance camp della serie, che per certi versi ricorda le impersonificazioni di Jordan Firstman. Toledo inverte le gerarchie tra fonte e imitazione sfruttando un formato che sussiste solo online, e crea delle mini opere che assomigliano a dei “meme d’artista”: completamente personali, unici, ma liberi di essere prestati a chiunque desideri usarli per esprimersi.
«Strano—scriveva la Lockwood—come le cose migliori del portale sembrassero appartenere a tutti. Non aveva senso dire È mio a una ragazzina che aveva diligentemente ritagliato la faccia, il nome e l’impronta digitale dalla tua frase – l’adorava, il linguaggio libero e immisurabile che aveva in testa l’aveva pronunciata cento volte quella frase, era sua. Una fetta della tua vita aveva tagliato la corda e si era moltiplicata tra le persone, prima da nessuna parte poi un po’ e infine ovunque e molto. Nessuno e tutti».