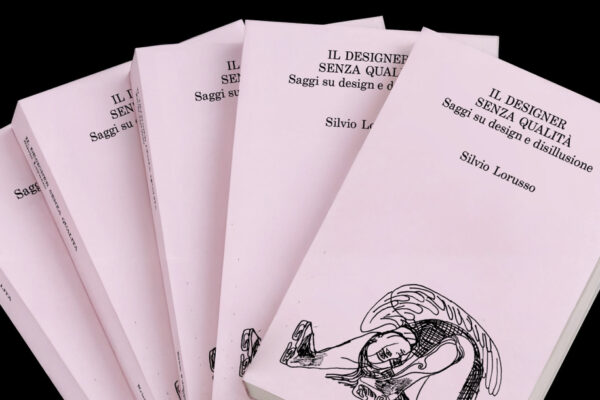Fuggito dalla guerra civile in Costa d’Avorio a soli 14 anni, Mohamed Keita approda a Roma nel 2010 dopo un viaggio durato tre anni attraverso l’Africa e il Mediterraneo. Il suo percorso artistico inizia tra i binari della Stazione Termini, dove trascorre i primi mesi di permanenza in Italia: qui, grazie a una macchina fotografica usa e getta, scopre una vocazione istintiva che trasforma il quotidiano in memoria.
Formatosi presso l’Istituto Rossellini e la scuola Exusphoto, Keita ha consolidato un linguaggio visivo capace di unire etica ed estetica. La sua carriera lo ha portato a esporre in istituzioni prestigiose, dal MACRO di Roma alla sede ONU di New York, fino a Palazzo Querini a Venezia, ricevendo riconoscimenti da maestri del calibro di Josef Koudelka.
SM: Il tuo percorso verso la fotografia non nasce da un’accademia ma dalla possibilità di sperimentare con una macchina fotografica. Il tuo lavoro sembra inseguire la soglia in cui qualcosa accade, in cui lo sguardo si apre. Quando osservi una scena urbana a Roma o a Bamako, come riconosci che quell’immagine merita di essere catturata?
MK: Sì, è vero. Ho iniziato a fotografare nel 2010 quando sono arrivato qui a Roma. Onestamente quando ero piccolo non mi piaceva la fotografia. Prima di partire da casa infatti c’erano due cose che mi sarebbe piaciuto fare da grande, cantare o giocare a calcio. Ero molto legato a queste due cose da ragazzino, ma uscendo fuori ho scoperto un mondo che a casa non conoscevo. Uscendo ho capito l’importanza delle persone, che sia la nostra ma anche quella degli altri. Perciò mi interessa molto raccontare il quotidiano di tutti giorni insieme ai luoghi, perché le persone passano e anche la città è in continua evoluzione. Grazie ad alcuni frammenti fermati con una foto, è possibile riviverla attraverso l’immagine. Per me è un modo di conservare memoria del presente per il futuro.

Per me il rispetto è molto importante.Quando si fotografa un’altra persona, trovare un metodo adatto per rappresentarla come persona lo trovo fondamentale.

SM: Le tue fotografie non cercano di raccontare tutto: anzi, sembrano custodire una parte di mistero, lasciando volutamente in ombra un pezzo della storia. La figura umana appare spesso in transito, mai del tutto esposta. È una qualità rara, che suggerisce un rispetto profondo per ciò che si fotografa e per ciò che non si può pretendere di comprendere del tutto. Se dovessi mostrare una sola tua immagine a qualcuno che non ti conosce, quale sceglieresti e perché?
MK: Se la foto è per me, sceglierei la mia prima foto intitolata J’habite à Termini, non perché è la mia foto più bella, ma per ciò che rappresenta. Per un’altra persona chiederei il suo parere prima di proporre la foto. Per me il rispetto è molto importante. Penso che quella sia la base da dove partire. Quando si fotografa un’altra persona, trovare un metodo adatto per rappresentarla come persona lo trovo fondamentale. Questo a prescindere dalla storia che mi trovo a raccontare, cerco sempre di rispettare la dignità della persona che si offre come soggetto. Penso che il percorso della vita non sia una linea dritta. Anche se sto dietro la macchina fotografica, questo non esclude che un giorno potrei trovarmici davanti. Perciò, quando mi trovo in giro a fotografare sono molto più preso dal processo per arrivare all’immagine che dal risultato stesso.

SM: E, in generale, che cosa vorresti rivelare di un oggetto e che cosa preferiresti che restasse nell’ombra?
MK: Quello che cerco di raccontare è la mia visione, il mio vissuto, la mia presenza, attraverso i luoghi e le persone che l’abitano. Mi piace mettere le persone al centro nella mia fotografia, nei contesti in cui si trovano.

SM: Il viaggio che ti ha portato da Abidjan a Roma non è un semplice capitolo della tua biografia: sembra essere diventato una lente attraverso cui guardi il movimento, la vulnerabilità e la forza delle persone. Eppure, nelle tue foto, non c’è mai compiacimento narrativo né retorica: c’è una distanza giusta, quasi una delicatezza nella scelta dei soggetti e delle situazioni. Secondo te, in che modo alcune ferite o scoperte che tutti ci portiamo dentro determinano il nostro sguardo artistico?
MK: Sì, condivido. Il nostro vissuto influenza il nostro modo di vedere la realtà. Devo dire che questi diversi passaggi della mia vita mi hanno offerto una lente in cui guardare il mondo.
SM: Roma è stata il tuo porto di arrivo: è una città di soglie, di bordi, di zone liminali. Guardando i tuoi lavori dedicati alla città, si ha la sensazione di assistere a un dialogo continuo tra chi arriva e chi resta, tra ciò che accoglie e ciò che respinge. Dal giorno in cui sei arrivato a oggi, come è cambiato il tuo modo di guardare la città?
MK: Il giorno in cui sono arrivato a Roma, la città non la vedevo. Ovviamente perché non la conoscevo. Con il passare del tempo, da quel giorno a oggi, per me è cambiato molto il modo di vedere la città: attraverso i miei amici, le diverse strade attraversate in questi anni e le storie ascoltate sulla città. Tutto questo apre la strada ad un altro modo di guardare.
Molto spesso, quando fotografo stando dietro la fotocamera, cerco di stare al posto del soggetto. Mentalmente questo mi aiuta a essere presente


SM: Molti dei tuoi soggetti vivono o si muovono in periferie, interstizi urbani, comunità non centrali. Fotografarli non è mai un gesto neutro. Nel tuo lavoro si percepisce un equilibrio complesso tra testimonianza e pudore, tra partecipazione e distanza. Come vivi la tensione etica tra rappresentare una realtà e rispettare l’intimità di chi la abita?
MK: Molto spesso, quando fotografo stando dietro la fotocamera, cerco di stare al posto del soggetto. Mentalmente questo mi aiuta a essere presente. Ma, nello stesso tempo, trovare il modo di far sì che la mia presenza non diventi pesante, mi aiuta ad avere la giusta distanza dal soggetto.
SM: È un tema molto complesso che testimonia anche le relazioni di potere e il colonialismo del nostro sguardo. La storia di Kevin Carter che si suicidò, forse per senso di colpa) l’anno successivo alla vittoria del premio Pulitzer nel 1993 per la sua fotografia in Sudan di una bambina denutrita accanto a un avvoltoio. Che cosa è successo secondo te? E Ti è mai capitato di rinunciare a uno scatto o di modificarlo per una forma di rispetto o di necessaria discrezione?
MK: Penso che la storia di Kevin Carter ponga molte domande. Secondo me, la persona che poteva avere la risposta è solamente lui, ma purtroppo non ha avuto la possibilità di rispondere a queste domande. Ho rinunciato ad alcune fotografie, personalmente non ho grande difficoltà a rinunciare allo scatto, faccio gli scatti quando la realtà che ho intorno me lo permette. Penso che sia difficile fare tutte le immagini che ci piacerebbe scattare, a volte scatto solo con gli occhi.

SM: La tua vita sembra attraversata da due idee di porto: Roma come arrivo, Bamako come ritorno, e la Costa d’Avorio come radice profonda, anche quando non la nomini. Le tue fotografie custodiscono spesso questo doppio movimento: andare e restare, appartenere e sospendersi. Come convivono dentro di te questi due paesaggi emotivi?
MK: Sì, avete ragione. Attraverso i miei lavori fotografici porto con me il mio bagaglio di tutti giorni. Questi luoghi cerco di portarli con me. La Costa D’avorio, dove sono nato e cresciuto, Bamako con il legame forte attraverso i ragazzi dello studio KENE, Roma con il legame degli amici, e anche le esperienze vissute durante il viaggio. Le persone che hanno costruito il mio percorso come fotografo, ma anche come persona.