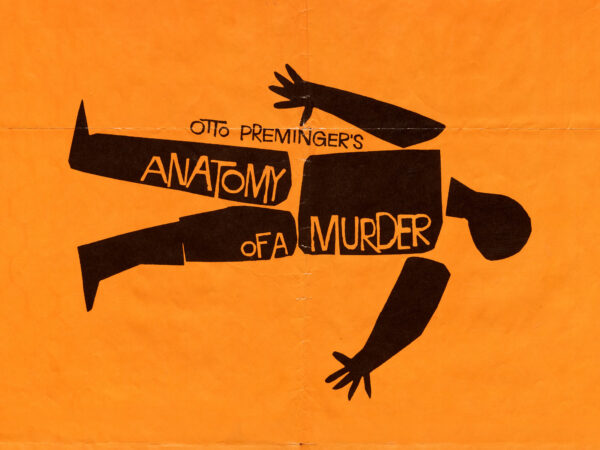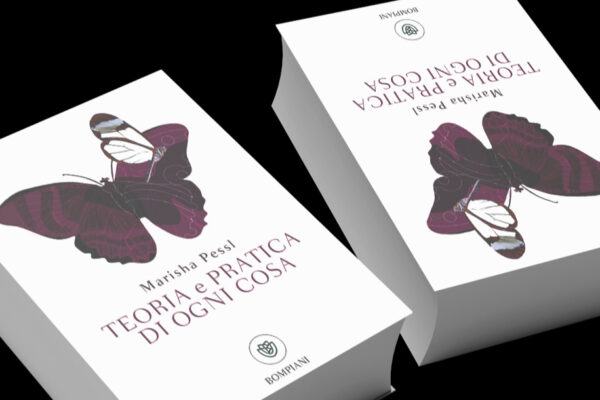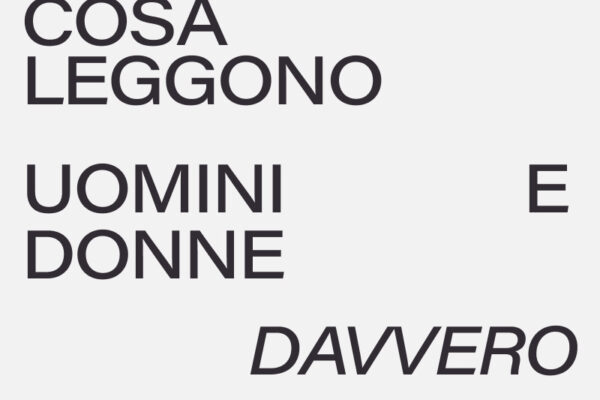“It’s time for cookies and crime”. È l’inizio di un TikTok dell’account di Karen Thi, influencer che ha aperto una rubrica chiamata “Cookies & Crime” dedicata al racconto di cronaca nera accompagnata dai suoi ricettari. Ma non è l’unico video di questo tipo. Scorrendo la propria for you page di TikTok, ci si imbatte spesso in video dove chi parla, con tazza di tè o microfono in mano, si approccia a un pubblico immaginario con un atteggiamento curioso, amichevole e talvolta drammatico. La sua testa fluttuante gira per lo schermo, circondata da foto di vittime, screenshots o registrazioni di CCTV che riportano persone disperse o crimini. Le immagini possono, come già accennato, essere addirittura sostituite da edit di task quotidiane o ricette.
Invece, aprendo la homepage di YouTube, tra i consigliati può capitare un video di canali come quello di Elisa True Crime, che pubblicano video simili ma la cui thumbnail mostra il loro volto serio, affiancato da quello della vittima. Se anche questo non ci soddisfa, o abbiamo voglia di stenderci sul divano per guardare Netflix o Prime, tra i prodotti più popolari ci saranno documentari o adattamenti di storie vere, come l’antologia di Ryan Murphy, Monster, incentrata su killer come Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez. Questi contenuti fanno parte di un immaginario più ampio – se così si può definire – definito true crime.

Con “true crime” si intende un umbrella term che racchiude diversi mezzi di comunicazione (tra cui libri, podcast, film e non solo) incentrati sulla condivisione, principalmente romanzata, di crimini realmente accaduti. Nonostante all’apparenza possa sembrare una sfumatura del reportage, in quanto riporta informazioni reali, il true crime funge più da infotainment, perché l’evento riportato viene ingigantito e romanzato affinché proponga un tono accessibile e soprattutto appetibile per l’audience.
Narrazione sensazionalista
Non c’è da stupirsi che il true crime persista da secoli; si ipotizza dagli albori della stampa tra il XV e il XVI secolo, seppur con diverse sfumature e format. Inizialmente si trattava di pubblicazioni dovute all’enfasi religiosa del tempo, in quanto raccontavano di grandi punizioni divine. Di fatto, già allora presentavano un tono narrativo quasi sensazionalistico. Ma il true crime diventa prodotto di consumo vero e proprio più avanti, grazie ad autori come Truman Capote, che elaboravano accattivanti opere di non-fiction partendo da storie vere.
Un genere che ha saputo reinventarsi restando fedele a una nota sensazionalistica per attrarre un’audience sempre più ampia.
Verso la fine del XX secolo, TV e riviste si arricchivano di programmi, rubriche e contenuti a tema true crime, i quali, seppur avessero alimentato un interesse più estetico, presentavano minori elementi di finzione e restavano più fedeli agli avvenimenti reali su cui si basavano. Da qui, infatti, il true crime prende la nota semi-giornalistica che conosciamo oggi. Si tratta di un genere che ha saputo reinventarsi, tuttavia restando fedele a una nota sensazionalistica per attrarre un’audience sempre più ampia. Non a caso, il genere ha subito una graduale trasformazione con l’avvento del digitale.
Negli ultimi anni, di fatto, il true crime ha preso un’ulteriore piega con la popolarità dello streaming e dei social media, adattandosi alle nuove modalità di consumo e intrattenimento. Come spiega Rachel Monroe, autrice di Savage Appetites: Four True Stories of Women, Crime and Obsession, questi nuovi format digitali fidelizzano i propri spettatori grazie ad una modalità narrativa che permette il binge watching e l’aspetto confortante che quest’ultimo comporta. Tra l’altro, rappresentano un ecosistema facilmente realizzabile, nello specifico a livello economico: non è difficile disorientare il pubblico a livello emotivo e, soprattutto, non costa molto creare un podcast o un account TikTok. Ciò ne alimenta il consumo e il numero di contenuti.

Nel caso dei prodotti seriali, o cinematografici, il true crime porta sullo schermo adattamenti estetizzanti, anche qualora prendano la forma di documentari. Diversamente dai libri di Capote, la storia è all’80% reale: presenta nomi, fatti e luoghi effettivi, ma la narrazione tende ad allontanarsi dalla realtà in maniera da coinvolgere l’audience emotivamente.
Per quanto riguarda, invece, i contenuti social (YouTube, podcast o TikTok – definiti dagli utenti parte di uno spazio digitale più ampio denominato “CrimeTok”), la ricostruzione è abbastanza diversa. È chi parla a doversi avvicinare al pubblico, presentarsi come una persona qualunque ma interessata, incuriosita e che vuole fare giustizia. Il creator si presta a un atteggiamento familiare, appunto amichevole, con slang o modi di fare che rispecchiano quelli dei millennial e della Gen Z. Un po’ come se si fosse al bar insieme o in presenza di qualcuno che riesca a riportare i fatti in maniera accessibile.
Secondo un articolo di Dazed di James Greig, tuttavia, forse non c’è un vero discernimento dei media tradizionali da quelli digitali fai-da-te, visto che l’ossessione per la cronaca nera ha plasmato una narrazione generale, seppur disomogenea, sensazionalistica e spesso inappropriata di conseguenza. Ma cosa comporta questa nuova narrazione per noi stessi e per gli altri?
Tra appartenenza e sfiducia nel mondo
Perché queste narrazioni così macabre, e per di più vere, ci attraggono così tanto? Sicuramente ha a che fare con un aspetto intrinsecamente umano, ovvero quella naturale curiosità di risolvere o capirne di più di un mistero o di ciò che ci accade intorno. Oramai, però, nel caso del true crime spesso può celarsi molto di più.
Ad esempio, ascoltare i casi risolti risulta utile per l’audience, soprattutto quella femminile, a scovare quei piccoli segnali di pericolo nella vita reale. Oppure potremmo essere spinti da un interesse quasi socioantropologico a voler capire perché gli esseri umani si spingano a tanto, e perché la nostra società sia diventata (o sia sempre stata) così oscuramente violenta. Come se questi contenuti venissero inseriti all’interno di una banca dati immaginaria che prova ulteriormente quanto lo Stato e la società non siano dalla parte dei cittadini.
Si forma una bolla dove è l’audience, spinta da una certa vena investigatrice, a tentare di risolvere gli stessi casi.
Di fatto, le nuove generazioni, soprattutto più giovani, provano un senso di sconforto verso il mondo. Sembra impossibile sentirsi pienamente protetti da chi dovrebbe farlo – le autorità, gli amici, la famiglia. Lo sconforto può tradursi nell’ossessione per queste narrazioni, che a loro volta possono portare alla luce mancanze da parte dei nostri connazionali o delle autorità.
Casi come quelli di Carly Gregg, documentato su TikTok, o di Amanda Knox, riportato in noti documentari, mostrano che non ci si può fidare di nessuno. Nel primo caso, è la famiglia a tradirci, mentre nell’altro sono le autorità a essere impreparate. Di conseguenza, si forma una bolla dove è l’audience, spinta da una certa vena investigatrice, a tentare di risolvere gli stessi casi.
Ma così facendo, una gran parte dell’audience ha sviluppato un bisogno quasi naturale di risolvere i casi da sé, con le proprie capacità o con l’aiuto di una comunità di appassionati di true crime. Sotto video online o nei canali subreddit è pieno di utenti che dicono la loro su casi irrisolti o ancora in corso. Ci sono state occasioni in cui l’ossessione per l’investigazione fai-da-te o i documentari hanno effettivamente aiutato la risoluzione di casi reali. Tuttavia, a lungo andare, un feed pieno di crimini, morti e violenze spiegate nei minimi dettagli, porta a una desensibilizzazione non indifferente. Non a caso, molte delle investigazioni amatoriali presentano un tono e un atteggiamento fin troppo distaccato, come se le persone coinvolte non fossero realmente esistite.
Romanticismo e desensibilizzazione della realtà
Come mostrano alcuni recenti studi, il sovraconsumo di true crime porterebbe a una costante sensazione di ipervigilanza, aumento dell’ansia e paura generalizzata che, di conseguenza, danneggia le nostre relazioni con gli altri e il mondo. Si dà forma a una percezione della realtà distorta, ansiogena ma allo stesso tempo disinteressata, perché i pericoli sono ovunque e la violenza è la normalità.
Le vittime diventano proprietà pubblica, soggette all’immaginazione collettiva.
Tra l’altro, questo atteggiamento desensibilizzato e disinteressato porta con sé una sorta di tone deafness verso le persone coinvolte. Quando accadono in tempo reale dei crimini, molti si mettono immediatamente all’opera dicendo la propria, giudicando autonomamente la colpevolezza o innocenza di persone ancora afflitte dal caso. È successo su TikTok, per esempio con gli eventi legati a Carly Gregg o Mr Prada. Entrambi carnefici, i loro casi sono stati prima di tutto accolti con ipotesi e analisi psichiatriche amatoriali. I feed si sono riempiti di screen, video in tribunale, e la condivisione di qualsiasi piccolo dettaglio che potesse essere rivelatorio o destare sospetto. Di conseguenza, per molti ciò risulta inappropriato nei confronti di familiari e gli amici vicini alle vittime. Come raccontato da Rebecca Makkai in I Have Some Questions for You attraverso i suoi personaggi, le vittime diventano “proprietà pubblica, soggette all’immaginazione collettiva”.

Questo atteggiamento talvolta non si ferma ad una bolla social: la desensibilizzazione verso le vittime spesso prende forme più possenti, come nel caso del sopracitato Monsters di Ryan Murphy. Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez seguono un filo narrativo che estetizza e romanticizza i loro casi, distorcendo non solo ciò che concerne i killer ma le vittime coinvolte. Non a caso, tali adattamenti hanno scatenato molte critiche: sono risultati offensivi per una delle vittime di Dahmer, e per i fratelli Menendez, che hanno denunciato il racconto pseudo-incestuoso e diffamatorio nei loro confronti. Una situazione simile si è verificata proprio in Italia a causa della serie incentrata sul caso di Avetrana.
Si tratta di un interesse che non si limita a persone totalmente estranee a noi, ma anche a celebrità con le quali siamo cresciuti o sviluppiamo un rapporto parasociale. Come nel caso della recente morte di Liam Payne dei One Direction, vista non solo come conseguenza di uno star system tossico, ma anche come un’ottima occasione per sviluppare milioni di ipotesi sulla salute mentale e la vita privata del cantante. Oppure quello del rapper Diddy e dei suoi “party”, nel tentativo di scovare chiunque ne fosse coinvolto. Quest’ultimo caso, in particolare, ha spinto diverse persone a speculare sulle morti di Aaliyah, Tupac e Michael Jackson collegandole all’impero di Diddy.
Ciò che spicca nell’ampio mondo del true crime è quindi un’ossessione per la giustizia e la verità, scaturita da un disincanto con il mondo e le autorità. Un’ossessione che va a braccetto, sfortunatamente, con l’esibizionismo morale o la desensibilizzazione scaturiti dall’ingordigia di contenuti del mondo digitale, alla ricerca di guadagno o di validazione online.
Si tratta di un interesse non per forza inedito, ma in linea con le trasformazioni contemporanee, ovvero uno scenario di forte paranoia verso un’ipotetica assenza di futuro o persone, luoghi e istituzioni a cui aggrapparsi. Il true crime quindi può sì servire da manuale di autodifesa, ma per prima cosa è bene ricordare che si sviluppa a partire da una necessità morbosa dell’essere umano e di una generazione, di trovare un senso alle ingiustizie a cui assistiamo quotidianamente.