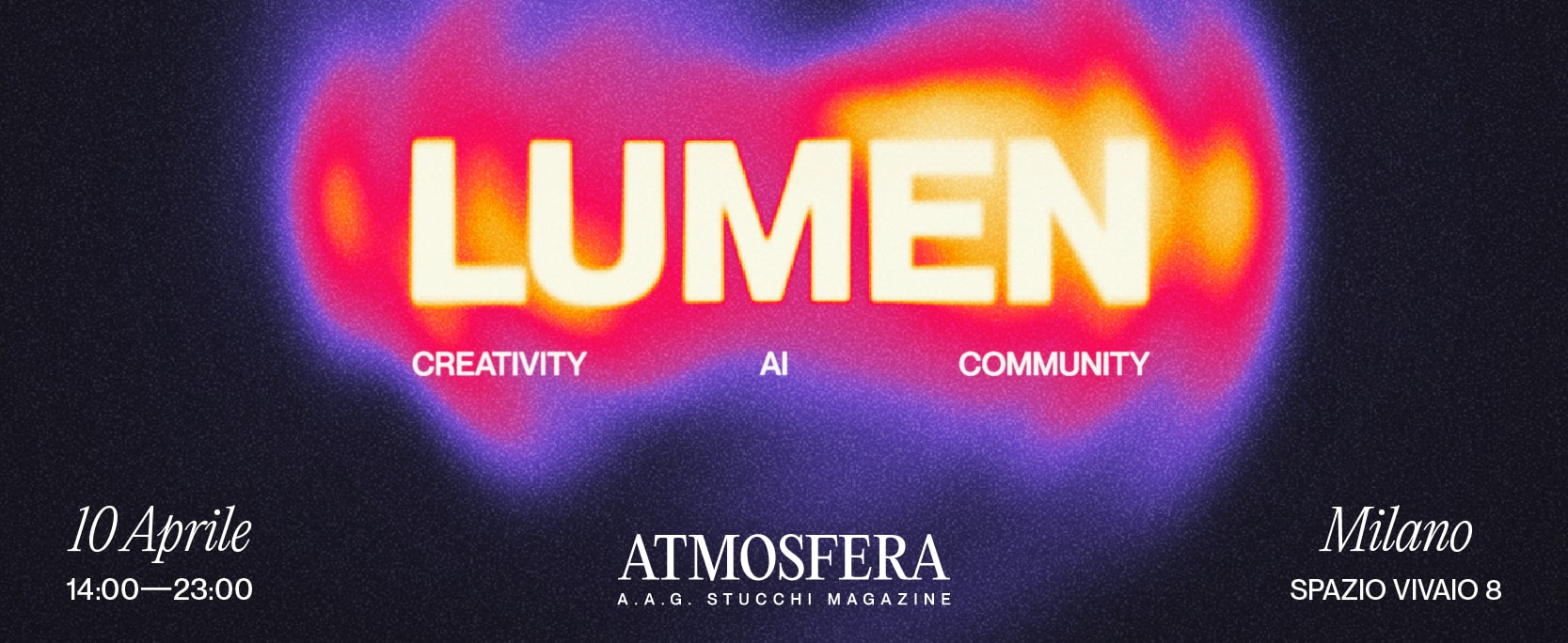La disoccupazione è una questione sociale oltre che un fenomeno economico”, ha sentenziato lo scorso aprile il Beijing News, quotidiano di Pechino del Partito comunista cinese. Da settimane giornali, siti di approfondimento e pagine social partecipano a una discussione collettiva su una questione piuttosto critica: un giovane su cinque, in Cina, non studia e non lavora.
È quanto emerge dai dati condivisi dall’Ufficio nazionale di statistica, che dal 2018 pubblica mensilmente i risultati di sondaggi sull’occupazione nelle aree urbane. Il tasso di disoccupazione giovanile cresce da circa dieci anni. Il picco di quasi venti punti percentuali registrato lo scorso anno è stato superato già ad aprile del 2023. La curva continua a salire e i dati pubblicati di recente indicano che a giugno si è toccato il 21.3%.
Milioni di giovani che non fanno nulla in termini produttivi e di crescita personale sono una presenza sgradita per il Partito comunista cinese sin dai primi anni Duemila. All’epoca se ne parla utilizzando un acronimo nato qualche anno prima nel Regno Unito: “Neet, Neither in Employment, Education or Training”. Il Libro Blu dello Sviluppo Giovanile di Guangzhou, una delle maggiori metropoli della Cina meridionale, riporta che nel 2010 circa il 35% dei giovani dell’area urbana è a rischio metamorfosi in Neet. In una città che in quel periodo conta quasi 13 milioni di abitanti centinaia di migliaia di persone non partecipano agli sforzi collettivi che in quell’anno permettono a Pechino di superare Tokyo e guadagnarsi il posto di seconda potenza economica mondiale.
Un dilemma piccolo?
Il tasso di disoccupazione giovanile di quell’anno mostra come il problema si estenda a tutta la nazione. Nel 2010 per la prima volta la percentuale supera cifra doppia. In quei mesi il South China Morning Post, noto giornale in inglese di Hong Kong, riporta la storia di Wen Jia, 24enne che dopo aver fallito l’esame di funzionario pubblico inizia a lavorare per un’azienda privata. Un’esperienza durata pochi mesi: il licenziamento le sembra l’unica scelta visto il magro salario che non supera i 1200 yuan mensili (neanche 160 euro).
Milioni di giovani che non fanno nulla in termini produttivi e di crescita personale sono una presenza sgradita per il Partito comunista cinese sin dai primi anni Duemila.
Le vicissitudini di Wen Jia rivelano le difficoltà di una intera generazione, che negli anni non hanno fatto altro che acuirsi. Lo spiega bene David Ownby, direttore del progetto web Reading The China Dream e docente all’Università di Montréal: nell’introduzione a un recente saggio sul tema tradotto dal cinese, Ownby evidenzia le parti più rilevanti di una lunga conversazione avuta con due giovani trentenni della Repubblica popolare impiegati nel settore culturale. Uno dei due, con fare smarrito, gli dice che nei lunghi anni passati a studiare “niente mi ha preparato ad affrontare tutto questo”.
Non sarebbe esagerato affermare che in Cina millennials e Gen Z sono cresciuti a pressioni sociali. Tutoring e corsi privati rincorrono i giovani fin dalla tenera età. L’ansia sociale si riversa nel contesto familiare: i genitori chiedono ai figli di eccellere sin dai primi anni e puntare dritti e con inattaccabile laboriosità al temuto gaokao (高考, letteralmente “grande esame”, che quest’anno ha registrato un record di quasi 13 milioni di partecipanti), in cui confluiscono quello di maturità e quello di ammissione per l’università. E ancora, entrare in una buona università, trovare un ottimo lavoro, assicurarsi un buono stipendio, mettere su famiglia e così via.
Temi ampiamente discussi in A Little Dilemma (Xiao Shede, 小舍得), una popolare serie tv rilasciata nel 2021 che racconta le scelte prese dai genitori per preparare i figli alla feroce competizione scolastica. Se l’obiettivo pare esser stato quello di raccontare i tentativi di raggiungere un equilibrio tra la felicità della prole e il raggiungimento di ottimi risultati scolastici, molti utenti hanno scherzato sul web riconoscendone il chiaro “valore contraccettivo” verso chi deve mettere su famiglia. “È meglio dei preservativi”, si legge in un commento sulla piattaforma di microblogging Weibo. Secondo molti parlare in maniera così critica delle pressioni familiari significa scoraggiare i giovani a fare figli. Proprio il contrario delle misure intraprese da Pechino per invertire la rotta demografica in calo.
Temi ampiamente discussi in A Little Dilemma (Xiao Shede, 小舍得), una popolare serie tv rilasciata nel 2021 che racconta le scelte prese dai genitori per preparare i figli alla feroce competizione scolastica. Molti utenti hanno scherzato sul web riconoscendone il chiaro “valore contraccettivo” verso chi deve mettere su famiglia.
Le risposte dei giovani sui vari social si accodano a una discussione che ha preso piede da anni su Internet. Al centro, un generale sentimento di insofferenza nei confronti dell’etica del lavoro e di un percorso già battuto che viene elevato da istituzioni e società come l’unica via da seguire. E perfino, con molta preoccupazione del Partito, dell’idea stessa di procreare. Le medesime questioni che in misura più o meno analoga interessano il dibattito generazionale in molti paesi del mondo. Ma che nella Repubblica popolare assumono un ruolo ancor più cruciale, in quanto minano alla base il contesto familiare, fondamento della società, e colpiscono direttamente l’immagine che il paese vuole offrire al mondo: una Cina di persone laboriose, ambiziose, capaci di mobilitarsi per il bene della nazione.
C’è il rischio, avvertono analisti e osservatori, che si incrini il cosiddetto “patto sociale”, l’accordo implicito tra Partito e cittadini che all’indomani del massacro di piazza Tian’anmen del 1989 lega a doppio filo benessere economico e lealtà politica. Il miglioramento delle condizioni di vita in cambio di un certo grado di limitazione della libertà di espressione. Ma se la Repubblica popolare ha salutato il nuovo millennio forte di una crescita a ritmi record grazie al modello economico basato sulle esportazioni, da circa un decennio è stato necessario ridimensionarsi. Nel 2013 Pechino annuncia come definitivamente conclusa la fase caratterizzata dal “binomio investimenti-export”, dando il benvenuto a quella di “consumi e servizi”.
Già prima del Covid, tuttavia, si guarda con timore alla crescente erosione dei portafogli, da imputare al calo del reddito delle famiglie e riconducibile a una serie di fattori in cui trovano spazio anche le allora nascenti tensioni con Washington e la cosiddetta “guerra dei dazi” avviata da Donald Trump. Poi, la crisi pandemica assesta il colpo finale. Il paese chiude il 2022 con una crescita del Pil ben al di sotto delle previsione di inizio anno. A incassare il colpo sono per lo più entità aziendali di piccole o medie dimensioni. Da uno studio della prestigiosa Tsinghua University, nella capitale, emerge che nella prima metà dello scorso anno circa 460 mila aziende hanno cessato le attività, per un totale di oltre 3 milioni di individui e famiglie coinvolti. I numeri del 2021 sono tre volte maggiori.
Lo spazio di azione per i cittadini si è progressivamente eroso con la salita al potere di Xi Jinping, grazie anche a una pronta reazione degli organi censori del Partito contro contenuti web considerati sgradevoli e “non allineati”.
Dalle strategie nazionali alla scelta dei singoli
In questo scenario alcuni media occidentali non hanno mancato di fornire analisi quantomeno esagerate sul significato dei movimenti di opinione sul web nati tra i giovani (a cui dedicheremo un prossimo approfondimento) allo scopo di dare sfogo a una comune condizione di precarietà. A volte il paese è stato dipinto come una pentola a pressione, pronto a scoppiare come conseguenza della ferrea strategia di contenimento del Covid e delle magre prestazioni economiche, e a riversare i propri intenti di ribellione contro il capo supremo, Xi Jinping. Una interpretazione che ha pensato di aver trovato conferma nelle “proteste dei fogli bianchi” di fine 2022, che hanno visto manifestazioni circoscritte ma diffuse in molte città cinesi. Giovani e meno giovani non hanno solo criticato la strategia Zero Covid (o meglio, l’arbitrarietà della sua applicazione da parte delle autorità locali), ma hanno anche indirizzato critiche contro Xi e il Partito. Un fatto inedito, certo. Ma non sarebbe corretto identificare queste istanze con il volere e le opinioni dell’intera società civile. Il sistema politico gode ancora di un consenso diffuso. L’interesse verso questioni di carattere politico, inoltre, è circoscritto e lo spazio di azione per i cittadini si è progressivamente eroso con la salita al potere di Xi Jinping, grazie anche a una pronta reazione degli organi censori del Partito contro contenuti web considerati sgradevoli e “non allineati”.
La questione giovanile racconta piuttosto di un comune senso di frustrazione che si configura come la diretta conseguenza di un fatto indiscusso: la generazione più istruita della storia della Cina è anche la più disoccupata, e dopo tanti sacrifici manca il premio promesso.
A determinare uno scenario così desolante è intervenuta una sfortunata concomitanza di fattori. Alla crisi pandemica si è aggiunta la stretta di Pechino sui grandi colossi attivi nei settori dell’intrattenimento, dell’e-commerce, del tutoring scolastico e della finanza online. Nel periodo pre-Covid i dipendenti delle società attive nell’economia delle piattaforme sperimentano già un deterioramento delle condizioni interne. Una parabola che vede i colossi tech prima come motore dell’innovazione e creatori prediletti di posti di lavoro, poi come entità cresciute in maniera disordinata e portatrici di una cultura degli straordinari che bisognava “ridimensionare” in fretta.
Dal 2020 le Big Tech diventano bersaglio di multe e restrizioni normative inflitte dagli organi di regolamentazione di Pechino. Un processo che conduce a licenziamenti diffusi in molti dipartimenti aziendali. Lo dimostra Alibaba, multinazionale fondata da Jack Ma (tycoon molto noto, poi divenuto filantropo, e per un certo periodo inviso al Partito), che nel 2022 riduce la forza lavoro di circa 19 mila persone al fine di adattarsi a uno scenario economico traballante e migliorare l’efficienza. I dati riportano che da dicembre 2022 a marzo 2023 si sia registrato un ulteriore calo di 4500 lavoratori. Non è raro imbattersi in articoli che riportano l’attuale clima di preoccupazione sulle sorti dell’azienda (e su quelle di altre società del tech), malgrado Alibaba abbia smentito e si sia affrettata a condividere la notizia di un piano di assunzione di 15 mila persone entro la fine dell’anno.
La generazione più istruita della storia della Cina è anche la più disoccupata, e dopo tanti sacrifici manca il premio promesso.
Anche il governo rilascia dichiarazioni tranquillizzanti. In risposta ai dati allarmanti il portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica Fu Linghui ha ripetuto ciò che ha detto lo scorso anno, vale a dire che il tasso di disoccupazione cresce di norma nelle stagione estiva, quando si concentrano le lauree – vale a dire che la percentuale potrebbe ancora crescere. In occasione del record del 2022 ha però aggiunto che gli alti numeri sono da ricondurre al fatto che i giovani in cerca di lavoro trovano inadatte le offerte sul mercato. Trasferire le responsabilità dalle strategie nazionali alla scelta dei singoli è stato anche l’approccio del deputato dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhang Xinghai, anche proprietario dell’azienda automobilistica Xiaokang Group. A marzo 2022, a poche ore dall’inizio delle lianghui, le due sessioni annuali delle maggiori istituzioni politiche del paese, Zhang si è lamentato di come sempre meno giovani siano disposti a lavorare in fabbrica e siano invece propensi ai nuovi impieghi nell’e-commerce, nel live streaming e nella consegna espressa.
L’economia delle piattaforme
Se la penuria di manodopera nelle fabbriche è un grattacapo reale, i lavori da colletto bianco scarseggiano. Il settore tech resta attrattivo malgrado la crisi. Un sondaggio condotto lo scorso anno dalla piattaforma di reclutamento online Zhaopin mostra che circa il 30% degli studenti che si avvicina alla laurea desidera comunque lavorare nel settore di internet. Ma gli intenti di ristrutturazione si traducono in una inquietudine che serpeggia in vari dipartimenti delle maggiori società del paese.
Molti decidono di continuare a studiare per ritardare il momento in cui dovranno mettere piede nel calderone delle fiere del lavoro e dei colloqui infiniti.
C’è chi si chiede, come l’autore di un articolo pubblicato dal motore di ricerca Baidu, se un tasso così alto di disoccupazione possa “fornire un sostegno realistico alla teoria dell’inutilità della scuola, così dilagante nella società”. Al contrario, molti decidono di continuare a studiare per ritardare il momento in cui dovranno mettere piede nel calderone delle fiere del lavoro e dei colloqui infiniti. Scegliere di affidarsi a scuole di specializzazione e master post-laurea è anche il consiglio di alcuni esperti, utile, dicono, ad “alleviare l’attuale pressione sul mercato occupazionale”. Ma il mercato cinese soffre proprio la iper professionalizzazione. Nel 2020 i laureati non raggiungono i 9 milioni, per il 2023 si dovrebbe toccare la cifra totale di 11,6 milioni di persone. E i lavori qualificati non bastano per tutti.
Alla feroce competizione alcuni rispondono abbassando le aspettative e trovando soddisfazione in “obiettivi di carriera meno ambiziosi”, come si legge in un lungo rapporto della ong del lavoro di Hong Kong China Labour Bulletin. Un netto sì, quindi, a impieghi umili e considerati un tempo piuttosto indesiderati, come le guardie di sicurezza, professioni legate all’economia di cura, gestori di piccole attività, anche ambulanti. Una tendenza che smentisce le accuse di chi dall’alto punta il dito verso l’incapacità delle nuove generazioni di adattarsi.
Ad oggi, infatti, pare che uno dei problemi principali sia proprio la “sottoccupazione”. Da uno studio approfondito sul tema condotto da Lu Yao, della Columbia University, e da Li Xiaogang, della Xi’an Jiaotong University, emerge che almeno un quarto dei laureati del paese accetta posizioni non commisurate alla loro formazione. Lavori poco qualificati, mal pagati e part-time. Caratteristiche proprie di un certo tipo di impieghi da economia delle piattaforme, quelli a cui ci si riferisce con la parola “gig” e che a inizio pandemia hanno ricevuto un elogio pubblico dall’allora premier Li Keqiang in quanto capaci di contrastare lo spettro della disoccupazione (non solo giovanile).
Ma con la crescita del numero di disoccupati tra i giovani, e con le chiare conseguenze sociali che questo comporta, serve smussare la retorica. Il titolo di un articolo del quotidiano in lingua inglese China Daily non lascia spazio a dubbi e abbraccia una narrazione più benevola: “Gli studenti cercano la stabilità nel lavoro, non la flessibilità”. Secondo alcuni osservatori, infatti, il settore statale è in pieno revival: non opportunità considerate come prima adatte solo a persone carenti di talento e ambizione, ma luogo sicuro per rifuggire la precarietà dilagante.
Con la crescita del numero di disoccupati tra i giovani, e con le chiare conseguenze sociali che questo comporta, serve smussare la retorica.
Più che una corrente compatta e univoca, la questione giovanile in Cina si manifesta come un groviglio di tendenze diverse che mutano anche a seconda della provenienza geografica e del contesto sociale di appartenenza degli interessati. In più occasioni Pechino ha puntato il dito contro una presunta svogliatezza collettiva giovanile nei confronti del lavoro, più che prendersi carico delle conseguenze delle strategie nazionali. Una deresponsabilizzazione istituzionale che non fa altro che rafforzare la visione disillusa di molti millennial e gen z: il comune senso di frustrazione e la preoccupazione per il futuro sono legati a doppio filo all’indebolimento della fiducia delle nuove generazioni nei confronti di un governo, come scrive Ownby, considerato da sempre come “competente”. E che invece ad oggi non è capace di far incontrare domanda e offerta nel mercato del lavoro.