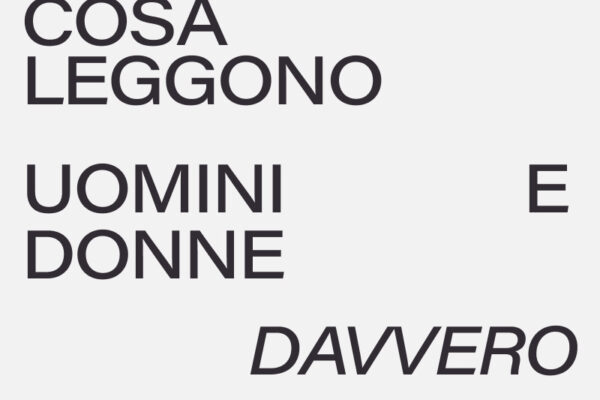Possono i social essere un modo per promuovere la rappresentanza dei popoli indigeni? Su TikTok diversi attivisti influencer nativi denunciano secoli di soprusi politici, sociali e religiosi perpetuati nei confronti delle proprie comunità, sfruttando i social per far rivivere usi e costumi tradizionali della propria gente e creare fronte comune contro le discriminazioni ancora attuali. In prevalenza si tratta di giovani adulti millennial e gen z che in un mondo digitalizzato cercano di ritrovare un’identità ancestrale che i bianchi hanno cercato di sopprimere e diluire nella propria sfera.
Per questi giovani attivisti TikTok è uno strumento di decolonizzazione dell’immaginario occidentale. Tra gli hashtag più seguiti sulla piattaforma, #nativetiktok da 6,2 miliardi di visualizzazioni e #indigenoustiktok da 1,3 miliardi sono diventate delle macroculture e sfere temporali a sé stanti. Scorrendo i video troviamo influencer vestiti in abiti tradizionali che sfoggiano tatuaggi sacri e riscoprono antiche usanze, i classici trend della piattaforma vengono riadattati per celebrare le storie indigene, sfide e danze sono adoperati per veicolare messaggi collettivi e rafforzare il senso di comunità, portando spesso a inside jokes che sono pensati per comunicare esperienze coglibili solo tra gli stessi appartenenti.
La creazione di contenuti viene adoperata in guisa di un atto politico e di ricerca interiore, porta a coniare freneticamente nuovi riferimenti sociali che tengano conto di identità sfumate. È il caso di chi prova a definirsi un nativo bianco, cioè figli di coppie miste che non hanno ereditato il colore della pelle o i tratti fisiognomici dei loro antenati indigeni, e perciò spesso vengono scambiati per bianchi, portando psicologicamente a un duplice senso di alienazione. Molti sono consapevoli che la loro audience è formata da persone non indigene, perciò dedicano la propria attività online a farsi portavoce per educare il pubblico sulle proprie tradizioni: raccontano storie e miti, insegnano la loro lingua e cultura spingendo spesso a un atteggiamento di sincera ricerca, parlano della loro terra e del rapporto con i non umani sollevando consapevolezza sulla crisi climatica, diffondono tecniche pratiche o riti trasmessi da generazioni, inscenano teatrini facendo il verso all’estetica new age o alle narrazioni hollywoodiane.
Numerosi video sono dedicati a decostruire la storia occidentale attraverso la critica dell’immaginario pop. Uno degli obiettivi principali è la narrazione Disney, dove ad esempio la Pocahontas sessualizzata e romanticizzata dell’omonimo film viene ricondotta alla Pocahontas storica, la giovane adolescente powhatan morta per complicazioni respiratorie dovute all’aria inquinata di Londra.
I discendenti indigeni cercano di coniugare uno stile di vita moderno con l’abbattimento quotidiano di stereotipi legati all’etnia, di cui molti sono vittime soprattutto a causa di una mancata educazione ai popoli indigeni, ghettizzazione sociale e classismo sul mercato del lavoro, o anche dell’ascesa di governi conservatori di destra.
Tra gli hashtag più seguiti sulla piattaforma, #nativetiktok da 6,2 miliardi di visualizzazioni e #indigenoustiktok da 1,3 miliardi sono diventate delle macroculture e sfere temporali a sé.
La rabbia e l’ironia diventano un forte catalizzatore per rompere l’immagine tipica del buon selvaggio di Rousseau, depositario di sapienze autentiche, distaccato dai problemi mondani e impegnato in qualsiasi momento a compiere gesti sacri, onorare gli spiriti e perseguire una vita pura.
Ciò che emerge invece è un quadro dove i giovani indigeni abitano una zona grigia in cui cercano di unire il meglio dei due mondi, alla ricerca di un’armonia tra il poter praticare le loro vie, riprendere possesso delle proprie terre con l’abbattimento delle riserve, e il vivere la propria vita nella società globalizzata.
La battaglia si gioca anche sulla terminologia: parole come “nativo” e “indigeno” vengono a un tempo rifiutate nella pretesa colonialista di uniformare i non bianchi sotto un’unica etichetta (a cui si aggiungono anche espressioni considerate dispregiative quali “indiano d’america”, “eschimese” o “ispanico”), e riscattate in virtù di un’opposizione alla società moderna. In qualsiasi caso gli attivisti spingono per il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, l’integrazione tra identità culturali, ripensamento dell’ecologia in chiave radicale, ricordando che le popolazioni indigene sono i maggiori protettori della biodiversità. Lo sfruttamento delle risorse locali, la morsa del capitalismo, il ricordo delle vittime del colonialismo, il razzismo e la cristianizzazione forzata, l’appropriazione culturale, sono le aree verso cui la critica social si concentra di più
Tra gli hashtag, sui versi della soundtrack Quechua 101 Land Back Please di Bobby Sanchez – una delle tracce eretta a inno tiktokiano della decolonizzazione digitale – si possono raggiungere le personalità più influenti. James Jones è notoriouscree, 3.7 milioni di follower e 88.9 milioni di like. L’influencer ha iniziato la sua carriera come ballerino hiphop, ma successivamente ha integrato nella danza gli elementi tipici della cultura Cree. Dopo essere esploso durante la pandemia, ha cominciato a dedicare i suoi video alla causa indigena, indossando sempre più vesti e monili tradizionali. La sua espressione artistica si è così spostata verso la riscoperta delle danze powwow, riprese dall’omonima cerimonia di raduno dei popoli nordamericani in cui ciascuna tribù celebra le proprie radici con danze, canti e vesti tipiche. In uno dei suoi video da 9,6 milioni di play, Jones ricorda che «Ci fu un tempo in cui non ci era permesso danzare o praticare la nostra cultura», riferendosi alle oppressioni durante il periodo delle guerre indiane, perciò «danzo per coloro che non poterono».
Uno dei suoi video più visualizzati da 5,7 milioni recita «Non siamo indiani e non siamo nativoamericani. Siamo più antichi di questi concetti. Noi siamo il popolo, noi siamo gli esseri umani», una delle frasi iconiche di John Trudell, poeta, autore, musicista e attivista di ascendenza Santee Dakota, famoso per aver combattuto nell’ambito della controcultura americana a favore dei diritti indigeni.
Angella Summer Namubiru è esplosa su TikTok con 5.2 milioni di follower, più di 130 milioni di visualizzazioni e like complessivi, postando video della sua vita quotidiana nel villaggio dove abita in Uganda, circondata dai bambini.
Fin dal primo colpo d’occhio, Namubiru sfoggia una bellezza iconica che lei stessa definisce raggiante. La maggior parte dei suoi video la ritraggono in scene bucoliche a contatto diretto con la sua terra, tra gli alberi o sul mare, le grandi foglie di platano usate come maschere per gioco, fiori messi tra i capelli, mentre sbuccia la verdura o si gode alcuni frutti locali come il giaco, il matoke, l’avocado e lo yam.
Originaria dell’Uganda, nell’Africa orientale, modella, artista e content creator di professione, Namubiru è diventata virale a causa di un commento razzista che le è stato rivolto, «Odio il colore della sua pelle», a cui risponde semplicemente con un sorriso. In un altro video un altro commento le chiede «Momento, momento, momento, hai il wifi?», a cui replica con ironia dicendo «No, ma abbiamo questi» mostrando un albero che ha in mano, e chiedendo alla fine «Cos’è il wifi?». Namubiru offre uno sguardo diretto dell’Africa che rompe l’immaginario coloniale di un unico continente-blocco, ancora troppo presente in occidente, per mostrare invece le vallate verdeggianti delle cascate Ssezibwa. In un altro video, uno dei primi a riscuotere successo, un commento urla di non sprecare l’acqua mentre la modella si riprende inginocchiata vicino una fonte naturale. Altri commenti riguardano la presenza di cellulari, i bagni, o accusano Namubiru di usare il green screen. A tutto ciò lei replica con pacatezza, fungendo da esploratrice di un lato dell’Africa che difficilmente viene mostrato dai media.
Shina Novalinga, conosciuta come Shina Nova, è una cantante e attivista di ascendenza Inuk, nel Quebec. Il suo impatto come personalità artistica le ha già guadagnato da giovanissima una pagina Wikipedia. Con 4 milioni di follower e 145 milioni di like, il canale TikTok di Nova è tutto dedicato alla causa indigena, dove si è distinta per aver postato nel marzo 2020 il suo primo video in cui esibisce il tradizionale canto gutturale Inuit, il katajjaq, assieme alla madre Caroline Novalinga.
Il canto Inuit è un’arte femminile trasmessa di madre in figlia, viene cantato dalle donne in guisa di un gioco vocale mentre gli uomini sono a caccia. Prevede una ritmia totale tra due donne posizionate faccia a faccia, emettendo suoni puri o anche cantando parole ispirate sul momento. È stata Caroline a trasmetterlo a Shina dopo averlo ricevuto a sua volta. Uno dei loro video più popolari ha 26 milioni di visualizzazioni e ritrae le donne cantare assieme, ritmando all’unisono la gola, la pancia e il diaframma.
Il katajjaq, come molte delle pratiche indigene, venne bollato dai missionari cristiani come arte satanica e proibito già all’inizio del Novecento, ma il legame tra le due donne restaura anni di soprusi coloniali e monoteisti che hanno quasi portato il canto all’estinzione. Shina e Caroline sfruttano la loro battaglia per ricordare allo stesso tempo le donne indigene ancora vittime di discriminazioni e violenze da parte del governo canadese.
In uno dei video principali da 41,3 milioni di visualizzazioni, Shina si fa riprendere mentre le vengono tatuati in volto, assieme alla madre, i tradizionali tatuaggi Inuit, disegni iniziatici dal profondo valore mitico, perché riprendono le parti del corpo dove la dea del mare Sedna venne smembrata dopo essere stata buttata in mare dal padre collerico. Il valore mitico, fondamentale, si accompagna alla maturità, il coraggio e il passaggio a una nuova età della vita, a momenti particolarmente significativi o l’appartenenza a una certa famiglia. Ovviamente anche in questo caso l’occhio del colonizzatore urla allo scandalo: i commenti allibiti lamentano che il tatuaggio abbia rovinato il viso immacolato delle due donne, rompendo la proiezione di una presunta purezza metafisica sulla pelle dell’indigeno feticizzato.
Infine Lance Jay Tsosie è modern warrior del popolo Diné, 2.6 milioni di follower e 92 milioni di like. Cresciuto nella riserva Navajo, tra gli attivisti indigeni è tra quelli sicuramente più serrati in un botta e risposta costante contro video razzisti e omofobi, criticando regolarmente nei suoi video l’appropriazione culturale di motivi nativi da parte degli utenti.
Il suo profilo è terreno di scontro per i suprematisti bianchi americani, a cui risponde con la frase catch da lui coniata «Hey, colonizer!», divenuta poi l’hashtag #heycolonizer da 423 milioni di visualizzazioni. Tsosie si batte in particolare contro la disinformazione, le discriminazioni di genere e gli stereotipi culturali, ma in alcuni casi sfocia in una prospettiva falsata che assolutizza il ruolo indigeno nei confronti della storia coloniale.
In un suo video da 2.9 milioni di like risponde al video di un altro utente completamente privo di connotazioni politiche, dicendo «Hey colonizzatore, vi abbiamo insegnato a lavarvi, vi abbiamo insegnato a coltivare, vi abbiamo insegnato a cacciare, dobbiamo insegnarvi anche come mangiare?». Tsosie mostra come l’estremizzazione della battaglia possa creare una risposta falsata per sfociare in un’evidente esagerazione provocatoria. In uno dei suoi video più noti oltre il milione, suggerisce ad esempio di ripensare una delle nemiche di Batman, Poison Ivy, figura di ninfa dai capelli rossi, con fattezze indigene, dato che il personaggio è una protettrice del mondo naturale.
I modelli su cui vengono strutturati gli spazi online e gli algoritmi sono condizionati dalla cultura di riferimento e dalla visione del mondo di chi li programma. Un fenomeno che rientra nell’ambito del digital colonialism, cioè l’uso del potere da parte dei grandi colossi digitali per appropriarsi di spazi fisici, virtuali, culturali ed economici di nazioni e popoli digitalmente più deboli. Tra i colossi americani e cinesi, il colonialismo ha solo cambiato faccia, diventando molto più subdolo perché passa attraverso l’omologazione dei contenuti online, i quali devono rispecchiare i valori della cultura sviluppatrice per guadagnare visibilità.
La creazione di contenuti viene adoperata in guisa di un atto politico e di ricerca interiore, porta a coniare freneticamente nuovi riferimenti sociali che tengano conto di identità sfumate.
Di fatto si riduce e spettacolarizza ulteriormente l’immagine dell’indigeno con l’illusione di ridefinirla, portando gli hashtag ad agire da “riserve digitali” di contenuti, dove i costumi tradizionali rischiano di assumere le sembianze di cosplay improvvisati. I social rompono l’icona dell’indigeno sperduto nella foresta, ma non è tutto oro ciò che luccica. La visibilità delle minoranze genera un cortocircuito e obbliga a un adattamento al canone estetico e morale occidentale, preservando lo sguardo bianco.
Inoltre le nuove generazioni riscoprono le proprie origini passando attraverso una cesellazione continua dell’immaginario pop con cui sono cresciuti, ma anche qui spesso la trappola è di proiettare riferimenti pop sul modo in cui si immagina l’antichità storica o di voler adattare la propria presenza nelle rappresentazioni dei cinecomics.
Da un lato ciò può aiutare a preservare o riscoprire antiche usanze, ma è anche vero che c’è sempre il rischio di diluire le tradizioni nella sfera dei trend online. Bisogna anche segnalare che l’etichetta di indigeno online viene più facilmente riscattata dai popoli americani rispetto al resto del mondo, di gran lunga meno presente sulla sfera social. Così allora ancora una volta l’illusione prospettica è di considerare universalmente indigeni solo i nativi che appartengono a un solo emisfero del globo.