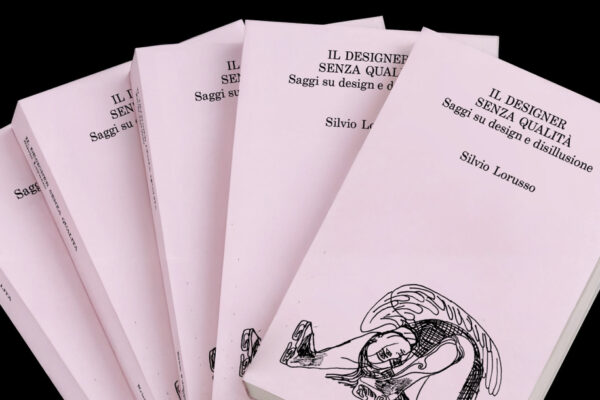CA: Hey Joe non è il primo film in cui lavori insieme a Claudio Giovannesi, avete un rapporto ormai consolidato.
DC: Sì, davvero più che consolidato. Ho avuto la possibilità di fare “la sua opera prima”, come dice lui, che è Alì ha gli occhi azzurri, anche se non è la prima in assoluto perché aveva già realizzato un lavoro con il Centro Sperimentale. Lui però reputa Alì ha gli occhi azzurri l’inizio del suo modo di fare cinema. Mi venne a trovare a Siracusa, io abitavo lì in quegli anni con la mia compagna e c’era il desiderio di lavorare insieme. Da quel momento in poi abbiamo fatto insieme tutti gli altri lavori: Fiore, La paranza dei bambini, fino ad arrivare a Hey Joe.
CA: Qual è la caratteristica più importante di un rapporto funzionale tra regista e direttore della fotografia, e tra voi due in particolare?
DC:
Nel nostro caso è qualcosa di molto piacevole: ci rifacciamo alla cinefilia, che ci accomuna e aiuta. Lui arriva da Fuori Orario e ha una grande cultura cinematografica, anche sul vecchio cinema, cosa che ci permette di confrontarci sul modo di raccontare le cose secondo gli stili della vecchia scuola. Lui, poi, ha moltissimi riferimenti del cinema contemporaneo, dai piani sequenza alla relazione coi personaggi. Per la fotografia ha anche molti riferimenti al vecchio cinema. Il nostro rapporto inizia da un ricordo di Claudio: quando lavoravo con Franco Maresco mandavamo le clip a blob, Claudio faceva parte del gruppo di Enrico Ghezzi e vedeva le nostre cose, mi ha conosciuto così.
Una caratteristica della nostra collaborazione è l’importanza che diamo alla storia in sé. Poi da un film all’altro cambia sempre un aspetto, che è quello della scrittura visiva. Io mi definisco come “un servitore dell’immaginario altrui”, lo dico sempre. Lui è molto esigente, un’esigenza che non si contrappone al mio lavoro, anzi, si affida in modo assoluto a me per quanto riguarda l’illuminazione, però sulla macchina da presa ha molta conoscenza e padronanza: può chiedermi ad esempio che il personaggio parta da quel posto e che per il controcampo riparta da quel posto, quindi io devo illuminare tutto il percorso. Insomma è un bel lavoro, ma sono ripagato da quello che ne esce, sempre.

CA: Vorrei entrare nel vivo di Hey Joe. Nel film si notano in modo particolare certe dominanti cromatiche, che guidano l’atmosfera del racconto quasi in funzione simbolica. Mi spiego: c’è una differenza nel modo in cui sono stati trattati alcuni binomi, come dentro/fuori e passato/presente. Se per gli interni, così come nelle scene dei flashback di Dean a Napoli, prevale una temperatura calda, quando Dean si scontra con la realtà del presente la fotografia torna in qualche modo più neutra.
DC: Il discorso del film è legato alla pazienza di un padre e alle attese di un padre. Io con queste differenze (notte/giorno, interno/esterno, inverno/estate) mi ci ero relazionato solo sullo scritto, in sceneggiatura. Ora, io non so che cosa sia successo nel film, quale magia – perché se nel cinema puoi scrivere, pensare, immaginare, poi quando c’è l’atto compiuto, o quello che devi compiere, tutto è un mistero – allora molto probabilmente è successo quello che io desideravo, e cioè di trovare una soluzione per far capire questi passaggi, la pazienza di un padre che cerca disperatamente suo figlio, le giornate che cambiano. Ѐ una cosa pensata, ma non voluta. Ѐ avvenuta. Quindi mi fa piacere che tu l’abbia notata. Poi è normale considerare anche le potenzialità della color, in cui vai a definire appunto le dominanti e le temperature. Si gira con uno standard, un tipo di luce che immagini per il film (ad esempio noi pensavamo di girare in pellicola, poi ne abbiamo girato solo una parte così). Ma questo importava poco, il vero problema non è la pellicola, è come si immagina il film, come si riceve dai personaggi un’emozione. Ѐ lì che avviene la magia. Lo dico da direttore della fotografia, ma anche quasi da “co-complice” (non co-autore) del desiderio che ha il regista. Poi il tema che affronta Giovannesi della ricerca disperata che intraprende un padre di suo figlio mi ha attratto molto perché ho scritto un film che dovrò girare che tratta appunto il tema dell’impossibilità. Ѐ però un grande piacere che hai osservato questa cosa perché non è stata calcolata, sarebbe stato addirittura brutto fosse stato tutto così calcolato, non è così. Ѐ avvenuto.

CA: Avete lavorato anche molto nella penombra e in moltissime situazioni notturne. Mi racconti qualcosa?
DC:
La notte più complicata è stata quella della barca. La cosa più divertente, ti racconto questo, è che Claudio ci ha fatto girare realmente di notte con le onde alte. Infatti abbiamo rotto un Ronin (quel particolare stabilizzatore che su cui si monta la macchina per riuscire a tenerla sempre in bolla senza farle subire troppe oscillazioni) perché abbiamo lavorato nel vento e con le onde, perché Claudio voleva l’effetto reale delle barche sul mare mosso, e aveva ragione a volerlo. Lì è stato complicato illuminare, avevo pochissimi punti di riferimento. Ho dovuto fare i conti, in maniera surreale, con una bussola che avevano loro lì sulla barca, unica luce realistica a disposizione – altrimenti non avevo nulla – e che crea un’illuminazione quasi surrealista, ma che comunque è realistica. Avevo bisogno di un riferimento ovvio, lampante, ed era la bussola. La difficoltà sta nel fatto che Claudio vuole sempre delle situazioni reali, sebbene ami anche le immagini più surrealiste. D’altronde, in quel momento sta facendo cinema, sta cioè “narrando facendo il bugiardo”, come diceva Fellini. E l’altra cosa straordinaria di quella scena è che avevamo James Franco davvero alla guida della barca. Insomma, sul set c’era un clima di vera complicità con tutti.
Per girare le notti, sai, fai sempre i conti con la realtà. Se devo avere un rapporto col realismo io mi baso su quello che è la realtà. Io infatti dico spesso che mi piacerebbe lavorare senza mettere luci, con la luce naturale, però è impossibile. Io semmai imito la luce: imito la luce di Napoli, Napoli che è bellissima perché ha queste contaminazioni – addirittura sono tornato all’idea di Tano da morire, ai colori forti, i blu, i rossi, la reale contaminazione legata a quella città. Mi piace l’idea di contaminare la città con la verità, perché lì hanno la lampada a incandescenza, i neon a basso consumo, quindi tutto quello che esiste a Napoli – e che esiste anche a Palermo – l’ho contaminato; è il Sud. L’unica cosa estranea che ho raccontato è il locale con le ballerine. Quello non esisteva nel mio immaginario, non l’avevo mai visto e ho dovuto crearlo. Quindi si vede questo locale con le luci basse e calde, l’orchestrina, le donne, e con poco siamo riusciti a raccontare quel luogo in modo credo verosimile, sebbene fosse totalmente lontano da una Napoli che esiste. Ho dovuto contaminare.
CA: C’è una cosa che sei particolarmente soddisfatto di essere riuscito a fare e una cosa che invece non sei riuscito a fare sul set di Hey Joe?
DC: Ti dirò, quando lavori con Claudio lavori in maniera artigianale. Sono contento delle immagini in 16 mm, quelle relative al passato di Dean, perchè mi hanno dato la possibilità di variare periodo, e questo non solo perché si cambiava supporto di ripresa, ma perchè i personaggi mi ispiravano quel diverso tipo di immagine. Ne sono molto soddisfatto. In generale credo che ogni film debba riuscire nella sua potenza e nella sua forma. Non sono uno che dice: “Bello il film, ma brutta la fotografia” o il contrario, non mi relaziono così col cinema. A me piace quando si dice che il film è bello, punto. Ho sempre una relazione col film in sé. Per Hey Joe ricordo che feci un’inquadratura con la tavola coi camorristi tutti attorno in una scena illuminata coi neon in cui qualcuno mi ha detto che sembrava l’Ultima Cena. Nulla di costruito, mi è venuto naturale. Avevo questa relazione col sud e il potere assoluto, quindi l’iconografia l’ho voluta fare napoletana, non religiosa o cristiana, eppure è venuta fuori quell’immagine. Mi è venuta, non sto scherzando, mi è venuto naturale. Ho posizionato la macchina, ho preso dei panni per oscurare la scena, ed è venuta l’Ultima Cena. A volte sono i riferimenti folli che servono.
CA: In un’intervista una volta hai detto: “Il mio immaginario è ruvido, sporco, granuloso, imperfetto.” È ancora così? Ci sono stati dei cambiamenti nel tuo approccio alla direzione della fotografia?
DC: Quando mi metto nei panni del servitore di immaginario altrui non posso, naturalmente, pretendere di imporre quello che immagino io, posso solo dare degli input. Non mi reputo un autore delle immagini, ma un servitore, appunto. Io vario, e vario a seconda degli autori con cui lavoro e ho lavorato, da Roberta Torre a Marco Bellocchio. Come mi è stato detto, passo dall’Ottocento al contemporaneo senza difficoltà. Non ho il problema dello stile, mi adeguo, sono come un viaggio nel tempo, mi piace il cinema in generale, mi adatto all’input che mi dà l’autore. Come dicevo a Claudio una volta, io il cinema reale non lo farò mai, io farò il cinema del reale, in cui è il mio mondo a raccontare la realtà. E il mio mondo è senza alcol, senza telefoni, senza niente.

CA: Ѐ stato il figlio può essere un esempio di questo tuo modo di vedere.
DC: Esatto, un film ambientato negli anni Settanta, ma con una contaminazione continua di periodi. Non mi interessava raccontare un periodo e basta, volevo raccontare il mio. Tutti i personaggi, lì, sono miei parenti incollati agli attori. Quando si tratta di un film di un altro regista cerco in tutti i modi di allinearmi col suo modo di vedere, ma io sono rimasto ruvido, sporco, granuloso e imperfetto!
CA: Nel tuo percorso hai lavorato molto in bianco e nero per poi passare al colore.
DC: Il bianco e nero l’ho fatto e lo farò, ma per raccontare un mondo scenograficamente, non per il bianco e nero in sé e per sé. Il bianco e nero è stato un toccasana perché mi ha permesso di scenografare la mia città in maniera inedita: le ciminiere, le macerie diventavano belle, eleganti. Come le fotografie industriali di fotografi che sono stati a Palermo, da Nicola Scafidi a Eugenio Interguglielmi, e quindi mi rifacevo a quel tipo di linguaggio. La macchina era sempre ferma, era una fotografia che si animava solo tramite i personaggi. Però non ho problemi ad affrontare altri modi, altri linguaggi. Quelli degli altri registi diventano come i film che non farò mai.

CA: Come avete lavorato sulla città per prepararvi a girare Hey Joe? Ha riservato delle sorprese?
DC: Ma guarda, le notti hanno confermato il mio modo di vedere la storia e mi hanno dato un enorme regalo. Napoli la conosco molto bene, l’ho conosciuta anche meglio con La paranza dei bambini. Per Hey Joe abbiamo scelto i luoghi giusti, più sobri rispetto a La paranza dei bambini perché avevamo bisogno di ambienti circoscritti per raccontare le due storie parallele presenti nel film. Napoli regala sempre qualcosa, c’è tutto. Anche perché per me Napoli è Palermo, è come se girassi nella mia città.
CA: Genera una sensazione straniante vedere un film come Hey Joe basato, come dicevi all’inizio, su una camera che segue con insistenza i volti annullando quasi il resto del paesaggio. Ci si chiede come sia possibile che in un luogo così potente si possa condensare la vita di un uomo solo e straniero. Si crea un contrasto tra la bellezza del panorama – che pure si intravede – e quello che vive il protagonista.
DC: Questa è la bravura di Claudio. Mentre in altri film abbiamo raccontato il luogo, qui il luogo si annida dentro l’anima dei personaggi. Si inizia con la guerra, con Napoli, e dopodiché Napoli è il passato, è dentro di lui (Dean). La potenza del film è riuscire a guardare Dean e sentire la Napoli del suo passato. Senti Napoli, ma non la vedi se non ogni tanto, al ristorante, al porto. Non è un film di Sorrentino, ecco (ride). Napoli nel nostro caso è dentro, dentro, dentro. Il film non era facile perché è tutto basato sul volto di James Franco.

CA: E come è stato illuminare questo volto che traina l’intero film?
DC: James Franco ha un volto meraviglioso. Ne parlo spesso, è un volto facilissimo da illuminare e potente, senti molto tutte le emozioni che evoca, è stato molto bravo ed è stato un grande onore lavorare con lui, vero cultore di cinema, attento alle scene e a tutto il lavoro sul set.
CA: Fritz Lang, in una bellissima intervista tenuta da Godard nel 1967, diceva che “il regista deve essere come uno psicanalista, riuscire ad andare sotto la pelle dell’attore.” Tu che definizione daresti al direttore della fotografia?
DC:
La stessa cosa. Il direttore della fotografia intanto non deve essere un tecnico. E prima di tutto deve conoscere molto il cinema. Io sono convinto che serva e sia fondamentale conoscerlo, infatti rimprovero spesso i giovani e gli studenti che non guardano il vecchio cinema. A me in realtà dà fastidio questa tendenza di molti registi contemporanei di occuparsi solo delle immagini senza badare a chi c’è davanti alla macchina da presa. Ѐ una cosa sbagliata secondo me. Quando mi sottopongono una sceneggiatura, non solo chiedo dove si girerà per fare i sopralluoghi, ma chiedo chi ci sarà, le facce dei personaggi, che sono gli altri panorami del cinema. Io poi le faccio anche le immagini belle, quelle “fighe”, ma non è quello il punto del fare cinema e di fare il direttore della fotografia, non mi interessa proprio. Le immagini devono narrare in un certo modo, seguire un certo linguaggio. Vedi Il ritorno di Cagliostro: è il primo film fatto in italia che ha tutti i formati e i linguaggi della comunicazione della settima arte.
Tra parentesi, Matteo Garrone, che ha visto Hey Joe e a cui è piaciuto tantissimo, ha subito chiamato Claudio per dirgli che secondo lui avevo fatto una fotografia uguale a La prima notte di quiete, il film con Alain Delon del 1972 di Valerio Zurlini. E aveva ragione! Mi è rimasto talmente in testa che si è impresso in me, sebbene non l’abbia preso in considerazione consapevolmente per girare Hey Joe. I vecchi film non li rimuovi, ti rimangono dentro. E aveva ragione appunto perché c’è lo stesso trattamento della luce nei locali, nei colori. Poi Hey Joe è stato passato in pellicola, trattato sviluppato e scannerizzato pur girando in digitale – tutto un lavoro per arrivare proprio a quel gusto lì, che in effetti c’è ne La prima notte di quiete. Garrone infatti ha indovinato. Questa è l’elaborazione dell’immaginario.

CA: Mi spieghi meglio questo passaggio dal digitale alla pellicola che è stato fatto per Hey Joe?
DC: Il film ha una parte girata in 16 mm e una parte in digitale però passata nella chimica e poi scannerizzata. Infatti, tutta la grana che si vede nel film non è grana aggiunta, è pellicola. E questo è il miglior modo per conservare il cinema, che ha e avrà sempre bisogno dei negativi per essere conservato e restaurato. Claudio voleva girare tutto in pellicola, io però gliel’ho sconsigliato. Si sarebbe imprigionato, avrebbe dovuto fare solo tre ciak a scena, mentre Claudio ne fa almeno quindici o venti. Perché negarsi una libertà? Sebbene questo procedimento non abbia fatto l’immagine del film, è come se gli avesse dato un vestito in più, come se avessi girato con la Ferrania o con la Kodak. Però tutto il lavoro luministico è necessario farlo in ripresa.
CA: Un ultima cosa su Hey Joe.
DC: Voglio dire che sono sempre felice di averlo fatto. È vero che Giovannesi ti massacra perché vuole molto, ma quando vedi il film ti dici: “Aveva ragione”. È sempre una conferma, e raramente mi succede di poterlo dire. Aver collaborato a un film bello mi rende felice, e sono convinto che questo film sia la vera maturità di Claudio. (Scrivilo, mi raccomando! Almeno mi garantisco il suo prossimo film!).

Hey Joe, diretto da Claudio Giovannesi, è da oggi in sala!