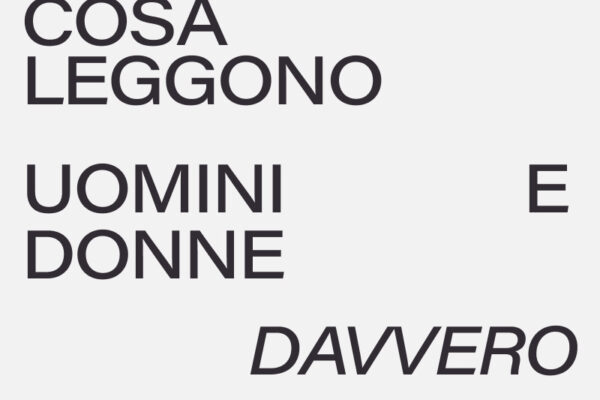Grattacieli, convenience store ed insegne neon, ciliegi in fiore e abiti tradizionali. Quando pensiamo al linguaggio visivo asiatico, in particolare cinematografico, ci vengono in mente degli scenari molto specifici. Solitamente sono collegati ad un’essenza intensa e poetica, a una fotografia perspicace che si fa messaggera dell’animo umano, presupponiamo una naturale capacità di catturare l’essenza spirituale di una condizione o individuo attraverso un acuto elemento audiovisivo e una sceneggiatura filosofeggiante. Insomma, uno spazio estetizzante che preferisce l’introspezione e l’elemento riflessivo, qualunque sia il genere di contenuto.
C’è da sottolineare che in questo caso con “orientale” si intende il cinema dell’Est asiatico, attualmente il più predominante a livello globale. Infatti, inserendo “film asiatici” come chiave di ricerca su Google, vengono fuori tendenzialmente gli stessi titoli: Old Boy, In the Mood for Love o Memorie di un assassino, Viaggio a Tokyo o La foresta dei pugnali volanti. Nel pensare a questo genere di film, inoltre, ci vengono in mente storie dove il visivo prende il sopravvento, dal grottesco di Old Boy al contesto familiare di Hirokazu Kore-eda, fino alle metropoli neon di Wong Kar-wai. Tornano alla memoria gli aspetti più tradizionali: i film di Bruce Lee, i kimono di Yasujiro Ozu o i mondi di Zhang Yimou. Tra noir astuti e comfort movies, non sono poche le caratteristiche che spiccano quando si parla di narrazione orientale. La popolarità di questa estetica e narrativa così “lontane” attrae il pubblico globale, alle quali dedica pagine social dove condividere scene o considerazioni.
La narrazione orientale
La narrazione orientale non è facile da definire, soprattutto oggi, in quanto la continua trasformazione degli scenari sociopolitici mondiali porta a una diversificazione interna dei contenuti culturali, con cambiamenti di direzione e focus narrativi. Di conseguenza, nonostante esistano temi e modus operandi che si mantengono vivi nel tempo, la natura di questi contenuti non è sempre costante. Gli ingenti rapporti economici ed influenze cross e transculturali la rendono, soprattutto nel cinema, una forma espressiva disomogenea.

Anche se ci sono sempre stati film diventati popolari all’estero, la contemporanea tendenza universalistica del cinema, esacerbata durante il periodo pandemico, facilita l’interesse di un pubblico straniero. Il recente successo delle narrazioni orientali ha cambiato traiettoria per l’industria globale, dando una svolta all’atteggiamento orientalistico ed etnocentrico delle case di distribuzione. Se da un lato il cinema asiatico riesce a farsi spazio perché esprime temi universali, dall’altro per acquisire distribuzioni estere si ritrova a giocare secondo regole altrui. Ad oggi c’è maggiore apertura verso una narrazione orientale, e il “divario” dei sottotitoli non costituisce più un ostacolo. Nonostante questo, i rapporti collaborativi tra case di distribuzione occidentali e orientali giocano un ruolo più rilevante di prima. Ciò che rientra nel nostro immaginario culturale è di maggiore interesse, e permette così buoni riscontri dalla critica in quanto voci “tipiche” e “nazionali”. Ne sono prova le svariate rappresentazioni auto-orientalizzanti del cinema di Takeshi Kitano o di Zhang Yimou.
Inizialmente, gli scenari e le estetiche orientali si addentrano nella cultura occidentale attraverso rappresentazioni orientalistiche come, ad esempio, Memorie di una Geisha (2005), film che ha scatenato non poche critiche sia in Giappone che all’estero. Non mancano, ovviamente, titoli locali che sbarcano ai festival esteri, i cui titoli mostrano maggiormente scenari tradizionali o già noti ad Ovest, come il folklore dei film di Akira Kurosawa e Zhang Yimou. Le cose sono oramai un po’ cambiate, dato l’aspetto cosmopolita del cinema contemporaneo.
Questo cosmopolitismo cinematografico viene descritto da Felicia Chan in Cosmopolitan cinema come “fatto di idealismo, fantasia e aspirazione”. Di per sé, il cosmopolitismo comprende visioni di un universo unito nella differenza, ma, quando viene messo in pratica, specialmente nel cinema, esprime il bisogno urgente di ripensare l’approccio verso questa differenza, riconoscendone l’attrazione per gli aspetti politici, capitalistici e culturali globali.
I tratti distintivi
Nel 1960 il regista statunitense John Sturges completa I Magnifici Sette, ispirato a I Sette Samurai di Akira Kurosawa. In entrambi i film, i protagonisti sono mercenari che affrontano un compito apparentemente impossibile, ma con profonde differenze culturali.
La differenza nell’approccio relazionale delle due culture è evidente: una vive secondo un ideale (e dovere) di collettività, mentre l’altra segue il sogno individualista.
Nel film originale, i samurai chiamati per proteggere il villaggio instaurano relazioni feudali con i contadini e tentano la coesistenza pacifica. Inoltre, non ricevono denaro per la loro protezione, bensì cibo e riparo. Svolgono un ruolo all’interno di una società, creandovi una condizione di equilibrio. Ne I Magnifici Sette, invece, i cowboy lavorano per profitto, si distanziano dai compaesani e formano legami soltanto con i “colleghi” per superficiale senso di squadra. La differenza nell’approccio relazionale delle due culture è evidente: una vive secondo un ideale (e dovere) di collettività, mentre l’altra segue il sogno individualista. In entrambi i casi, i due gruppi di protagonisti rappresentano l’eroe perfetto secondo le rispettive forme di pensiero e strutture sociali.
Nonostante il senso collettivo sia un valore molto presente, nei film asiatici si dà molto spazio anche alla soggettività. Con quest’ultima si intende una forza introspettiva e autoriflessiva che crea soggezione durante la storia e si concentra sulle influenze interiori, ovvero i pensieri, le sensazioni e le emozioni dei personaggi. Lo Wai-luk, analizzando A Time to Live, A Time to Die (1985) di Hou Hsiao-hsien, intravede un ambiente dove “il tempo rimane fermo, con i sentimenti del personaggio disegnati come se fossero una linea, una brezza invisibile, che si muove dolcemente, danzando, espandendosi o inanellandosi nello spazio”. In questo contesto, il messaggio arriva attraverso un processo interiorizzato sul quale si chiede all’audience di riflettere, diversamente da quanto avviene in molti film occidentali. Nasce così una superficie emotiva dove il singolo impara ad esistere oltre il dovere collettivo. In questa superficie cresce e si trasforma, grazie all’influenza reciproca tra l’ambiente esterno in cui si sviluppa e il sentimento interiore che solo egli – e il pubblico – conosce. Molti, di fatto, definiscono i film est-asiatici come parte di un cinema del sottile, del sottinteso. Una concezione del genere si contrappone al cinema tipicamente occidentale, dove invece i sentimenti devono essere espressi in modo diretto perché siano riconosciuti. È quello che accade con il monologo di America Ferrera nel Barbie di Greta Gerwig. Sebbene fosse già chiara nel corso del film, la condizione della donna acquisisce validità nel momento in cui se ne parla con toni enfatici e con una certa potenza discorsiva.
Per chi ha più dimestichezza con le tecniche narrative, saltano subito all’occhio le differenze nella stesura di una trama o di una risoluzione del conflitto. Sono strutture riscontrabili in molte opere tipiche che scaturiscono da assetti letterari millenari. La struttura più utilizzata e nota viene oggi indicata con il suo nome giapponese, Kishoutenketsu, e richiede il seguente ordine: introduzione – sviluppo – punto di svolta – conclusione. Molti ritengono provenga dalla poesia cinese Qijue del periodo Tang, ma ciò che è certo è la sua presenza nei processi creativi dei Paesi circostanti, come Cina, Corea del Sud, e Giappone. Nel contesto cinematografico, le opere di Akira Kurosawa o d’animazione, in particolare Ghibli, ne rappresentano la massima espressione. In contrasto, la narrativa occidentale, nella maggior parte dei casi, utilizza una struttura a tre atti: introduzione – scontro – risoluzione della crisi, e in questo caso molti dei film di Peter Weir ne sono un perfetto esempio. La differenza, ad ogni modo, non sta tanto nel numero di atti, quanto nel loro contenuto. I due tipi di strutture citati, che non sono certamente gli unici a disposizione, sono piuttosto dei punti di partenza generici, non definitivi. Nella diversa suddivisione e selezione dei focus narrativi, esemplificano alcune delle differenze che interessano ogni nazione nella stesura di una storia.

Tuttavia, queste due strutture non sono limitative per nessuna delle due espressioni narrative. Sono quelle più utilizzate, ma non le uniche presenti. In seguito ai diversi sviluppi culturali, dalla letteratura al cinema, sono spesso state soggette a trasformazioni, che le rendono dei punti di partenza generici ma non definitivi.
Simbolismi, tropi, e metafore sono il risultato di un certo sviluppo socioculturale e vi sono, dunque, molti elementi specifici che distinguono i due metodi narrativi. Di conseguenza, non sono poche le differenze che segnano un distacco contenutistico e tecnico tra Oriente e Occidente, dallo storytelling alla fotografia, o addirittura dalla musica fino ai messaggi impliciti. Tuttavia, queste differenze possono affascinare quanto distanziare lo spettatore dall’opera.
È difficile proporre una definizione esaustiva delle narrazioni orientali sullo schermo. Questo perché i loro luoghi d’origine presentano, proprio come l’Occidente, molteplici sfumature scaturite dal continuo mutamento ambientale, politico e socioculturale. Non solo, spesso le considerazioni etnocentriche limitano l’approccio occidentale, anche se ciò non rende il cinema orientale inaccessibile. Allo stesso tempo, la presenza di elementi “universali” può rendere il messaggio del film più comprensibile, ad esempio, e in questo modo riesce ad unire più culture. Il rapporto tra le due culture si rivela così contraddittorio, in quanto l’equilibrio tra cultura locale ed estera risulta ambiguo e poco definito.
Un cinema transnazionale
Annette Kuhn e Guy Westwell in A Dictionary of Film Studies (2012) definiscono il transnazionalismo cinematografico come contenuto “che trascende i confini nazionali e/o modella le proprie strategie narrative ed estetiche con riferimento a più di una tradizione o comunità nazionale o culturale.” Quest’idea di transnazionale allude “alle forze che collegano persone e istituzioni attraverso le nazioni: […] denaro, merci, informazioni e persone. Il cinema transnazionale fa parte di questo ampio nesso di forze, che comprende non solo il dominio di Hollywood sui mercati cinematografici mondiali”. La definizione riassume perfettamente il mondo del cinema dagli anni ‘80 in poi che, nonostante il predominio occidentale, ha preso forme sempre più internazionali.
Ad oggi, gli aspetti più influenti nella diffusione e scrittura di un film sono quello capitalistico e quello politico ed entrambi sono cruciali per la riuscita di una storia sullo schermo. Queste due componenti, infatti, essendo legate ai processi di distribuzione, hanno il potere di influenzare e re-impostare l’andamento della storia a seconda del target o dei festival ai quali la pellicola sarà proiettata. Può capitare che la narrazione venga modificata per raggiungere più Paesi, o al contrario che rimanga così com’è. Questo perché non sempre riusciamo a cogliere le somiglianze, oppure ignoriamo le differenze culturali proposte dalla trama. Di conseguenza, nascono spesso dibattiti, analisi e/o critiche che cercano di fare luce o evidenziare la natura intrinsecamente politico-economica di ciò che guardiamo. Tra questi, ne spicca uno che riguarda il distanziamento occidentale dalla narrazione orientale sulla base degli elementi politici. L’esempio più lampante è sicuramente l’atteggiamento nei confronti del cinema cinese, in particolare dei film bellici o di generi dove i personaggi principali incarnano valori eroici.
Nonostante ci si diverta a criticare o addirittura ironizzare sulle opere siniche come mezzi propagandistici del Partito, Lin Feng e James Aston in Renegotiating Film Genres in East Asian Cinemas and Beyond (2020) offrono una prospettiva diversa su come ne valutiamo i contenuti. Viene fatto un paragone tra i film bellici cinesi e statunitensi che enfatizza una certa somiglianza. Sia il cinese Wolf Warrior che lo statunitense Saving Private Ryan portano avanti simboli, messaggi e valori che fungono da veicoli di propaganda militare, tra l’altro espressi attraverso gli stessi mezzi tecnici: immagini ed effetti speciali grandiosi – ovvero di estetica dell’eccesso – e discorsi melodrammatici sulla propria identità nazionale. Ci sono, ovviamente, distinzioni non solo di contenuto culturale ma politico: la Cina gioca sullo stereotipo di vittima, riproponendosi forte poiché spinta dall’amore per la Patria (o Partito), mentre gli Stati Uniti si pongono sotto una prospettiva che giustifica e fortifica le motivazioni dietro la loro battaglia. Secondo gli autori, il fatto che Paesi diversi siano legati dallo stesso interesse propagandistico proverebbe l’esistenza di un’ideologia transnazionale, che pone il genere bellico “come un sistema globale piuttosto che una collezione di nazioni più o meno autonome.”
D’altro canto, molti film presentano caratteristiche ed elementi universalistici facilmente più accessibili. L’esempio più lampante è il cinema sudcoreano. Dagli anni ‘90, con la nascita della Korean Wave (o Hallyu), molti registi si sono distinti per narrazioni di grande sensibilità verso la società nazionale post-capitalista del periodo, come Lee Chang-dong, Kim Ki-duk e molti altri. Nonostante le specificità culturali, sono molti i temi universali che riescono ad arrivare al cuore dell’audience estera. Il successo, aumentato enormemente negli ultimi anni, è stato possibile grazie all’unione di caratteristiche nazionali con uno stile estetico in linea con la definizione occidentale di cinema sudcoreano.

L’universalità della diseguaglianza economica e della lotta della sottoproletaria famiglia Kim rischia, tuttavia, di essere vista come cinema eat the rich e nulla di più.
Non era sicuramente la prima volta che un film asiatico sbarcava il botteghino o riceveva premi di grandissimo valore, ma Parasite di Bong Joon-ho è un ottimo esempio. Il regista aveva già avuto esperienze con l’Occidente e, in più, il film ha avuto un tempismo perfetto (il periodo pandemico). L’universalità della diseguaglianza economica e della lotta della sottoproletaria famiglia Kim rischia, tuttavia, di essere vista come cinema eat the rich e nulla di più.L’azzardo del cosmopolitismo e del transnazionalismo è quello di eliminare il carattere locale della storia, impedendo al pubblico a voler scoprire le sue specificità locali e socio-culturali, come se l’importante fosse solo potersi immedesimare e riconoscersi in quanto visto, appiattendo tutto il resto.
Ad ogni modo, è anche vero che il cinema unisce e, se una storia riesce a colpire le persone nel profondo, allora non tutto è perduto. Il successo di Parasite ha rappresentato una svolta significativa per il cinema sudcoreano e quello asiatico in generale. In contesti come quelli nordamericani, dove i sottotitoli non sono particolarmente apprezzati, un assetto linguistico-culturale diverso ha ora più fascino. Tra l’altro, molte di queste narrazioni permettono di scoprire prospettive diverse o di far luce in qualche modo su aspetti locali che non conosciamo, come nel caso di Exhuma di Jang Jae-hyun. L’opera non è politica di per sé e strizza l’occhio al botteghino occidentale, ma rivela un pezzo di storia sudcoreano dimenticato, ovvero l’occupazione giapponese e un sentimento anti-nipponico tutt’oggi vivo. Esprime, inoltre, il fascino contemporaneo per la tradizione, in questo caso lo sciamanismo. Exhuma ha avuto un ottimo successo sia ai festival internazionali che a livello nazionale, ottenendo un record di incassi al botteghino (più alti di Dune 2).

Meaghan Morris ricorda la difficoltà di superare i confini culturali nell’approcciarsi a un’opera straniera: “Troppo spesso, semplicemente, non sappiamo abbastanza per discutere storicamente di cinema in un registro transnazionale, anche su scala regionale”. In questo scenario cosmopolita, ricorriamo spesso a paragoni (e parallelismi) continui, che rivelano una consapevolezza forse eccessiva dei confini culturali, in quanto la comprensione di un’opera che continuiamo a percepire come “lontana” sembra dover passare necessariamente per il confronto con la propria cultura di riferimento.
Di fatto, la natura cosmopolita del cinema può enfatizzare la sensazione di non poter mai “sapere abbastanza”. Ma questo stato di “non sapere abbastanza” non deve essere un punto d’arrivo, bensì il punto di partenza per un’analisi produttiva. In questo senso la prospettiva comparativa, che diventa una posizione critica cosmopolita, non deve limitarsi a scoprire le proprie lacune, ma tentare di accettarle o affrontarle per imparare e godere più pienamente di storie nuove.
I limiti della definizione
In Questions of Japanese Cinema, Mitsuhiro Yoshimoto critica un certo approccio occidentale verso il cinema nipponico. Si tratta di un atteggiamento fermo sul “carattere nazionale” perché, come spiega l’autore, suppone che “il Giapponese rappresenti un’essenza collettiva, omogenea e astorica che viene definita come la Mente Giapponese.” Generalmente parlando, gli occidentali hanno dei propri schemi cognitivi con cui forzano la comprensione di nuove informazioni. Nell’approcciarsi ad un contenuto estero, si piegano ai suddetti pattern per tentare di capirli. Ciò può risultare talvolta dannoso, poiché limitativo nel comprendere realtà diverse e, di conseguenza, ogni caratteristica considerata “estranea” in un film straniero diventa automaticamente espressione di un “cinema nazionale”. Questo atteggiamento è maggiormente sentito nel mondo cinematografico e quello letterario. Film o libri che presentino le caratteristiche associate al loro Paese diventano così quelle che solitamente riscontrano maggiore successo in Occidente. Ciò spiega la supremazia di alcuni autori rispetto ad altri, nonostante la loro celebrità occidentale non corrisponda a quella locale. Ne sono un esempio Takeshi Kitano o, se vogliamo citare il mondo letterario, Haruki Murakami.Non sono necessariamente approcci dettati dalla volontà di porsi come superiori rispetto ad una determinata cultura, quanto dalla necessità metodica di definire quel che si vede, senza considerare una mentalità diversa. Si dà forma a una cultura “dell’altro”che affibbia definizioni rese successivamente universali. Questa cultura propone un distacco dal contenuto, perché considerato troppo estraneo ed etichettato solo come tale. Come si è già detto, è quello che accade, ad esempio, con la definizione del “cinema giapponese”. Il nostro metro di giudizio della “giapponesità” di un film ricerca gli elementi che abbiamo noi stessi deciso di vedere come caratterizzanti, associati all’elemento tradizionale e simboleggiata dalle opere di Yazujiro Ozu. Non a caso, l’ultimo vincitore del FEFF26 è stato Takano Tofu: un’opera contemporanea ma dagli elementi tradizionali, poetici e Ozu-eggianti. Ma il problema sta nel fatto che, dato il peso Occidentale a livello accademico e mediatico, spesso queste definizioni prendono il sopravvento, e diventano immaginari globali comuni.
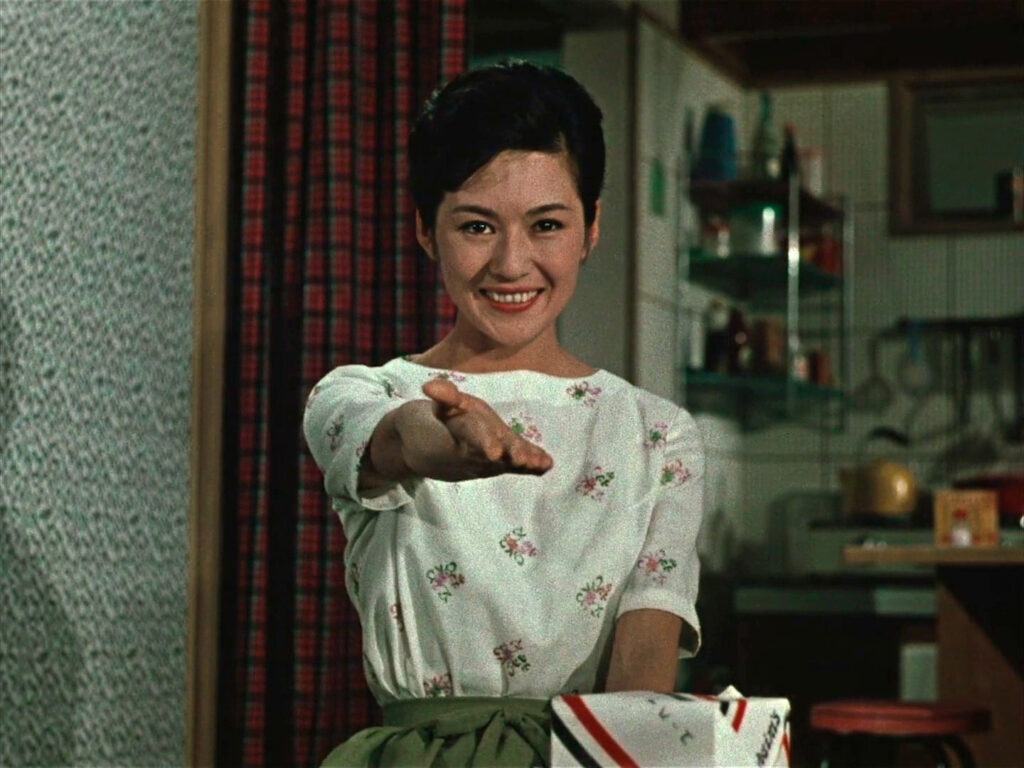
Parafrasando Guy Debord in La società dello spettacolo, si elimina la distanza geografica solo per produrre una nuova separazione interna che, in questo caso, prende forma nell’estremo universalismo o in una onnipresente prospettiva occidentale. È naturale non riuscire a comprendere in maniera completa un contenuto culturale estero, però alcuni divari culturali possono essere allentati attraverso lo sradicamento di alcuni preconcetti. Tra questi, proprio l’approccio chiuso che spesso serbiamo per contesti a noi incomprensibili, non in linea con la narrazione nostrana.
Si tratta di un approccio spesso inculcatoci, perché molti media e studi accademici sono prodotti da un’analisi orientalistica ed etnocentrica invasiva. Un’analisi di questo tipo è figlia di una quasi ufficiosa realtà culturale “dell’altro” dove, nonostante esistano elementi universali a livello narrativo, persiste un distanziamento quasi naturale.
Per un cosmopolitismo critico
Secondo Felicia Chan, “la sfida del cosmopolitismo non è tanto quella di teorizzare la differenza, quanto quella di porre il problema dell’universalità. […] la celebrazione della capacità di attraversare i confini va accompagnata dal riconoscimento delle condizioni della differenza e delle trasformazioni che ne derivano attraverso ogni confine traslativo, che include o incorpora tutte le resistenze e le ostruzioni al processo”. La sfida posta dal cosmopolitismo per questi scenari internazionali è proprio la negoziazione, ovvero un compromesso che vede da una parte le storie e le memorie “locali”, dall’altra coloro che non posseggono quelle stesse conoscenze (che sono definite “alfabetizzazioni culturali”) e la loro interpretazione. Non è possibile che una persona di un’altra cultura comprenda appieno il codice di un’altra cultura, ma questa stessa mancanza di comprensione può dirci molto sul cinema nella storia e nella geografia di un territorio.
Dalla critica cinematografica, al ruolo di audience, fino alla distribuzione cinematografica, bisogna rinegoziare il nostro approccio al cinema asiatico. Sia la teorizzazione, la metabolizzazione che la commercializzazione di quest’ultimo scaturiscono da una mentalità etnocentrica e capitalistica che influenza non solo le nostre preferenze di consumo, ma mette in difficoltà nell’approcciarsi ad altre espressioni artistiche. Nasce così un rapporto che si basa sull’essere “altro”, non solo nel suo distanziamento, ma anche nell’apprezzamento. Si dà per scontato sia automaticamente tutto diverso, giustificandone possibili difetti, o enfatizzandone gli elementi universali. Non ci sporge un po’ più in là per comprendere i contesti socioculturali o politici che hanno reso questa narrazione possibile.
Questo influisce sul consumo e la distribuzione: si desiderano remake occidentali, si celebrano le “scoperte” cinematografiche di altri Paesi, si romanticizzano contesti locali e scenari perché idealizzati. Vengono fuori anche collaborazioni o produzioni impostate fin dall’inizio per poter ricadere nelle grazie di un’audience occidentale. Tra questi Perfect Days di Wim Wenders, che elimina qualsiasi caratteristica realistica locale per poter vendere uno scenario idealizzato del Giappone. Oppure, la trasposizione occidentale de Il Problema dei Tre Corpi, che adatta il mondo narrativo di Liu Cixin secondo i propri schemi per raccontarne il messaggio da un punto di vista occidentale dato che quelli della fantascienza cinese sono considerati difficili da comprendere. Infine, un ulteriore esempio può essere l’enorme numero di film e k-drama prodotti a stretti legami con Netflix.
Quando uscì Lanterne Rosse, molti connazionali e critici criticarono la totale invenzione di tradizioni cinesi, utilizzate secondo loro per poter facilitare la sua distribuzione e popolarità in Occidente.
La passione etnocentrica e orientalistica verso il cinema asiatico non è recente, ma si è espansa sotto forme diverse. Non riguarda solo l’audience occidentale, ma soprattutto le case di distribuzioni asiatiche, le quali sono più interessate ad aprirsi verso un pubblico occidentale. Anche i registi spesso creano narrazioni che molti studiosi considerano “auto-orientalistici”. Zhang Yingjin in Screening China (2002) afferma che autori come Kitano o Zhang sono coscienti della percezione occidentale del proprio cinema, il che influenza conseguentemente i loro lavori. Quando uscì Lanterne Rosse, molti connazionali e critici criticarono la totale invenzione di tradizioni cinesi, utilizzate secondo loro per poter facilitare la sua distribuzione e popolarità in Occidente. David Bordwell afferma, in riguardo alla critica, che ciò funziona perché così in Occidente “proiettano ciò che ci piace e quello che vogliamo sia il cinema.” Lo stesso può dirsi per le narrazioni sudcoreane, che hanno visto una svolta nella produzione mainstream grazie non solo a Parasite ma all’attuale fenomeno K-wave. Come già affermato, questo contatto in sincrono con l’estero non è necessariamente negativo, data la possibilità di scoprire nuove realtà e dell’accesso a nuovi racconti.
Inoltre, la narrazione orientale non è del tutto isolata e questo approccio occidentale verso la sua Settima arte, o anche lo stesso rapporto tra un’audience asiatica con i film occidentali, non sono per forza fattori destabilizzanti. Occidente e Oriente si influenzano a vicenda, come accade spesso con i film noir e crime hongkonghesi e quelli occidentali (tra cui le opere di Johnnie To o Quentin Tarantino). Nella sua concezione di “studi cinematografici comparativi”, Paul Willemen afferma: “Ciò che è instabile non è quindi il compromesso tra materiale locale e forma straniera, ma tra materiale locale e il potere trasformativo e l’impatto dell’industrializzazione stessa, che non è mai semplicemente ‘straniera’”. Ciò che viene messo a confronto non sono quindi le “culture” in quanto tali, ma “stabilire quale di queste forme industrializzate locali sia legata all’incontro con il capitalismo da parte della formazione locale e al suo interno”. Willemen sostiene la necessità di un impegno critico verso il mezzo cinematografico che tenga conto non solo “dell’esperienza comune ma delle storie divergenti dello sviluppo di un modo di produzione capitalistico e dell’impatto delle sue dinamiche di riformattazione sulle relazioni sociali, comprese quelle culturali”.
A differenza del multiculturalismo, il cui obiettivo è gestire le diversità culturali all’interno di strutture consolidate, il processo cosmopolitico è, secondo Gerard Delanty, un “processo di apprendimento”. Questo implica “una trasformazione cognitiva interna”, che influenza le concezioni sociali, politiche e culturali esterne del mondo. Per farla breve, un cosmopolitismo critico significa imparare a convivere con la sensazione di “non sapere nulla” e con i preconcetti determinati dalla propria cultura. Tuttavia, c’è una dimensione etica che non può essere ignorata: quella che riguarda orientalismo, etnocentrismo e capitalismo. È del tutto possibile, anzi auspicabile, avere coscienza di quanto questa dimensione pesi nella visione di un film e abbia il potere di impedire un approccio genuino a una nuova narrazione. Non affrontare questo aspetto significa non solo una strada verso il cinema cosmopolita molto più difficile, ma anche privarsi del mondo immenso e riflessivo delle storie orientali.