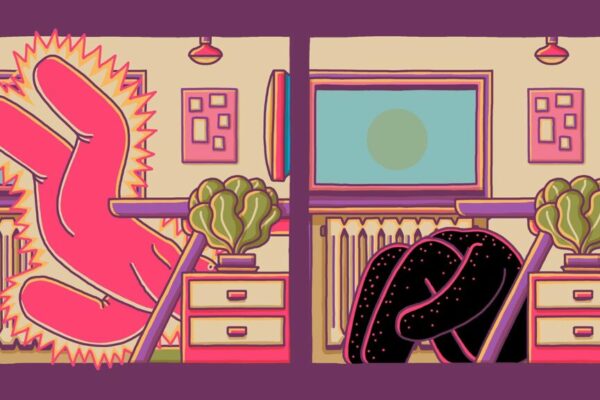Ho deciso che sarei diventato un lavoratore indipendente circa un anno prima del momento in cui ho dato le dimissioni. Questo fa di me una statistica, una di quelle che registra le “Grandi dimissioni”. Sociologi e giornalisti hanno preso a chiamarla così, la sempre più diffusa renitenza al lavoro che la pandemia sembra aver generato nelle persone in tutto l’Occidente. In effetti, se ripenso ai motivi della mia scelta, non posso negare che il primo lockdown abbia avuto una parte importante nel farmi maturare la coscienza che avrei potuto farcela. Per capire il perché, è il caso che torni indietro con la mente ai primi giorni di marzo del 2020, quando il presidente del consiglio Giuseppe Conte annunciò che avremmo dovuto distanziarci oggi per tornare ad abbracciarci domani.
vita privata e vita professionale
Come ho già avuto modo di scrivere su questo magazine, il primo lockdown è stato il momento in cui è diventata concreta la mia consapevolezza, fino ad allora solo potenziale, che avrei potuto svolgere ugualmente bene, forse anche meglio, il mio lavoro di copywriter e marketing manager da casa invece che dall’ufficio.
Per quanto all’epoca condividessi un appartamento non enorme con la mia compagna e nostro figlio, che aveva appena compiuto due anni, il passaggio dal lavoro in presenza a quello da remoto per me non è stato per nulla traumatico. Anzi è avvenuto in modo del tutto naturale, senza frizioni.
In quello che era il nostro soggiorno avevo a disposizione, come hardware, un iMac del 2009 ancora affidabile, una scrivania vecchia e mediamente comoda, una sedia abbastanza ergonomica da non darmi problemi ad articolazioni, schiena e cervicale. I software aziendali erano tutti in cloud e dunque accessibili facilmente a chiunque, da ovunque e in qualsiasi momento, così come gli strumenti di comunicazione che usavamo per coordinare il lavoro tra colleghe e colleghi. Il solo cambiamento che sono stato costretto ad apportare al mio flusso di lavoro quotidiano è stato perdere l’abitudine di lavorare in locale con alcuni tipi di file; abitudine che non ho ripreso neanche quando, all’inizio di quell’estate, quando la pandemia sembrava ormai in ritirata, sono tornato a lavorare in presenza.
Per il resto, ogni cosa, ogni routine ha continuato a funzionare (quasi) come se la pandemia non stesse accadendo e, per alcuni aspetti, la qualità del mio lavoro e dell’equilibrio tra questo e la mia vita privata ha subìto una serie di notevoli miglioramenti.
Per esempio ho scoperto che, a casa, potevo concentrarmi meglio che in un ufficio condiviso, quando avevo la necessità di lavorare in modo intenso alla stesura di testi di vario genere, velocizzando l’intero processo e migliorando la qualità del risultato finale grazie alla maggiore tranquillità del contesto circostante. Avendo poi tagliato i circa trenta minuti di spostamenti, in auto o con i mezzi pubblici, necessari per coprire il tragitto casa-ufficio in entrambe le direzioni, la giornata lavorativa risultava così molto meno faticosa.
Potevo passare in modo del tutto naturale dal tavolo della colazione alla scrivania e dalla scrivania al divano senza per questo dovermi affidare alla puntualità dei mezzi pubblici o confrontare con il traffico che, a Bolzano, subisce l’influenza di una viabilità tutto sommato demenziale, che lo rende un problema sentito ed endemico.
A differenza di molte altre persone, infine, il passaggio al lavoro da remoto non ha significato per me la scomparsa di ogni confine tra vita privata e vita professionale. Tanto le colleghe e i colleghi quanto la proprietà avevano continuato a rispettare, come di consueto, gli orari di lavoro e nessuno, mai, mi ha chiesto una call o una riunione al di fuori di essi, a dimostrazione che, forse, il problema non era tanto la condizione di lavorare da remoto, quanto quella di lavorare all’interno di culture aziendali poco sane.
La prima volta che ho avuto questo pensiero però è stato nel 2016, in terapia, mentre affrontavo, con l’aiuto del professionista che mi seguiva al tempo, alcune profonde insoddisfazioni che provavo rispetto alla mia vita professionale.
Tutto questo è servito a entrare concretamente in contatto con una dimensione di indipendenza che ha rafforzato non solo la mia convinzione che avrei potuto svolgere quel lavoro anche a distanza, ma anche quella che avrei potuto provare a diventare indipendente anche dalla realtà dell’agenzia che, fino a quel momento, mi era apparsa come il solo ed unico contesto in cui avrei potuto lavorare con la tranquillità che solo un contratto a tempo indeterminato è capace di dare. In potenza però era già da diversi anni che avevo cominciato a immaginarmi una vita vissuta in un orizzonte di totale indipendenza lavorativa.
La prima volta era successo nel 2016, in terapia, mentre affrontavo, con l’aiuto del professionista che mi seguiva al tempo, alcune profonde insoddisfazioni che provavo rispetto alla mia vita professionale. In quei mesi infatti desideravo confrontarmi con una realtà lavorativa diversa dalla mia e mi scontravo con la frustrazione di non riuscire a trovare un’alternativa che rispondesse ai bisogni e alle esigenze che sentivo di avere in quel momento. Era stato allora che il mio terapeuta mi aveva chiesto se avevo mai pensato di diventare un libero professionista, visto che dalle mie parole sembrava che fosse quella la dimensione a cui aspiravo, piuttosto che a un altro contratto di lavoro come dipendente.
Sulle prime la cosa mi aveva stupito, perché avevo sempre guardato con un misto di paura, diffidenza e forse anche fastidio al mondo della libera professione, come se si trattasse di qualcosa di molto distante dal mio mondo, dal mio modo di pensare e dal mio modo di concepire il lavoro. Nei blog e sui social, i freelance mi apparivano come una specie di tribù il cui atteggiamento oscillava tra l’entusiasmo scintillante di chi ha scoperto che esiste il lavoro perfetto – quello che trasforma la passione in professione e, una volta che lo trovi, non devi lavorare mai più in vita tua – e il costante maledire quella condizione di precarietà perenne che esponeva a tutta una serie di stress e ansie che mi apparivano soverchianti al punto da chiedermi come facesse una persona a sopportarle senza perdere la brocca.
Quella domanda però si era depositata nel profondo e aveva cominciato a lavorare. Mano a mano che passava il tempo iniziavo a capire che a rendere difficile la mia ricerca di una nuova occupazione non erano solo le condizioni strutturali del mercato del lavoro – che in effetti avevano un peso importante – ma anche la condizione di dipendenza che essa avrebbe comportato.
Il caso e la fortuna
Ripensando oggi a quel periodo mi accorgo che ogni volta che inviavo un curriculum o sostenevo in colloquio finivo per dire o fare qualcosa che mi rendeva inassumibile agli occhi di chi avrebbe dovuto valutarmi. Finivo così a pensarmi e a immaginarmi sempre più spesso come un lavoratore indipendente. Più lo facevo e più intensificavo i miei sforzi per crearmi e farmi coinvolgere in progetti paralleli che mi facessero sperimentare quella dimensione indipendente a cui, giorno dopo giorno, scoprivo di aspirare con sempre maggiore convinzione.
Le condizioni materiali sono un altro, fondamentale, tassello che ha contribuito alla mia decisione. Valga dunque come un personale privilege check confessare che ho preso questa decisione su basi abbastanza solide per poterlo fare serenamente.
Ho capito, riflettendo su questi passaggi, che una parte importante della capacità che ho avuto, qualche mese fa, di dare le dimissioni e farlo con tranquillità, aveva avuto origine nell’enorme lavoro di immaginazione fatto sulla mia vita potenziale e parallela, da cui erano scaturite quella serie di scelte che, poco dopo, mi hanno portato ad avere un certo numero di clienti e progetti da seguire fin dal mio primo giorno come libero professionista.
Dicendo questo, ci tengo specificarlo, non intendo concedere un punto alla retorica, fin troppo in voga, del “se lo vuoi, puoi farlo”. Piuttosto è un invito a ragionare, che rivolgo a tutte le persone che stanno pensando all’opportunità di scegliere o non scegliere l’indipendenza come proprio orizzonte professionale, su quanto sia importante farlo partendo col provare a immaginarsi come potrebbe essere trasformare la propria vita in questo senso e agire di conseguenza a seconda delle opportunità a cui si viene messi di fronte.
Ma questa capacità di proiezione è solo uno degli aspetti che permette di gestire le tante ansie che il gesto di dare le dimissioni nel processo che porta dalla dimensione dipendente a quella indipendente. Le condizioni materiali sono un altro, fondamentale, tassello che ha contribuito alla mia decisione. Valga dunque come un personale privilege check confessare che, quando ho dato le dimissioni, la mia compagna e io avevamo da poco acquistato e ristrutturato un nuovo appartamento, con l’idea di farne la casa dove vivremo (mai dire mai, ma la speranza è quella) fino alla fine delle nostre vite; che lei ha un’attività ben avviata e, per un po’ di tempo, avrebbe potuto sostenere la famiglia anche in assenza del mio stipendio; inoltre godiamo entrambi dei vantaggi di una piccola rendita, grazie alla quale il pensiero del mutuo è meno spaventoso di quanto potrebbe esserlo in condizioni differenti.
L’esercizio di riconoscere i propri privilegi vale, anche in questo caso, come messa in discussione della retorica del “se vuoi, puoi farlo”, mettendone in luce tutti i suoi limiti e i suoi presupposti ideologici più dannosi. Perché sono consapevole di non avere fatto proprio nulla, o davvero pochissime cose, probabilmente ininfluenti, per avere ciò che ho e poter godere del benessere materiale di cui ho goduto e godo. Perciò, se devo attribuire dei meriti per le scelte che ho fatto negli ultimi mesi, è prima di tutto al caso e alla fortuna che devo riconoscere un ruolo chiave nel mio percorso di indipendenza.
Le mie azioni, ciò che ho fatto io concretamente per arrivare dove sono arrivato – cioè all’inizio di una carriera da lavoratore indipendente – passano su un piano secondario. Un piano importante ma non decisivo, su cui se non avessi avuto una solida base materiale su cui poggiare le mie scelte, non avrei potuto spostarmi, o lo avrei potuto fare solo a costo di difficoltà molto più scoraggianti di quelle che ho incontrato.
La scelta di dare le dimissioni per passare da una condizione di dipendenza lavorativa a una dimensione di indipendenza può assumere una tonalità più ansiogena e spaventosa, soprattutto quando a imporla sono condizioni ambientali o contingenze sfavorevoli, e questo è ovviamente un grosso problema per chi si trova a viverla in tali condizioni. Ma quando tale scelta avviene in modo consapevole e maturato, rifletto provando a riassumere il senso di questo racconto, essa diventa più serena e meno dolorosa. Dunque gestibile. Gestire una scelta di questo tipo significa riconoscere per esempio che al passaggio da una condizione di dipendenza a una dimensione indipendente corrisponde un passaggio da una condizione di stasi a una condizione dinamica, di divenire e trasformazione costante che spesso mette in discussione la propria identità e invita rinegoziarla in un processo costante.
Sviluppare una capacità di immaginare lo sviluppo della propria carriera prima che questo avvenga è, come ho già avuto modo di sottolineare, qualcosa che mi ha aiutato molto ad arrivare sereno e sicuro delle mia scelte al momento in cui esse sono passate dall’esistere solo in potenza nella mia mente all’avere un effetto concreto sulla mia vita. Ci sono molti modi per sviluppare una capacità di questo genere. La terapia è stata quello che, per me, ha funzionato meglio. Ma ognuno, una volta capito quanto è importante questo aspetto, può trovare il modo che preferisce per provare a proiettarsi e sperimentare orizzonti e dimensioni inedite per la propria carriera.
Le condizioni materiali rappresentano, infine, la base di ogni scelta di carriera. Più sono solide – e la solidità dipende anche dalle esigenze, dai bisogni e dalle situazioni puntuali in cui ognuno di noi finisce per trovarsi – più la scelta di dare le dimissioni potrà essere vissuta come un atto consapevole, agito e non subìto.