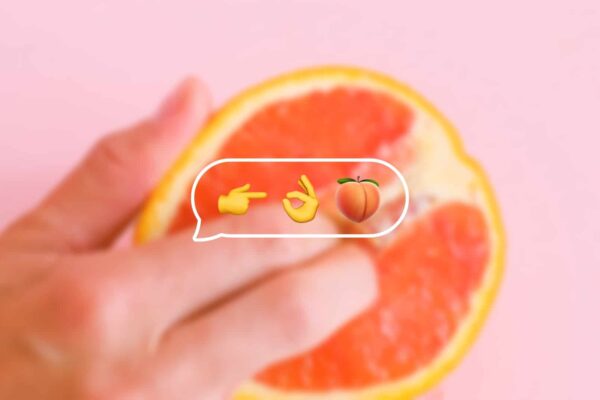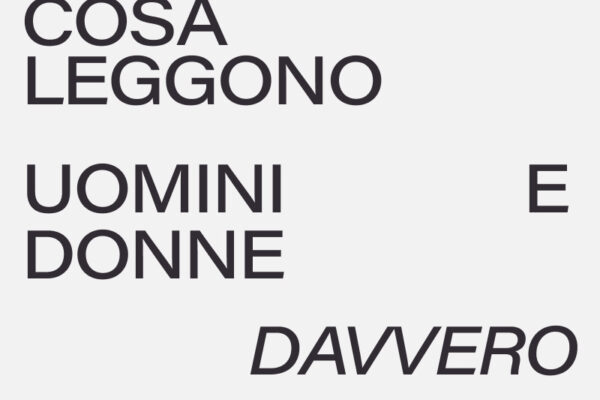Quanto l’attivismo diventò social
Sembra un paradosso, ma è così. Negli ultimi due anni il digitale e, più nello specifico, le piattaforme social hanno dato prova di essere molto di più di un ricettacolo di elementi disordinati. TikTok, secondo i dati di un articolo del Corriere della Sera, tra il 2020 e il 2021 in Italia non solo è cresciuto del 388%, ma ha rivoluzionato in tempi brevissimi le potenzialità del mezzo, facilitando un cambiamento nella comunicazione del cosiddetto “nuovo attivismo”, spesso associato agli adolescenti della Generazione Z.
Gli utenti, attraverso video, dirette e soprattutto challenge sono continuamente stimolati a partecipare e a condividere a loro volta risposte e contenuti che spaziano dalla lotta al razzismo e alla crisi climatica − topic centrale degli #strikers, gli studenti appartenenti al movimento School Strike for Climate, noto anche come Fridays for Future (FFF) − , alla sensibilizzazione nei confronti delle comunità locali, della parità di genere, del linguaggio inclusivo.
Ciò che ha contribuito alla popolarità di questi “info-post”, così come lo stesso Instagram li aveva nominati, è la possibilità di diffondere informazioni a un numero sempre maggiore di utenti, oltre le barriere geografiche e temporali. Fin qui tutto bene. Peccato che il mezzo, benché abbia intenzioni lodevoli e sia stato, in alcuni casi, proficuo nella promozione di alcune tematiche, presenta un difetto strutturale, per cui difficilmente l’attivismo social può trasformarsi in sociale e avere, dunque, una ricaduta nella realtà.
Il filo che lega content creation e slacktivism
Andiamo per gradi. Anzi, per definizioni. Per alcuni il fenomeno viene identificato unicamente nell’espressione slacktivism o “attivismo pigro”, con valenza negativa, mentre per altri nel corrispettivo neutro clicktivism, un’etichetta più ampia che, secondo l’Oxford English Dictionary, significa «l’uso dei social media e altri metodi online al fine di promuovere cause». Se il clicktivism sembra essere dunque un valido alleato dell’attivismo tradizionale, lo slacktivism è, in sostanza, l’uso non impegnato del primo. Eppure, questa differenza non convince.
L’Urban Dictionary, alla voce slacktivism riporta che il fenomeno è «l’idea illusa che mettendo mi piace, condividendo o retwittando qualcosa si stia aiutando». In effetti, come nella comunicazione, la sola intenzione non basta. Occorre verificare che il contesto permetta a me, mittente, non solo di comunicare al meglio il mio messaggio, ma anche che permetta a te, destinatario, di avere tutti gli strumenti per interpretarlo nel modo meno ambiguo e parlare o agire di conseguenza. Il contesto digitale nel quale l’attivismo si manifesta è caratterizzato da una struttura complessa, probabilmente molto più di quella della nostra comunicazione in presenza, e soprattutto non è controllabile. In primis occorre riflettere su chi siamo, o meglio, vogliamo essere, nella rete.
Sulle piattaforme social, l’attivismo potrebbe essere scambiato, senza che ci sia una piena consapevolezza, nel fenomeno più generico quale è stare proprio sulle piattaforme social: prendere in prestito informazioni, riutilizzarle, editarle, fare video e rispondere ai video degli altri.
Non mi sto riferendo solo all’estetica dei profili, ma alla natura della nostra rappresentazione digitale, che per “esistere” ha bisogno di essere continuamente modificata, aggiornata, ampliata, perché influenza la narrazione di chi siamo − si spera solo in rete. Ciò che condividiamo, infatti, sostiene la nostra reputazione, mostrando tutto ciò che ci interessa.
Nell’ambito dell’attivismo è chiaro che, come ben sottolinea la definizione di slacktivism dell’Urban Dictionary, siamo di fronte a un’illusione. Siobhan Mullally, giovane ecologista della School of Environment, Resources and Sustainability (SERS), in un articolo dell’Alternatives Journal, analizza in prima persona cosa significa − realisticamente parlando − essere impegnata online: «Spesso le persone che condividono contenuti contribuiscono alla loro identità di attivista, senza che questa sia seguita da azioni o cambiamenti nell’offiline. […] Anche io ho condiviso molti post su Instagram, aggiungendo commenti, incoraggiando o sfidando le persone a “svegliarsi” su questi problemi perché sostengo la causa e voglio condividerla, ma a volte proprio questo è il limite del mio attivismo. A volte mi ritrovo persino a fare l’opposto di ciò che ho condiviso e sostenuto online. Sono sicura che ci sono state volte in cui ho condiviso un sacco di post sull’importanza di acquistare prodotti locali e stagionali, e poi sono andata al negozio e ho comprato un sacchetto di arance provenienti dalla Spagna. Un’altra volta c’era un post su una crisi in un Paese in via di sviluppo che stava circolando attraverso il mio feed e l’ho condiviso senza effettivamente fare nulla nel concreto, come firmare le petizioni, donare o informarmi ulteriormente sul problema in questione».
Sulle piattaforme social, l’attivismo potrebbe essere scambiato, senza che ci sia una piena consapevolezza, nel fenomeno più generico quale è stare proprio sulle piattaforme social: prendere in prestito informazioni, riutilizzarle, editarle, fare video e rispondere ai video degli altri.

Due fantasmi molto intimi: il bias di conferma e l’algoritmo
Gli aspetti positivi della divulgazione legata all’attivismo online vanno riconosciuti, così come vanno riconosciuti anche i limiti dell’online. Per quanto i profili e le pagine impegnate si facciano portavoce di queste tematiche, è la natura del mezzo digitale a rendere problematica la legittimità delle informazioni condivise.
La disinformazione sui social viaggia infatti più rapidamente rispetto ad altre dimensioni online, non solo per la nostra attività di prosumers, come spiegavo in un mio articolo sulla Hive Mind, ma per una nostra tendenza mentale a ricercare, preferire, ricordare meglio (e dunque condividere) contenuti che supportano e confermano le nostre convinzioni. Questo fantasma che muove i nostri pensieri è conosciuto come bias di conferma.
Niente di nuovo sotto il sole, visto che ne parlava già Francesco Bacone nel suo Novum Organum (1620), nei termini di un “errore” peculiare e ripetitivo che ci fa propendere maggiormente e con più enfasi nei confronti delle affermazioni più che delle negazioni, cioè di quello che contrasta con le nostre idee (spesso pregiudizi). Questa impostazione mentale non riguarda solo gli aspetti dell’attivismo social, ma anche la non governabilità dell’hate speech, per esempio.
Il bias di conferma può essere inteso anche come una sorta di cecità che ci impedisce di osservare i fenomeni da più prospettive. Non meno importante, la sua funzione principale consiste nel preservare la nostra identità (o presunta tale), confermando quelle idee che ci legano a un gruppo sociale. Ecco che l’intenzione del confronto con altre posizioni e proposte sembra crollare già in principio. Anche perché il bias della conferma è rafforzato anche dal modo in cui noi cerchiamo le informazioni nell’ambiente circostante, ricco di dati e stimoli continui che sono guidati da un altro fantasma: l’algoritmo.
Il bias di conferma, che ci rende sempre più incapaci di scontrarci con opinioni diverse dalla nostra, e il meccanismo dell’algoritmo creano in sostanza una magia: un mondo fatto di Io, perfettamente cucito su di esso.
L’espressione filter bubble (“bolla di filtraggio”), ideata (guarda caso) dall’attivista Eli Pariser, fa riferimento agli algoritmi che orientano i contenuti che le piattaforme social ci propongono quotidianamente. La bolla, dunque, è la conseguenza dei sistemi di personalizzazione dei risultati delle ricerche, che offrono sulla piattaforma dell’utente argomenti in linea con quelli con cui di solito interagisce.
Il bias di conferma, che ci rende sempre più incapaci di scontrarci con opinioni diverse dalla nostra, e il meccanismo dell’algoritmo creano in sostanza una magia: un mondo fatto di Io, perfettamente cucito su di esso. Akiko Hemmi e Jim Crowther, autori di uno studio nel 2013 dal titolo Learning Environmental Activism through Social Networking Sites? mettevano in guardia sul fatto che «l’attivismo social non permette di raggiungere il maggior numero di pubblico rispetto alla stampa o ai media digitali a causa di persone che principalmente comunicano con chi fa già a parte della loro rete sociale estesa», come riporta Maëlle Jacqmarcq nel reportage Environmental Activism in the Digital Age.
Questo è dovuto alla “camera d’eco” (in inglese echo chamber), quello che ci accade quando riceviamo una serie di informazioni che rafforzano il nostro punto di vista, senza che ci sia la possibilità di avere accesso ad altre risorse, che, magari di tendenza opposta, potrebbero sviluppare il nostro pensiero critico e/o rendere più obiettiva la nostra idea su un determinato argomento. L’“euristica della coerenza” ci spiega infatti che abbiamo un bisogno innato di rimanere coerenti con le nostre opinioni e con i nostri atteggiamenti mentali. Dato che non possiamo farne a meno nella vita offline, ma possiamo provare a saperne di più, è importante riflettere su come, questa tendenza venga accresciuta nell’online, e su quali sfumature possa assumere ora nell’onlife.