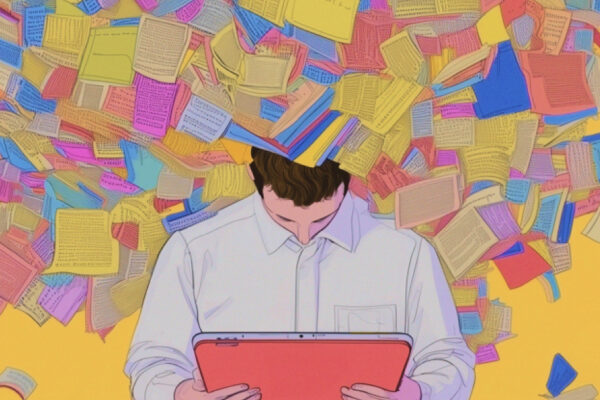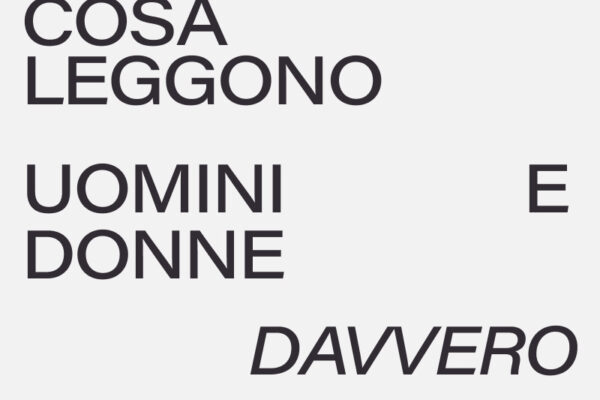A dodici anni David Foster Wallace acquisisce il diritto di guardare la tv da solo. Dall’area di Champaign-Urbana, Illinois, negli Stati Uniti dello scandalo Watergate e di Gola Profonda, che usciva proprio nel 1974, si ricevevano solo quattro stazioni: tre private e una pubblica. Ciò non toglie che David rimanesse seduto sul divano verde di casa sua dalle otto del mattino alle sei di sera, rapito dallo schermo in bianco e nero a guardare episodi di Gli eroi di Hogan, Star Trek, Mistero in galleria. Sabato mattina, cartoni; sabato notte, l’horror di Le creature del brivido. In mancanza d’altro ripiegava sulle soap opera – Sentieri, quella che preferiva – e sui quiz show, soprattutto Ok, il prezzo è giusto. Non che ci sia nulla in comune tra me e uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, ma ricordo il momento in cui mi veniva dato il permesso di vedere la tv senza supervisione con la stessa precisione con cui è descritto in Every love story is a ghost story, la biografia di Wallace scritta dal giornalista statunitense di D. T. Max.
È stato circa trent’anni dopo, in un’Italia anni Duemila dove ancora si guardava la televisione e si dichiarava più o meno fieramente di guardarla, fatta eccezione per gli anti-televisionisti della prima ora, quelli che dicevano di non averne mai posseduta una per ragioni morali, ideologiche o un mix delle due. Ricordo il preserale con i game show, romanzo italiano per eccellenza. Le stagioni infinite di Lost migrate dalla tv on demand alle reti nazionali. I videoclip di Mtv. Poi, soprattutto, la particolare sensazione che si prova nel rapporto uno a uno con lo schermo: una solitudine confortante, uno spazio di familiarità e confidenza per cui, come si legge in Infinite Jest, forse il più grande capolavoro di Wallace, quello schermo non è più “solo qualcosa da guardare”, ma “qualcosa con cui convivere”.
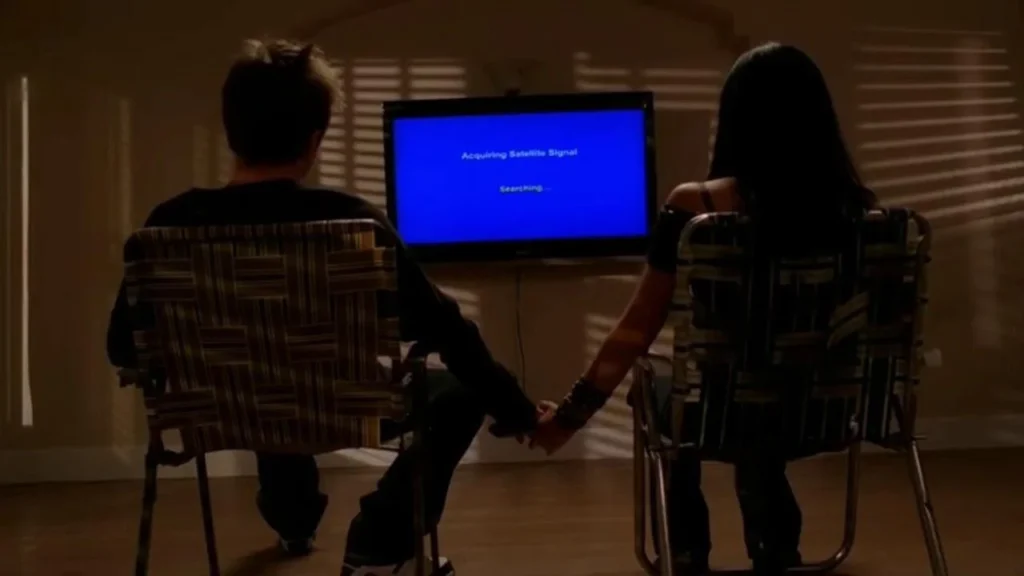
Cent’anni di televisione
Chissà se ne aveva già coscienza cent’anni fa John Logie Baird, considerato l’inventore della tv moderna, di come lo schermo sarebbe diventato il nostro inquilino immancabile, in casa e in testa, il primo passo verso una dipendenza che oggi è talmente comune da sembrare senza tempo. Personaggio bizzarro, che associo a un immaginario un po’ alla serie tv Rick e Morty, prima del successo Baird aveva brevettato le suole che si gonfiano come pneumatici, la lametta da barba in vetro, le calze di carta e un modo per fabbricare i diamanti. Tutte idee che lo avevano per lo più impoverito, fino a che non aveva avuto l’intuizione di provare a inviare un’immagine – pare che la prima fosse quella della croce di Malta – da una stanza all’altra del suo appartamento al 22 Firth Street di Soho, a Londra. A partire da quel primo teletrasporto, nel 1925, nacque l’antenata della televisione che conosciamo oggi. A partire dalla sua distribuzione commerciale, negli anni Trenta, iniziò invece il processo che ci ha portato ad avere schermi in casa, poi in tasca, poi come prolungamento del nostro io; che ha dato nuova forma ai prodotti culturali, e al nostro modo di fruirne, ha cambiato il tempo dello spettacolo e così la nostra vita, la percezione che abbiamo di noi stessi e di ciò che ci circonda. E che continua a farlo oggi, in un momento in cui la tv ancora sopravvive, anche di fronte a chi non si stanca di ribadire la sua fine annunciata.
A partire dalla tv si è generata quella specie di mutazione antropologica per cui abbiamo iniziato a guardare alla tecnologia non come un oggetto tra gli altri, ma come un soggetto che co-abita la nostra esperienza.
Ma da cos’è data l’immortalità della televisione? E cos’ha portato di nuovo questo medium nella storia della cultura? La tv non muore mai, e anzi continua a resistere proprio perché è riuscita mutare, tenendo incollati a guardarla con lo stesso pathos David Foster Wallace, tutti i bambini prodigio raccontati in Infinite Jest, i miei coetanei e me, a decenni di distanza. In questo rapporto potentissimo tra spettatore e schermo, mi sembra ci sia infatti il filo rosso di tutta la storia della comunicazione e dei media, e del suo destino futuro, dato che proprio a partire dalla tv si è generata quella specie di mutazione antropologica, inedita fino ad allora, per cui abbiamo iniziato a guardare alla tecnologia – e in particolare al dispositivo dello schermo – non come un oggetto tra gli altri, ma come un soggetto che co-abita la nostra esperienza, perché partecipa alla nostra vita e allo sguardo che abbiamo su di essa.
Schermofilia
Nei cento anni dalla sua invenzione, la tv si è riempita di contenuti. Ma si è anche moltiplicata, per così dire, in un sistema di diffusione meno preciso e catalogabile, che comprende tutti quegli schermi – Youtube, Google Video, Twitch, le varie tv online dei quotidiani, cosi come Instagram, Tik Tok e gli altri social network – che anche se di per sé non sembrerebbero avere nulla di televisivo, in qualche modo tentano di emularla o si ispirano ad essa – e per questo, non a caso, sono stati di recente integrati nella misurazione dei dati Auditel. Tutti gli schermi con cui ci rapportiamo hanno infatti qualcosa di televisivo, perché hanno imparato dalla tv come avvicinarsi a noi, come diventare sempre più familiari, sempre più nostri.

La prima novità che la televisione ha introdotto nella storia della cultura consiste infatti nel dare allo spettatore la possibilità di appropriarsi dello schermo, che non deve più essere raggiunto in alcun modo perché è sempre a portata di mano e di sguardo. E se fino a qualche decennio fa questa possibilità soddisfava un desiderio di relazione, ovvero quello di far parte del soggetto “pubblico”, guardando contemporaneamente con molte altre persone lo stesso programma, e condividendo quel momento e quell’esperienza insieme a loro nonostante la distanza fisica; oggi le opportunità di connessione offerte dai nuovi ecosistemi digitali sono diventate talmente numerose e varie – post, commenti, reblog, ricondivisioni, chat, dirette streaming, avatar virtuali – da rappresentare una vera e propria condizione della relazione. Questo perché lo schermo è arrivato a rappresentare il primo mediatore del contatto con noi stessi, con l’altro, col mondo.
Siamo ormai molto oltre lo scenario previsto nel saggio E Unibus Pluram, per tornare ancora a Wallace, che aveva previsto con oltre vent’anni di anticipo come nella solitudine della visione individuale ci saremmo abituati a riconoscere proprio nello schermo il canale privilegiato per rapportarci a tutto ciò che ci circonda. A dispetto di quanto previsto dalle narrazioni fantascientifiche, infatti, mi sembra ci stiamo proiettando in una strana post-umanità che non ha scelto di fondersi con la tecnologia attraverso bracci bionici per ottenere la super forza; ma che prova a farlo appunto attraverso lo schermo, rendendolo una sorta di protesi emotiva: primo canale di comunicazione e auto-riflessione, scrigno di emozioni e segreti, catalizzatore di sentimenti sia positivi che negativi, occhio sul mondo – e chissà quante altre cose nel prossimo futuro.
Cosa sono le notifiche, infatti, se non una versione più contemporanea del “restate con noi”?
La tv, da questo punto di vista, è stata senz’altro il primo medium che è riuscito a intromettersi nel nostro spazio personale, permettendo alla circolazione di informazioni e contenuti di avere accesso alla nostra dimensione più intima, di colonizzare i luoghi dell’interiorità in cui eravamo soli e ora non lo siamo più. Ha dato il via, in sostanza, all’invasione mediatica del nostro microcosmo interiore, che oggi viviamo all’ennesima potenza, e ha in qualche modo creato una forma di affezione, un legame emotivo tra noi e lo schermo. Cosa sono le notifiche, infatti, se non una versione più contemporanea del “restate con noi”? Un invito a stare ancora insieme, a con-vivere, direbbe Wallace. Tutti i media dopo la televisione non hanno fatto altro che replicare questo invito, cercando di nutrire l’affetto che ci tiene incollati alle immagini sullo schermo, e che forse – nel bene e nel male – ci fa sentire un po’ meno soli.

Divertirsi da morire sempre
Come sarebbe, se esistesse, una rivisitazione di Blob per i social? Per Instagram, Youtube o TikTok?
Nulla di avanguardistico, per come la vedo io. Probabilmente una replica pressoché identica del programma tradizionale: un flusso di coscienza senza termine e definizione di schegge di interviste, dichiarazioni, monologhi, meditazioni, sketch, opinioni politiche, citazioni letterarie o cinematografiche, esibizioni musicali, jingle, spot, televendite. Il fluire inarrestabile di contenuti che oggi appartiene alla tempesta della comunicazione contemporanea, non è infatti altro che un eredità televisiva. Così come lo è la successione serratissima dei suoi input, che crea quella dimensione di piacere prolungato in cui abbiamo scoperto l’opportunità di “divertirci da morire”, come ha scritto il sociologo statunitense Neil Postman. Una dimensione che negli anni si è espansa, evolvendo nella sfera dell’entertainment continuo, capillare e totalizzante, in cui la possibilità – o forse l’imperativo – è diventata quella di “divertirci sempre” o quanto meno a “intrattenerci sempre”.
La convivenza con lo schermo televisivo è infatti un rapporto che ha tempi larghi, infinitamente estesi. Di qui, la seconda innovazione che la tv ha portato nella storia della cultura, ovvero la vastità indefinita del tempo dello spettacolo, che copre tutte le ore delle nostre giornate – come ha fatto sempre, anche quando la concorrenza per il nostro tempo e la nostra attenzione non era così affollata. La tv e tutti gli schermi che le assomigliano, infatti, non comprendono soltanto quello che vogliamo guardare davvero, ma anche tutto ciò in cui ci imbattiamo per caso, quello che ci fa compagnia, quello che scorre – appunto – mentre siamo concentrati altrove, quello che riempie il nostro tempo vuoto senza troppe pretese.
Quest’epoca di horror vacui è quindi in buona parte causa della tv, dove è nato il flusso senza posa di materiali da guardare che tutti ci travolge e trattiene. Lo spettatore può ancora decidere di ritagliarne soltanto una parte, come faceva accendendo e spegnendo lo schermo con il telecomando, o cambiando canale, e può farlo scrollando fino a raggiungere il video a cui intende dedicare i prossimi quindici secondi. Si tratta certo di un collage di tempi sempre più frammentati, brevi, convulsi, ma va a comporre lo stesso flusso multiforme di contenuti che la televisione ha sempre saputo contenere e governare, come una scatola magica, dandolo poi in prestito a internet, ai social – che da anni utilizziamo per intrattenerci più che per socializzare, come piccole tv portatili –, alle piattaforme, e chissà a quale altro dispositivo futuro.

Come in uno specchio
Ci sono almeno un paio di motivi, allora, per cui continuiamo a fare parte del pubblico televisivo, anche se non abbiamo la tv in casa o non la guardiamo in diretta, anche se pensiamo che non ci interessi più.
“Disprezzare la tv è come rifiutare di guardarsi allo specchio”, ha scritto la critica televisiva statunitense Emily Nussbaum: “Non lo specchio stendhaliano che riflette il cielo blu e le pozzanghere fangose. Ma più qualcosa di simile allo specchio del bagno con la luce sopra, davanti al quale i quindicenni si ispezionano i bicipiti e decidono qual è il loro profilo migliore”.
Sembra l’ennesimo modo per ripetere che “il medium è il messaggio”, ma c’è anche qualcosa di più. Nussbaum fa riferimento alla straordinaria capacità di trasformismo della televisione, che a differenza dei film o dei romanzi non offre l’istantanea di un certo momento storico, di un’esperienza o di un particolare luogo del mondo. O meglio, non solo. La tv è una creatura composita per definizione, un Frankenstein pop che si nutre della trasformazione, cucendosi addosso ritagli di ciò che le scorre intorno. Ed è questo che le permette di riuscire a stare al passo con i cambiamenti di chi in lei si rispecchia, anche a distanza di anni, quando quel quindicenne non vorrà più ammirare i suoi bicipiti ma inizierà a controllarsi rughe e calvizie.
Nel suo essere così incerta, mutevole, mimetica rimane in piedi, forse perché ci ha cambiati più di quanto noi abbiamo cambiato lei.
Nelle sue molte incarnazioni, che dal tubo catodico al registratore digitale arrivano fino all’on demand, alla biblioteca di videotesti allineati, catalogabili e consultabili offertaci dalle piattaforme, o ai palinsesti social, c’è lo spazio virtuale in cui un secolo di spettatori ha potuto trovare rispecchiamento al suo stesso cambiamento, sul piano sia individuale che sociale. Soprattutto, la stessa evoluzione della tv sembra tenere traccia della miriade di processi che hanno reso le nuove tecnologie digitali, e in particolare lo schermo, un pezzo fondamentale nella narrazione del nostro io e del mondo, un elemento ormai imprescindibile della nostra esistenza, perché capace di rispondere a bisogni emotivi per noi fondamentali: quello di uno strumento a cui delegare parte della nostra dimensione emotiva, e che sia in grado di riempire ogni istante della nostra vita.
In questo senso, la televisione è scrittura del tempo che passa, dato che tutto attorno il mondo e il suo pubblico si muovono, ma lei continua ad adattarsi per sopravvivere, trovando sempre nuove forme per interessarci, rispecchiarci, accompagnarci. Nel suo essere così incerta, mutevole, mimetica rimane in piedi, forse perché ci ha cambiati più di quanto noi abbiamo cambiato lei.
O forse perché, nel continuo scorrere delle cose, sa che per resistere non può che accettare di non poterle bloccare.