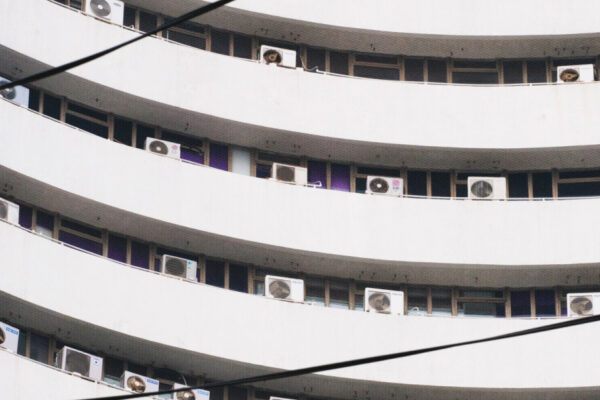«Questo è il cibo del futuro», mi dice il giovane uomo con la tuta verde e la mascherina nera: «Il futuro è già qui». Tiene in mano una confezione di uova, il classico cartone da sei, ma il nome e l’etichetta sbandierano un sostituto di origine 100% vegetale: badabam! Peccato che il tizio non sia un enfant prodige del food tech, founder e CEO di una startup californiana, ma il commesso del supermercato sotto casa mia. Peccato che, quando apro la confezione, il cartone non rivela sei perfette riproduzioni in 3D di uova di gallina, ma un sacchetto pieno di polvere giallina acconciato alla bell’e meglio tra gli alloggiamenti ovali, e un misurino di plastica. Sembra uno di quei meme “aspettative vs realtà”. Il cibo del futuro è già qui? Sì, naturalmente. Ma forse non è come ce lo aspettavamo, o come continuiamo a immaginarlo.
Quando eravamo piccoli, l’immaginario sul cibo del futuro era spaziale, asettico, medicale. Non avremo più bisogno, si diceva, di sederci a tavola, sporcarci, perdere tempo, rischiare la salute: i pasti saranno condensati in una pillola, facile e veloce, incontaminata e perfettamente bilanciata nell’apporto di nutrienti. Il cibo degli astronauti, si pensava, diventerà il cibo di tutti: era una visione intrisa di ottimismo, figlia di un immaginario utopico in cui tutti saremmo diventati astronauti e ci saremmo lanciati nella colonizzazione dello spazio.
Nel giro di pochi anni, questa visione è stata completamente ribaltata: non solo non mangiamo tutti come gli astronauti, ma gli astronauti mangiano come tutti; persino loro si portano dei pezzi di terra lontano dalla Terra, per farci crescere la vita, il cibo.
Si è capito che non possiamo prescindere dal gusto, che la nutrizione non è solo inserimento di carburante, che cibarsi insomma non è solo un dovere, ma anche un piacere: il piacere è il modo che la vita si è inventata per perpetuarsi; se mangiare – così come fare sesso e compiere quelle poche altre funzioni indispensabili – non fosse anche bello, oltre che necessario, non staremmo qui a raccontarcela.
D’altro canto, però, il futuro è arrivato, sotto forma di minaccia: quella solita, la fine del mondo. Siamo sempre di più, e sempre più ricchi, avidi, incontentabili; ma il nostro orto, la Terra a disposizione, è sempre quella, e andare a piantare grano su Marte sembra infattibile nel breve periodo. Soprattutto, mentre cerchiamo il modo di produrre di più, ci rendiamo conto che dovremmo produrre di meno, o se non altro in modo meno impattante: l’industria alimentare contribuisce alla grande, e in una molteplicità di modi, al riscaldamento globale.
Per questo, la ricerca sul cibo del prossimo futuro si sta concentrando sulle proteine, i mattoni della vita come dicono i divulgatori. Produrre e mangiare così tanta carne non è più sostenibile: per l’ambiente, per la salute, per il benessere animale. Servono alternative. Ma quali?
Attualmente il settore più avanzato è quello della plant-based meat: finta carne, principalmente hamburger o salsicce, con prodotti di origine vegetale.
Molte delle opzioni allo studio, o già a scaffale, sono state prese in esame da un libro di qualche anno fa, scritto da Agnese Codignola e intitolato Il destino del cibo (di qualche anno fa poi, è uscito solo a inizio 2020 ma subito dopo c’è stata la pandemia e sembrano due secoli: tra l’altro proprio sulla pandemia c’è un inquietante e profetico passaggio, quando tra i rischi di un’alimentazione troppo basata su prodotti di origine animale nominava i wet market orientali e il salto di specie dei virus…).
È vero che la tecnologia in questo settore ancora più che in generale compie progressi di anni in settimane, ma quel libro continua a essere utile non tanto per i casi concreti che cita e lo stato dell’arte, quanto perché offre una panoramica generale sul vasto ventaglio di alternative. Sgomberando subito il campo da un equivoco: che la sostenibilità alimentare si possa ottenere con soluzioni “naturali” e conservative, per quanto radicali e affascinanti. Per dire, anche se di botto diventassimo tutti quanti vegetariani, cosa impossibile, questo non allevierebbe l’impronta ecologica sul pianeta, anzi forse la aumenterebbe.
E così pure la via indicata Slow Food – mangiare meno carne, di qualità buona, da piccoli allevamenti etici e sostenibili, pagandola il giusto (cioè tanto) – sarebbe, oltre che di difficile percorribilità, nient’affatto decisiva. La tecnologia ci vuole, anzi le tecnologie: perché l’unica alternativa praticabile, è praticarle tutte in parallelo.
Attualmente il settore più avanzato è quello della plant-based meat: finta carne, principalmente hamburger o salsicce, con prodotti di origine vegetale. La maggiore differenza con i würstel di soia e gli spezzatini di seitan che ricordiamo dagli anni zero, è che questi prodotti tentano di sostituirsi alla carne non solo dal punto di vista nutrizionale ma anche da quello dell’aspetto, e del gusto: polpette sanguinolente e tenere ma resistenti al morso, questo lo standard, l’obiettivo, il benchmark. Avanzato perché ormai si trovano dappertutto, a partire dai supermercati: prodotti non solo dalle startup nate appositamente per l’obiettivo e ora diventate colossi, come Impossible e Beyond Meat, ma anche da marchi storici come Findus e Nestlé, che ci si stanno buttando. Così come si trovano nelle catene internazionali del fast food: McDonald’s da qualche mese ha messo sul mercato McPlant, realizzato da Beyond, e dice che è andato ancora meglio delle aspettative; Burger King collabora con The Vegetarian Butcher e ha addirittura creato un punto vendita totalmente privo di carne, una cosa storica per un business che mette la carne al centro. Insomma i big hanno fiutato l’affare e stanno investendo come solo loro possono.
E non c’è solo la carne: i ricercatori e le aziende stanno ampliando l’offerta dei sostituti a tutti i prodotti animali, partendo da latte e uova (più facili da imitare per la loro consistenza liquida), e arrivando a salmone, tonno (già c’era quello sottolio di Nestlé, ora arriva quello crudo nella bowl di Poke House), gamberi, seppie, caviale, granchi.
La “carne vegetale”, però, è tutt’altro che priva di problemi: anzi si può dire che tra tutte le proteine alternative è quella più problematica. Per esempio per creare il tanto ambito “effetto sangue” spesso si usa l’eme, una proteina prodotta con un metodo che coinvolge OGM (e questo è il motivo per cui l’hamburger di Impossible non viene commerciato in Europa). Ma in generale perché, per ottenere l’effetto visivo/gustativo della carne, si è un po’ persa di vista la sostanza, e questi hamburger sono cibi ultraprocessati e poco nutrienti. Pieni di addensanti e coloranti, carichi di ingredienti poco salutari come sali e zuccheri, e anche se pari o quasi come apporto di proteine, decisamente perdenti quando il confronto va sui grassi e sui carboidrati.
Secondo l’ultimo rapporto della FAO, nel mondo 800 milioni di persone, il 10% del totale, soffrono la fame.
Le carni del futuro però non sono tutte uguali: la summa divisio anzi vede opporsi due tipologie proprio agli antipodi, perché dall’altra parte della fake meat c’è la cosiddetta clean meat, o carne coltivata. Si tratta di carne vera, in un certo senso, ma ottenuta con un metodo cruelty-free: vengono prelevate delle cellule da un animale vivo, e poi messe a riprodursi in laboratorio fino a ottenere una quantità sufficiente. Sa di carne, dice chi l’ha assaggiata, perché in effetti è carne: ma anche qui il problema sta nel raggiungere determinate consistenze e varietà, perché è facile fare polpette o hamburger (o anche creme e patè, tanto che una delle cose migliori è l’alternativa al foie gras, cibo tanto raffinato quanto crudele), più complicato è ricreare il grasso intramuscolare, i tessuti connettivi, le ossa.
Ma comunque, ci stanno lavorando. E anche qui, estendendo il dominio del lab-grown ben oltre la carne bovina o il pollame: dall’astice al granchio, per finire con prodotti che sostituti non sono ma vere e proprie fughe in avanti nella fantascienza, perché chi ha mai mangiato o sentito il bisogno di mangiare la bistecca di leone o il sushi di zebra?
Sembra una cosa grandiosa, la carne in laboratorio: inattaccabile dal punto di vista etico e da quello ambientale, perfetta dal punto di vista gustativo e nutrizionale. Però anche qui vediamo la discrepanza tra aspettative e realtà, anzi da qui in poi la crepa si allarga fino a diventare voragine. Attualmente la carne in laboratorio è accessibile al pubblico in una sola nazione al mondo: la piccola seppur avanzatissima Singapore. E per un solo prodotto, la carne di pollo realizzata da Eat Just, cui da qualche mese se n’è aggiunto un altro, sempre a base pollo. In tutto il resto del pianeta, per ora sono solo chiacchiere.
Adesso la vulgata che sta passando è questa: gli ostacoli alla messa in commercio di questi cibi sono relativi alla reazione del pubblico, che non sembra totalmente pronto ad accettare la carne coltivata; ma anche e soprattutto alle regolamentazioni dei vari paesi in materia alimentare, che prevedono procedure lunghe e complesse per accogliere un cibo così nuovo.
La scalabilità è raggiunta, dicono gli alfieri della lab-grown meat, che annunciano ogni giorno un altro round di finanziamenti, o un altro passo in avanti in laboratorio: la barriera adesso è solo la maledetta burocrazia.
«Beh, non è proprio così, anzi non lo è per niente», mi dice Mario Ubiali, fondatore e CEO di Thimus, innovativa azienda che aiuta i produttori alimentari a mettere a punto i cibi del futuro, inventandoli da zero o migliorando quelli esistenti, attraverso una molteplicità di strumenti sia scientifici sia culturali. «La scalabilità, ovvero la possibilità di produrre carne in quantità tali che abbia un senso immetterla sul mercato, e a un costo competitivo, è tutt’altro che raggiunta. Abbiamo parlato con varie startup, soprattutto californiane, e ci hanno detto che quest’anno a stento produrranno dieci, quindici bistecche. E le daranno tutte agli investitori» che dal canto loro continuano a crederc, dai fondi specializzati ai nomi in vista come Leonardo DiCaprio e Bill Gates, puntando miliardi di dollari su questo numero.
Cibo del futuro, o bolla destinata a scoppiare?
Una terza via tra plant-based e lab-grown in realtà ci sarebbe, e si chiama fermentazione di precisione. I cibi vengono “costruiti” in bioreattori che sfruttano le capacità fermentative e trasformative di microrganismi, come batteri e lieviti. Se vi sembra una pericolosa operazione alchemica o una diavoleria hi tech, beh considerate che è un po’ quello che succede da millenni quando dall’uva creiamo il vino, o dall’orzo la birra. Ma qui ovviamente si tratta di produrre molto altro, cibi o ingredienti per preparazioni più complesse: per esempio un latte di mucca senza mucche, dove l’elemento di partenza non è neanche un piccolo gruppo di cellule, ma un frammento di DNA dell’animale.
Anche qui ci sono lati oscuri e costi esternalizzati, cioè scaricati sulla collettività. Mi racconta sempre Ubiali: «Di recente ero a un convegno sul tema, e a un certo punto uno scienziato di una certa età si è alzato e ha chiesto: scusate ma avete calcolato quanta CO2 verrebbe prodotta se la fermentazione di precisione venisse usata in maniera massiccia? Perché facciamo tanto per ridurre l’inquinamento da allevamenti animali, e poi immettiamo altri gas serra nell’atmosfera! La domanda è caduta in un silenzio stupefatto».
D’altra parte c’è chi prova a ribaltare completamente il tavolo e creare proteine dall’anidride carbonica stessa: sarebbe come prendere due piccioni con una fava, eliminando le emissioni inquinanti e trasformandole in cibo (anche se in realtà la CO2 sarebbe il nutrimento dei microrganismi che poi ammassati in grande quantità costituirebbero la base proteica da inserire in altri cibi, ma non stiamo a sottilizzare).
La verità è che, come si diceva all’inizio, non sarà tanto un metodo a prevalere sugli altri, ma andranno avanti in parallelo. O in sovrapposizione: uno dei trend del 2022 nell’ambito delle proteine alternative dovrebbe essere la creazione di cibi con proteine di fonte diversa. Ad esempio una base vegetale nella quale vengono innestate cellule coltivate in laboratorio. O anche una parte animale e una parte vegetale: che può sembrare un controsenso ma non lo è, considerando innanzitutto che lo scopo è quello di ridurre la carne consumata e quindi prodotta, per cui anche il taglio di una percentuale in una ricetta fa la sua parte. E poi bisogna tener conto che tutte queste alternative non si rivolgono a chi ha già fatto una scelta vegetariana o flexitariana, ma a chi vorrebbe farla e non riesce a portarla avanti in maniera rigorosa, per motivazioni deboli o difficoltà pratiche: anche in questo caso, poco è meglio di niente.
La salsiccia ungherese che sto assaggiando in questo momento, infatti, non è completamente priva di carne, ma ha una percentuale di proteine vegetali. Che percentuale, e che tipo di proteine, non posso saperlo: perché sono qui, nella sede di Thimus, per fare un panel di analisi sensoriale insieme ad altre persone, ovvero un assaggio alla cieca in cui dobbiamo descrivere le sensazioni gustative secondo precisi parametri.
Non solo soggettivi, perché la seduta prevede che ci attacchino dei sensori alla testa per effettuare un elettroencefalogramma, ma anche alle mascelle. I salamini che assaggiamo sono ben lungi dalla perfezione, ma quello che è interessante è il metodo che usa Thimus. Come mi spiega Ubiali, lo scopo è quello di integrare neuroscienze e dati culturali, sociali, umani, psicologici: per questo il progetto cui abbiamo partecipato ha previsto, prima ancora dell’elaborazione di una ricetta, una ricerca sul campo a proposito di abitudini alimentari e di rapporto con il cibo delle popolazioni coinvolte.
Le posizioni più avanzate, tutto sommato, mi sembrano proprio quelle che non si fanno prendere la mano dall’accelerazione tecnologica pura. Per esempio, la fissa dell’imitazione: quando la smetteremo di rincorrere la mimesi, si chiede un articolo su Food Navigator, e sostituiremo le verdure che sembrano carne con le verdure che sembrano… verdure? Una strada che alcuni stanno già iniziando a percorrere: proteine alternative che magari al palato sanno di carne, ma non vogliono ingannare l’occhio.
Alternative alle alternative: è questo il prossimo passo verso il futuro del cibo? Per esempio molti lavorano sulle micoproteine: non si tratta di una bistecca di funghi, ma di una sottospecie di fermentazione di precisione.
Alla fine del giro, sembra paradossale ma dobbiamo tornare ad attingere al regno animale. Anche se si tratta di animali del tutto particolari: gli insetti. Sono loro, anche loro, che di tanto in tanto vengono acclamati come l’alimento del futuro. E d’altra parte tra tutti sono forse il più difficile da accettare. Non vale osservare che da molti punti di vista tra un grillo e un gamberetto ci sono davvero poche differenze. Non vale ricordare che nel mondo gli insetti vengono tradizionalmente consumati in 130 paesi da circa 2 miliardi di persone. Eppure piano piano, almeno dal punto di vista normativo, gli insetti si stanno facendo strada anche sulle tavole europee: l’ultimo autorizzato dall’EFSA, l’ente Ue sulla sicurezza alimentare, è proprio il grillo, il primo era stato – neanche un anno fa – la tarma della farina, seguita dalla locusta migratoria.
Anche qui, come recita il nostro mantra, dobbiamo distinguere tra aspettative (in questo caso, piuttosto, timori) e realtà. Ci immaginiamo zuppe di scarafaggi brulicanti o scorpioni mangiati vivi come si vede in certi documentari sui mercati asiatici; ma quello che nel 90% dei casi arriverà, saranno farine e altri sottoprodotti inseriti come ingredienti in cibi processati, e completamente indistinguibili non solo alla vista ma anche al gusto. Il che può essere un bene eh, ma ancora una volta: dove diavolo sta questo futuro strabiliante che ci avevate promesso?
In tutto questo, il discorso sul cibo di domani e sul domani del cibo – come il realtà qualsiasi discorso che ruota attorno all’alimentazione – non può e non deve prescindere da una realtà assodata ma non meno agghiacciante: secondo l’ultimo rapporto della FAO, nel mondo 800 milioni di persone, il 10% del totale, soffrono la fame. E negli ultimi anni il numero non è diminuito come si potrebbe credere, anzi è tornato a salire.
La vera discrepanza non sta tanto tra l’hipster engagé che si dirige verso le proteine alternative e il cafone inconsapevole che continua ad abbuffarsi di pollo d’allevamento pompato di ormoni, quanto tra chi è in grado di mettere un piatto a tavola tutti i giorni, e chi no.
Il futuro è già qui, diceva il profeta del cyberpunk William Gibson negli anni Ottanta, solo che non è equamente distribuito. E a quanto pare non lo è mai stato. Resta da vedere se potrà diventarlo in, ops, futuro.