Pubblichiamo un estratto da “Come annoiarsi meglio” di Pietro Minto, pubblicato per Blackie Edizioni. Ringraziamo l’autore e l’editore per la gentile concessione.

È facile associare la Fomo a un evento di gala o una festa esclusiva, ma la sua presenza è rilevabile anche nelle attività meno piacevoli e glamour, persino quelle che siamo costretti a svolgere per sopravvivere. Un posto migliore, una posizione aperta, l’ambizione di una ral ben diversa: sono tutte occasioni in cui quanto successo al Fyre Festival avviene, in versione ridotta e intima, nelle vite di ciascuno di noi. Le forze in gioco sono le stesse: l’ansia, il timore di rimanere indietro, di essere rifiutati, la frustrazione per i successi altrui che spinge a ulteriori sacrifici. Volendo perlustrare il nostro rapporto con il tempo, poi, sarebbe assurdo non parlare di lavoro e del suo indotto emozionale: i luoghi di lavoro, gli spostamenti per recarsi al lavoro, la gerarchia sociale su cui esso si basa. È qui che si annidano i sentimenti e i malesseri più scuri e intensi, dalla depressione all’ansia, passando ovviamente per la noia.
Le pareti, la macchina del caffè, i divisori negli uffici vecchio stile o la loro totale assenza nei moderni open space, i colleghi della stanza accanto, le pause pranzo e le riunioni interminabili, le sfuriate del capo e il traffico del tardo pomeriggio. Ci sono immagini mentali che magicamente sono in grado di immergere chi le vive in un momento preciso, come fossero un casco per la realtà virtuale: a me, per esempio, basta immaginare un ufficio a cubicoli in stile anni settanta, quelli del fumetto Dilbert o di The Office, per essere sbranato dai demoni della noia e trasformarmi in Folagra, l’impiegato comunista che radicalizza Fantozzi nel primo film della saga, pronto a rovesciare scrivanie e divisori.

Ognuno di noi ha il proprio rapporto con il lavoro, che è in costante evoluzione. La somma di queste fluttuanti esperienze poggia sul tessuto socioeconomico, storico si potrebbe dire, che cambia e influenza le nostre giornate di lavoro. Nel momento in cui scrivo parlare dello stato del lavoro pare quasi una provocazione, un controsenso, un’operazione assurda come ristrutturare un tinello nel mezzo di un’inondazione: puoi anche avere un’idea geniale, ma dovrai aspettare un bel po’ prima di capire se è ancora realizzabile. Cosa è successo al lavoro – ai lavoratori e alle lavoratrici – a partire dal fatidico marzo 2020, quando la pandemia da Covid-19 è esplosa in Europa? Non è compito di questo libro affrontare anche solo di striscio questa domanda, ma è doveroso segnalare come tutti i problemi affrontati finora – l’attenzione, gli schermi, la Fomo, l’erosione del tempo libero – esistessero da prima del Covid e siano stati fatti brillare dalle sue conseguenze. Milioni di persone sono state costrette allo smart working e a ridiscutere i confini tra vita personale e professionale, tra intimo e privato, intervallando videochiamate tra amici alle riunioni su Zoom con i colleghi, mentre le mansioni lavorative non incontravano più limiti e confini, spargendosi in tutta la casa.
A soffrire di più sono state le donne di ogni età. Il tema dell’occupazione femminile, come tutti i fenomeni legati alla pandemia, era preesistente e già preoccupante da tempo, specie in Italia: secondo i dati di Eurostat relativi al 2019 – prima che Wuhan diventasse una nota località anche in Occidente, insomma – da noi solo il 56,2% delle donne tra i 15 e i 64 anni risultavano impiegate, contro una media del 68,3% dell’Unione Europea. Il divario d’occupazione tra maschi e femmine era del 19%, il più alto del Continente dopo quello di Malta.
Ognuno di noi ha il proprio rapporto con il lavoro, che è in costante evoluzione. La somma di queste fluttuanti esperienze poggia sul tessuto socioeconomico, storico si potrebbe dire, che cambia e influenza le nostre giornate di lavoro.
Post-lavoro e reddito universale di base, digitalizzazione e robotizzazione del lavoro
Allo stesso tempo, l’Italia soffre di una cronica debolezza demografica, con un tasso di natalità in continua discesa. Da un report dell’istat del luglio 2020 relativo all’anno precedente si hanno conferme dello svuotamento demografico, perlopiù al Centro-Sud, solo parzialmente bilanciato dalla crescente popolazione straniera. Lo so che lo sapete già, ma ripeterlo non fa di certo male: alla pandemia possiamo imputare tante, tantissime tragedie e problemi, ma non va trasformata nella chiave per l’assoluzione totale, l’alibi perfetto per decenni di malapolitica, il più cornuto dei capri espiatori. Le principali vittime dell’infame anno sono state quindi loro, le donne lavoratrici e professioniste, che, senza una scuola dove mandare la prole, hanno dovuto abbandonare – più o meno gradualmente – il lavoro, in caso lo avessero. Un ritorno agli anni cinquanta avvenuto in poche settimane, un baratro dal quale un Paese rattrappito come il nostro – pronto al Family Day quando sorge la minaccia delle unioni civili, ma incapace di investire su chi fa una famiglia – avrà difficoltà a risalire.
Si suol dire che ogni pandemia funga da acceleratore storico, un enorme frullatore cosmico che può trasformare elementi, ma non crearli dal nulla: a questo ci pensiamo noi. A tal proposito va ricordato che da qualche anno il concetto stesso di lavoro era stato messo in discussione. In un articolo pubblicato nel 2018 dal Guardian, il giornalista Andy Beckett scriveva del cosiddetto «post-lavoro», uno stadio della società in cui il lavoro-per-come-lo-abbiamo-conosciuto scomparirà:
Il lavoro è sempre più precario: più contratti a zero ore o a tempo determinato; più liberi professionisti con entrate variabili; più «ristrutturazioni» aziendali per quelli con lavori veri.
Come fonte di aumenti sostenibili di consumatori e di proprietà immobiliari di massa – i successi principali della politica economica occidentale mainstream per gran parte del ventesimo secolo – il lavoro è screditato quotidianamente dal debito crescente e le crisi immobiliari. Per molte persone, non solo i più ricchi, il lavoro è diventato meno importante finanziariamente che ereditare un patrimonio o possedere una casa.
Secondo i suoi teorici, il post-lavoro porterà con sé una forma di universal basic income, un reddito universale di base che ciascun cittadino riceverebbe dallo Stato, sopperendo alla necessità di trovarsi un lavoro. In questo scenario la digitalizzazione e la robotizzazione avranno reso obsoleti la maggior parte dei mestieri, sostituendo cassiere, operai, meccanici, magazzinieri con macchine e programmi informatici; non solo, grazie al progresso delle intelligenze artificiali e delle reti neurali, anche professioni più specializzate saranno a rischio (operatori di borsa, scienziati, ingegneri, avvocati e giornalisti). Il post-lavoro sembra inevitabile, e ancora una volta è stata la pandemia a spingere alcuni governi ad avventurarsi in esperimenti temporanei, come l’assegno da 1200 dollari recapitato nell’aprile del 2020 ai cittadini americani, o il programma di sussidi – fino a 1.015 euro – deciso nel luglio dello stesso anno dal governo spagnolo. Secondo l’indagine «Europe’s Stories» dell’università di Oxford, su dodicimila persone intervistate nell’Unione Europea e nel Regno Unito, il 71% del campione ritiene che «lo Stato dovrebbe dare un reddito base».
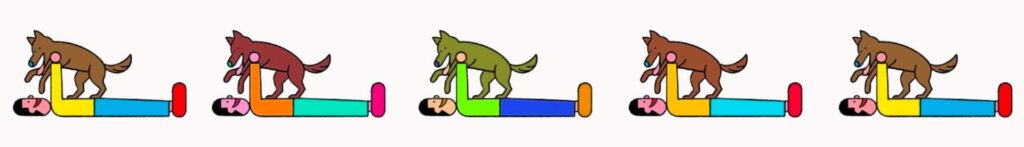
Confinato in casa, con o senza lavoro, in cassa integrazione o in malattia, oppure in smart working, il mondo ha fatto i conti con un futuro d’un tratto vicino, in cui il lavoro smette di essere indispensabile e ognuno è responsabile di sé e del proprio tempo. Basta poco per calcolare l’impatto del post-lavoro in una civiltà come quella umana, in cui ovunque, da sempre, le persone si sono distinte perlopiù per la loro mansione. I cognomi più diffusi sono quello, dopotutto: lavori. Ferro, Ferrante, Fabbri in italiano; Smith (fabbro) in inglese; Schumacher (calzolaio) in tedesco.
Una volta «perso» il lavoro, come ci distingueremo? Quali saranno le caratteristiche su cui fonderemo la società del futuro? È un panorama troppo vasto per essere incluso in questo libercolo pro-noia, ma è da questo che dobbiamo partire per immaginare il nostro rapporto con il tempo e la sua possibile evoluzione.
Non è di certo una novità che il lavoro cambi, trascinando con sé società, cultura e persino la religione. La società di massa si è accompagnata all’industrializzazione e all’urbanizzazione, generando un effetto valanga che ha stravolto, in un arco temporale relativamente breve, usi e costumi. Lo studioso americano Robert Levine ha descritto come lo scorrere del tempo sia in continuo cambiamento e come abbia ritmi particolarmente sfrenati in città. Il movimento verso i grandi centri sconvolse il rapporto con il tempo di milioni di persone, ammassate in luoghi ristretti e densi, premendo sull’elastica superficie del nostro spazio-tempo. «Per noi il tempo puro non esiste», scrive il fisico e filosofo Stefan Klein. «Noi percepiamo il tempo solo quando accade qualcosa».
Una volta «perso» il lavoro, come ci distingueremo? Quali saranno le caratteristiche su cui fonderemo la società del futuro? È un panorama troppo vasto per essere incluso in questo libercolo pro-noia, ma è da questo che dobbiamo partire per immaginare il nostro rapporto con il tempo e la sua possibile evoluzione.
A questo punto, però, sorge un atroce sospetto. E se nonostante tutto, e dico proprio tutto quello che è successo negli ultimi anni, rimanessimo comunque dei privilegiati rispetto ai nostri antenati? Sempre meglio la nostra condizione precaria e sottopagata di quella della gente del Medioevo, giusto? E poi: non sarebbe miope dimenticare quanto la condizione umana (occidentale) sia migliorata anche solo negli ultimi cinquant’anni? Di questi tempi, è una consolazione come un’altra. Ma a ben guardare, non è così vero come sembra: quando pensiamo al lavoratore del passato, ci vengono in mente l’operaio tessile dell’Inghilterra dell’Ottocento, la Prima e la Seconda rivoluzione industriale, il carbone, il fumo di Londra. Oppure, balzando ancora all’indietro le gilde di artigiani, i servi della gleba. Sono riduzioni, ovviamente, immagini stereotipate come quelle del Medioevo buio, in cui tutti stavano malissimo, pioveva sempre e se non fosse stata la guerra a ucciderti ci avrebbe pensato una banale polmonite.
Questa visione plumbea di quel millennio è figlia dell’Illuminismo, che nel Settecento mise in discussione il passato e lo ridusse a macchietta apocalittica: furono gli illuministi, insomma, a rovinare la reputazione del Medioevo per sottolineare le portentose promesse della nuova età dei lumi. Il futuro era luminoso; il passato, pieno di urla e fame. È toccato agli storici e storiografi moderni e contemporanei l’onere di ricostruire un quadro più giusto del Medioevo, e in generale del mondo pre-illuminista. Per quanto riguarda il lavoro, per esempio, la vita del servo della gleba non era quel mix di miseria e disperazione che ci immaginiamo. Secondo Juliet B. Schor nell’Inghilterra del Cinquecento era «molto insolito» che un lavoratore lavorasse per un giorno intero il campo di un Lord: «Una giornata di lavoro durava mezza giornata e se un servo lavorava un giorno intero, veniva contato come due “giornate di lavoro”».

Certo, il lavoro nei campi è fisicamente più duro di una giornata in ufficio. Ma i tempi, da allora, sono cambiati. Ancora oggi, è certo, esistono lavori di fatica, senza contare le pressioni sociali e culturali a cui è sottoposto anche il ceto impiegatizio: lavorare mezza giornata nei campi distrugge il fisico, ma, osservato nel suo insieme, è davvero più duro di un turno in un magazzino Amazon, o in un centro commerciale, o in una fabbrica, o, se ci concentriamo sullo stato mentale dei lavoratori, in un maledetto ufficio popolato da persone che si detestano? E soprattutto, e qui veniamo al cuore della faccenda: vogliamo davvero accontentarci di stare lievemente meglio di uno zappatore dell’anno Mille? Si sono davvero ridotte a questo le nostre ambizioni?
Sarò un ottimista, ma io cercherei di volare più alto degli standard dell’Alto Medioevo, cercando una strada migliore per lavoratori e lavoratrici. Per questo, parlando di lavoro nel xxi secolo, dobbiamo abbandonare l’Illuminismo e i campi di barbabietole per trasferirci in un ufficio qualunque. L’ufficio è il cuore di un annoso problema economico, culturale, sociale e psicologico: quello dell’annichilente noia vissuta e subita dai milioni di persone che vi lavorano ogni giorno. Di tanto in tanto, qualche imprenditore ottimista e ingenuo pensa di risolvere la questione con un nuovo arredamento, un’allegra pianta, o l’adozione del formato open space, che «fa tanto startup». Sono soluzioni parziali e disperate, cerotti con cui si prova a riparare colossali dighe crepate da ormai decenni. Per tutte queste ragioni, l’ufficio è la piastra di Petri perfetta per osservare complessi stati d’animo quali la noia e i suoi principali satelliti: frustrazione, ansia, tristezza…










