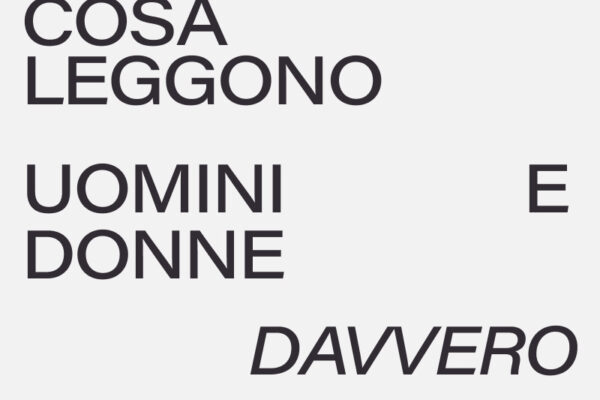Mi piace pensare che esista, in un mondo disarmonico e smembrato come il nostro, qualcuno che riesca a trovare una sinistra e crudele sintonia tra la letteratura e i personaggi esistenti sui social media, gli influencer.
Sebbene possa sembrare un paragone vagamente azzardato, dobbiamo pensare a come ci piaccia venire cullati dalla voce di un personaggio finzionale in modo tale da abbandonarci completamente alla sua verità: non accade forse lo stesso meccanismo aprendo Instagram?
Il nostro pollice scorre sul vetro dello schermo e davanti ai nostri occhi appaiono volti truccati, filtrati, sentiamo voci a cui decidiamo, volontariamente, di credere. Ma qualcosa, nel conturbante ingranaggio di fiducia che lega l’utente a queste figure sta cambiando, come se pigramente qualcuno avesse deciso di cambiare canale poiché quello di prima stesse diventando troppo attinente all’idea che abbiamo di esso.
Com’è possibile, ci chiediamo. Ebbene, dobbiamo pensare a un livello di saturazione talmente alto da averci traghettato – come se fossimo divenuti i Caronte di noi stessi – verso la nascita dei fictional influencer.
L’idea nasce da un’azienda statunitense, co-creata dallo sceneggiatore Ilan Benjamin, che oggi vanta la produzione di ben 22 personaggi finzionali. Se cerchiamo il sito web dell’azienda, veniamo subito indirizzati a una pagina su cui campeggia la scritta meet our characters: cliccando sul link, ci appare una lista di fictional influencer che possiamo iniziare a seguire.
L’unico social media in cui poterlo fare è, inutile dirlo, TikTok: l’app ha infatti raggiunto il miliardo di utenti nel 2021, con una crescita che, in Italia, ha visto il numero di utenti triplicare nell’ultimo anno e con una schiacciante maggioranza di consumatori appartenenti alla Gen Z attivi sull’app.
I fictional influencer seguono storyline delineate da un team di scrittori e sceneggiatori. Sui loro profili social viene esplicitato il carattere fittizio del personaggio che interpretano, ma questo non impedisce gli utenti di seguirli e instaurare un legame con loro.
Ma facciamo un passo indietro. L’esca è stata lanciata a marzo 2021 tramite la creazione e la condivisione del primo video di Tia, una ragazza il cui arco narrativo consiste nella scoperta della discendenza monarchica del suo ex ragazzo.
Pochi mesi più tardi, alcune testate inglesi e americane hanno pubblicato una serie di articoli riprendendo un video diventato virale su TikTok in cui una ragazza bionda, Sydney, elencava le red flag da evitare assolutamente nelle dating app.
La storia era particolarmente interessante perché Sydney affermava di essere impiegata al customer care di uno di questi servizi, lavoro durante il quale si trovava spesso a dover analizzare i profili di centinaia di utenti, accorgendosi quindi dei campanelli d’allarme presenti in molti di questi.
Sydney e Tia, però, non esistono realmente, ma solo nella rappresentazione virtuale su TikTok e nell’universo metanarrativo contenuto in esso. In realtà, si tratta di attrici pagate dall’azienda per mettere in scena uno script.
Nell’universo di FourFront c’è anche Ollie, un ragazzo trans; Billy, un fuckboy della finanza e Carmen, sugar baby. Ognuno di loro ha delle storyline delineate da un team di scrittori e sceneggiatori, mentre sui loro profili social viene esplicitato il carattere fittizio del personaggio che interpretano.
A quanto pare, però, la finzione delle loro storie non impedisce agli utenti di seguirli. Tutt’altro: i commenti sotto i loro contenuti sono gli stessi che potremmo trovare in un qualsiasi altro video su TikTok, in cui ci sono reazioni, esperienze vissute dall’utente e osservazioni condite con emojii.
L’azienda stessa incoraggia a stringere un rapporto più stretto con i propri personaggi, invitando l’utente a scrivere, tramite un’app di messaggistica, al fictional influencer preferito: a rispondere, però, non sarà neanche l’attore o l’attrice, ma un’intelligenza artificiale specializzata nella produzione di testi, la GP3-T.
I dati collezionati dall’azienda sugli utenti che interagiscono con i fiction influencer non vengono venduti a terzi, ma utilizzati per incrementare il valore di realtà dei propri personaggi, attingendo dalle storie condivise dagli utenti stessi per creare storyline sempre più realistiche e coinvolgenti.
Qui accade, infatti, qualcosa di inaspettato: nonostante l’utente sia a conoscenza dell’artificiosità connaturata al personaggio – personaggio, e non persona -, secondo una statistica fornita dalla FourFront, quasi il 50 % degli utenti hanno deciso spontaneamente di condividere con un personaggio fittizio i propri dati intimi e privati.

Le vetrine digitali sono uno spazio claustrofobico: disponibili in una quantità pressoché illimitata, hanno a disposizione, peraltro, un pubblico ininterrottamente presente, richiedendo agli influencer una performance sostanzialmente autogenerativa, costante.
Trovo, in una maniera ai limiti dell’inquietante, quasi positiva l’idea che un attore professionista venga pagato per veicolare dei presunti valori all’interno di contenuti online: la sottile rassicurazione che il suo carattere artificiale differisce dalla persona che un brand ha accuratamente ricucito su sé stessa.
L’aderenza alla realtà richiesta dagli utenti, a ciò che si presuppone una persona pensi davvero, è, a mio parere, uno dei più grossi errori commessi: l’autenticità online non esiste, nella misura in cui nelle vite di tutti i giorni non esiste autenticità – in un certo senso, abbiamo introiettato, anche se sarebbe meglio dire, proiettato sui social media questo desiderio di performare secondo dei canoni ritenuti attraenti dagli altri.
Il fictional influencer, invece, è stato creato appositamente da un team di scrittori professionisti il cui lavoro consiste esattamente nel dar vita ad un personaggio più likable possibile – e dunque anche piatto. La performance attuata dagli influencer finora – quella di spostarsi sul sottile filo del rasoio tra l’essere un oggetto votato al desiderio aspirazionale e dunque totalmente inautentico – è stata così ottimale da poter venire sostanzialmente replicata. Imparare a riconoscere l’autoillusione che questo meccanismo porta con sé: questo, forse, potrebbe essere uno degli insegnamenti che potremmo ricavare dalla nascita dei fictional influencers.
Come nella fiaba di Borges, in cui i cartografi incaricati dal re costruiscono una mappa così fedele alla sua rappresentazione da corrispondere perfettamente all’Impero stesso – causandone la distruzione – così la costruzione dei fictional influencer fa vacillare l’utente, il quale inizialmente sovrapporrà rappresentazione e realtà, per poi accettare l’inevitabile sopravvento del modello.
Secondo uno studio dell’Università di San Diego, la pandemia ha risemantizzato l’attaccamento emotivo verso fictional characters e influencers, rendendolo pressoché uguale a quello provato per un essere umano in carne ed ossa.
Questa relazione viene chiamata parasocialità: la relazione non deve essere vista come necessariamente negativa, poiché condurrebbe l’individuo a un accrescimento emotivo e potrebbe veicolare dei contenuti ritenuti positivi. Insomma, è indubbio che la pandemia abbia sfocato i contorni tra sociale e parasociale: il tempo che investiamo attivamente nella visione di contenuti – serie tv, film, video su TikTok, stories su Instagram, contenuti, didascalie – annebbia la distinzione tra reale e irreale, in una maniera, delle volte, a dir poco perturbante.
L’intimità riservata solitamente a partner ed amici – come puntualizza Marlowe Granados – su TikTok viene alterata, nella misura in cui a qualsiasi utente è possibile entrare in contatto con essa. Il linguaggio stesso dell’app – essere perennemente posti di fronte alla fotocamera, senza filtri – permette a questo social media di apparire essenzialmente come più autentico rispetto ad Instagram, in quanto, per la maggior parte delle nostre FYP, sia dominato da una certa straniante aurea di familiarità.
Instagram è uno spazio però, come TikTok, stordito dal suo stesso scopo: quello di riflettere le nostre vite. Purtroppo, lo stordimento si è esteso pigramente fino a noi, portandoci a riversarne all’interno ciò che presupponevamo appartenesse alla vita reale: didascalie come diari personali, selfie in cui piangiamo, fotografie di particolari di corpi altrui, call-out a multinazionali, infografiche sui nostri problemi di salute mentale.
L’atto di consumare e di produrre contenuti è un atto di fiducia: la nozione di performance, di cui parlava Jia Tolentino in uno dei suoi saggi, ha smesso di essere finzione ed è diventata essa stessa verità. Come nei video di TikTok, in cui l’utente ci mostra una versione di sé noncurante, autentica – tentando di dissimulare gli strati di invenzione che si celano dietro il tasto “Pubblica” (filmare, montaggio, editing, filtri, modifiche grafiche, ricerca di hashtag).
Ciò accomuna chiunque abbia un profilo su questo social media, fictional o meno che sia. Dalla nascita delle influencer si è creato un po’ un divario di pensiero su questa figura: da un lato, per la questione dell’autenticità, ci è apparso ormai chiaro che pressoché chiunque possa diventare influencer – d’altra parte, però, trovo intrigante la proliferazione di questi personaggi in termini narrativi.
Come puntualizza bene questo pezzo su Medium: «Connecting with fictional characters isn’t unusual. Everyone who’s read fiction has felt some sort of genuine emotional response to a book character».
A partire da questa affermazione immagino tutti questi influencer collegati gli uni agli altri da narrative più o meno simili, a cui gli utenti si affezionano come si affezionerebbero ad un personaggio di un romanzo – con l’unico inconveniente che questo romanzo, estremamente prolisso, coincide con la realtà.
Entrambi mirano a far breccia nell’individuo e/o utente, il quale si sentirà rincuorato nell’appurare come la sua vita non sia poi così dissimile da quella di qualcun altro. TikTok e autofiction sono accomunati dal posizionamento centrale dell’autore / creatore, il quale ritrae una versione fittizia di sé stesso e, al tempo stesso, promettono un prolungamento della nostra consapevolezza e percezione del mondo.
Forse i fictional influencer non sono altro che un prodotto letterario distopico? Come nella fiaba di Borges, in cui i cartografi incaricati dal re costruiscono una mappa così fedele alla sua rappresentazione da corrispondere perfettamente all’Impero stesso – causandone la distruzione – così la costruzione dei fictional influencer fa vacillare l’utente, il quale inizialmente sovrapporrà rappresentazione e realtà, per poi accettare l’inevitabile sopravvento del modello.
La creazione dei fictional influencers, inoltre, mi porta a pensare a possibili ramificazioni dell’argomento: la i di io nella parola internet – come ha scritto Jia Tolentino – è sempre più rilevante e centrale.
Da un lato, abbiamo la nascita dei fictional influencers, dall’altro, invece, assistiamo – perlomeno su piattaforme come TikTok – alla massiccia creazione di contenuti video in cui persone comuni diventano dei main characters, soggetti a questa narrativa costante, tipica di internet, in cui si cerca di romanticizzare al massimo la propria vita.
Un pezzo di autofiction, a mio parere, potrebbe apparire come la rappresentazione letteraria: una calibrata intersezione di verità e menzogna, in cui si pone nel nucleo della narrazione l’esperienza personale. Dietro questa narrazione personale, c’è, però, un accurato lavoro di ritaglio, aggiustamenti, un certo cesellamento nel personal branding.
Entrambi mirano a far breccia nell’individuo e/o utente, il quale si sentirà rincuorato nell’appurare come la sua vita non sia poi così dissimile da quella di qualcun altro. TikTok e autofiction sono accomunati dal posizionamento centrale dell’autore/creatore, il quale ritrae una versione fittizia di sé stesso e, al tempo stesso, promettono un prolungamento della nostra consapevolezza e percezione del mondo.
In particolare, il trend di porsi come main character è anamorfico tanto quanto un saggio di autofiction: ambedue distorcono ciò che presupponiamo sia la realtà che ci viene offerta, in verità celata da ulteriori stratificazioni: il narratore corrisponde con l’autore? Tentando di dissimulare la sua vera identità, il personaggio è ingannevole, oppure l’idea del Sé è talmente ben confezionata da risultare veritiera? Come viene presentato l’altro, all’interno di questa narrazione? In che maniera si potrebbe sviluppare, attraverso delle diramazioni senza gerarchia, nel cyberspazio? Gli strati di realtà che stiamo attraversando sono un perfetto contenitore del modo in cui la performance è diventata essa stessa verità.
L’atto di consumare contenuti è di per sé un atto di fiducia, in cui tra utente e autore vi è un accordo stipulato per fingere, o perlomeno permettere al primo di credere che la pura fantasia sia realtà
Forse chi utilizza i social media scrive consapevolmente il proprio saggio virtuale sulla sua persona. Ogni creazione digitale è autofiction, in quanto ogni prodotto esercita un controllo sull’essere e sulla narrazione.
Ci avviciniamo ad essi poiché convinti siano lontani da ciò che supponiamo sia un romanzo – un lavoro di finzione, sulla finzione – dimenticando che l’atto di consumare contenuti è di per sé un atto di fiducia, in cui tra utente e autore vi è un accordo stipulato per fingere, o perlomeno permettere al primo di credere che la pura fantasia sia realtà.
Forse, in quest’ottica, ben vengano gli attori pagati e gli influencer virtuali: quest’ultimi, in quanto presentati effettivamente come creazioni digitali simili ad umani, dovrebbero indebolire l’effetto uncanny riservato solitamente a robot con sembianze umane. L’individuo è incoraggiato, sin da bambino, a esprimere sé stesso attraverso i giochi, e la familiarità associativa con questa pratica potrebbe essere uno dei fattori di interesse negli influencer digitali.
Le attuali tecnologie permettono, peraltro, di renderli quasi indistinguibili dagli esseri umani. Nonostante queste possibilità, si può notare come vi siano dei glitch nelle immagini che li ritraggono: alcune delle imperfezioni – come la grana della pelle di Shudu, prima supermodella digitale su Instagram – potrebbero essere state create intenzionalmente, garantendo così al personaggio un carattere magnetico ed elusivo che attrarrebbe inconsapevolmente l’utente (chi l’avrebbe mai immaginato che sarebbe stato più interessante un personaggio digitale di una persona in carne ed ossa?).
Difatti, il futuro ci riserva l’estensione della mappa di cui parlavamo prima: secondo l’opinione della sociologa Diane Pacom, l’ascesa di influencer virtuali – come Lil Miquela, Noonoouri, Shudu – potrebbe portare a due ramificazioni possibili: da un lato, le aziende dei vari brand saranno indubbiamente rassicurate, poiché gli influencer creati digitalmente comportano un totale controllo dell’essere mantenendo sembianze umane, dall’altro, però, avverrà – come una profezia – la sostituzione del reale tramite una costruzione artificiale.
In futuro saranno forse gli influencer digitali a soppiantare quelli in carne ed ossa, fictional inclusi?
Tutti i protagonisti presi in considerazione – un attore pagato per sembrare un influencer e recitare un copione, i milioni di main characters su TikTok (l’hashtag #maincharacter è stato utilizzato, al momento in cui scrivo, 6 miliardi di volte), gli influencer tridimensionali in carne, organi e ossa, quelli composti unicamente da pixel, l’offuscato narratore che pone al centro un sé accuratamente romanzato – tutti si trovano sulla mappa che cerca di simulare fedelmente il reale. Sfortunatamente, nella mappa ci troviamo a vivere anche noi, immergendoci sempre di più in questa sequenza di strati. Riuscire a differenziarli sarà la vera sfida.