Per chi non li conoscesse, i tipi di Honest Trailers sfruttano i cliché formali dei grandi blockbuster per sfotterne gli stereotipi di contenuto. Al di là del pubblicare video dall’umorismo assai dubbio, la missione neanche troppo indiretta degli honest trailers è smascherare le pigrizie, i manierismi o la ripetitività intrinseca dei franchise e dei film commerciali provenienti dagli Stati Uniti. Se avessi le doti e la pazienza di un bravo montatore, cercherei di compiere un’operazione simile con la maggior parte di quei documentari – seriali e non – che hanno fatto parlare di sé negli ultimi anni. Immaginate una trafila di spezzoni tratti da Tiger King, Making of a Murderer, The Last Dance o Whitney: Can I Be Me cuciti insieme con i toni schizoidi di un true crime che si trasforma in thriller sportivo per poi ritrarre una personalità stravagante ma sconosciuta, oppure celebre ma morta.
Il film documentario nasce con l’intenzione di istruire e informare, e perciò in seno a un paradosso: a differenza dei metodi scientifici che si avvicinano alla verità elaborando una maggiore quantità di dati disponibili, il mezzo filmico è per natura parziale. Offre uno sguardo, letteralmente una inquadratura sulle cose. Non che per questo non abbia mai avuto pretese scientifiche: una branca dell’antropologia, quella visiva, si sviluppò in seguito alle politiche coloniali proprio con l’ambizione di esplorare la realtà umana con obiettività empirica. Ma senza tirare in ballo le problematiche politiche del sempre pregiudicato sguardo sull’altro, il documentario, nella sua intenzione di raccontare e spiegare la realtà – uno sforzo che l’accomuna alla filosofia, alla storiografia o alla narrativa non-fiction – si colloca sul delicato confine tra arte figurativa e informazione. Malgrado questo suo “peccato originale” la storia del cinema documentario ha prodotto capolavori capaci di inoltrarsi in mondi sconosciuti (Titicut Follies, Frederick Wiseman, 1967), svelare meccanismi nascosti (The Thin Blue Line, Errol Morris, 1988), raccontare storie o persone trascurate dai media mainstream (The Act of Killing, Joshua Oppenheimer, 2012; Grizzly Man, Werner Herzog, 2005), condiviso visioni inimmaginabili (Leviathan, Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel, 2012; Il Sacro GRA, Gianfranco Rosi, 2013).
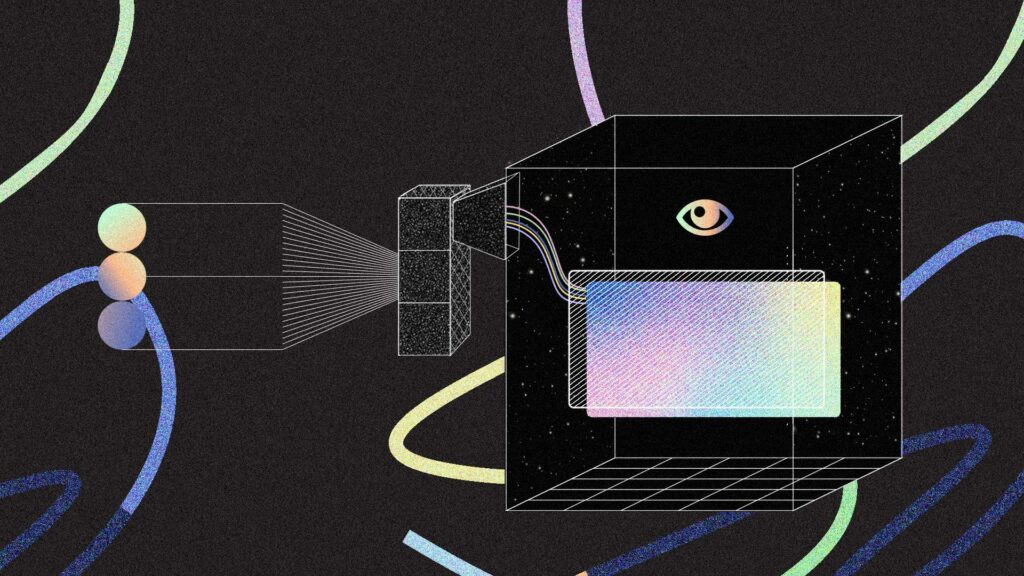
I casi appena citati, tutti – bisogna dirlo – generati da spiccati sguardi autoriali, sono diventati dei modelli per i generi capitalizzati dalle serie odierne: il true crime, le biografie di figure idiosincratiche e fuori dall’ordinario, l’idea di evento insabbiato da rivelare o spiegare al pubblico. Una lista approssimativa di riferimento affianca, alle serie nominate in apertura, titoli come come Leaving Neverland, What Happened, Miss Nina Simone?, Generation Wealth, Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado, Free Solo, Jeffrey Epstein: Sesso, Potere e Perversione.
Esistono poi formati più compatti, che esercitano proprio la funzione di spiegoni su temi vari anche se spesso sociali: dalle pillole di John Oliver alla serie Explained prodotta da Vox, l’idea è sempre fornire accesso ad un alto numero di informazioni complesse, spesso ordinandole secondo archi narrativi hollywoodiani (preambolo-conflitto-risoluzione del conflitto e conseguente riconoscimento di una nuova verità). In tutte le loro varie forme – serial, lungometraggi, infotainment di pochi minuti – questi documentari sembrano però non tanto muoversi da un desiderio autoriale di condividere storie e visioni, quanto dall’intenzione di lusingare il modo in cui fruiamo contenuti da quando esiste internet: avidamente, frammentariamente e in modo dissociato. Quanti di questi nuovi “documenti” toccano nel personale la nostra visione del mondo? Quanti si sedimentano davvero nel nostro immaginario o nella comprensione della realtà?
A non stimolare un processo di interiorizzazione e appropriazione di questi non-fiction contribuisce anche – e forse soprattutto – l’apparato estetico delle varie produzioni originali di piattaforme con milioni di abbonati come Netflix e compagnia. Si tratta di stilemi reiterati che si manifestano quasi identici a prescindere dal contenuto: riprese con i droni, slow motion, color grading brandizzati o identificativi di periodi cronologici precisi, soggetti in primo piano 4K su sfondi neutri e sfumati, “talking heads” drammatici o scandalosi, narrazione in off dai toni inquisitori, materiale d’archivio esclusivo o presentato come tale, colonne sonore “suggeritrici” ad anticipare fatti o stati emotivi dello spettatore. Da una parte e almeno per quanto riguarda il pubblico statunitense, questi elementi creano una sensazione di familiarità perché derivanti direttamente dalle tivù locali che si cimentavano, a basso costo, coi generi legal e forensic, il re-enactment, e i primi reality degli anni Novanta (The Real World: ricordate?). Sarebbe ingiusto liquidare questi fenomeni come “tivù spazzatura” e in un certo senso il recupero di stilemi popolari – proprio grass root dal punto di vista produttivo – vent’anni dopo, in prodotti dai budget stellari, rivela un processo di appropriazione “invertito” apprezzabile, come se i metodi indagatori di Franca Leosini comparissero improvvisamente in un true crime ispirato a Montalbano diretto da Garrone (anzi, nella fiction questa appropriazione invertita esiste e si chiama Boris). Dall’altra parte, se questi doc oggi prodotti in massa fanno leva sui tratti un po’ ossessivi suscitati dall’interazione quotidiana con internet, in realtà non ne esprimono l’ipertestualità, la sua qualità archivistica e sofisticatrice, la natura complessa e conflittuale che intercorre tra mondo reale e virtuale, l’emergere di personalità ipertrofiche ma anche ingegnose. Soprattutto non incarnano lo spirito di “ricerca” – sia in termini di puro motore di ricerca, sia in termini di costante sviluppo tecnologico – su cui si basa l’intero funzionamento di questo mondo “parallelo” in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
L’apparato estetico dei doc prodotti in serie somiglia molto al modo in cui fruiamo di contenuti da quando esiste internet: frammentariamente, avidamente e in modo dissociato.
In realtà internet non è affatto un flusso ordinato di contenuti e input prodotti con l’unico scopo di farci abbuffare (pagare il canone, condividere dati), ma un caos sregolato e labirintico che si basa sull’archiviazione e la registrazione di se stesso; sulla replica virtuale di comportamenti e abitudini mondani; su slanci sia individualisti che collettivi; sulla tracciabilità delle informazioni e la possibilità di costruire delle realtà alternative proprio grazie a questa tracciabilità; sull’imprevedibilità dei fenomeni che lo contraddistinguono e di chi vi interagisce. In altre ovvie parole, internet è come la realtà: un sistema altamente sofisticato la cui complessità riverbera anche quando si cerca di spiegarla.
Così, a contraddire il panorama non-fiction laccato e semplificante proposto dai doc – chiamiamoli così – “prodotti in serie”, esistono diversi documentari tra loro molto diversi ma che sembrano incarnare in modo molto più contemporaneo e realistico la complessità di cui si diceva sopra. Laddove i doc prodotti in serie restituiscono una realtà falsata da format semplificanti e necessità di profitto, questi doc – diciamo semplicemente “altri” – raccontano e mostrano storie in un modo molto simile a quello in cui la realtà, e dunque poi internet, si srotola verso di noi e, letteralmente, ci informa.

Anche in questo caso basti una lista sommaria, orientata sulla cultura anglofona e dunque non esemplificativa della varietà globale, che comprende ma non si limita a lavori come OJ: Made in America (Ezra Edelman, 2016), Finding Jonbenet (Kitty Green, 2017), American Factory (Steven Bognar e Julia Reichert, 2019), Amazing Grace (Alan Elliott, 2018), Citizenfour (Laura Poitras, 2014), Collective (Alexander Nanu, 2019) e ai doc di Adam Curtis, Sergei Loznitsa, Matt Wolf.
Prendiamo ad esempio il primo citato, il doc di Ezra Edelman per ESPN Films, uscito quasi in contemporanea con lo sceneggiato seriale di FX The People v. O. J. Simpson: American Crime Story. La miniserie di Edelman segue sì la biografia problematica di Simpson, ma la intreccia alla questione razziale statunitense identificandovi punti in comune, sovrapposizioni cronologiche e segnali culturali che permeano non solo gli eventi particolari ma la società intera, attraverso il tempo. Per quanto specificamente americano, nella sua esecuzione OJ: Made in America dimostra quanto, per raccontare una storia, sia necessario “aprirla” a tutte le altre che vi scorrono attraverso.
I documentari di Adam Curtis – vedi All Watched Over By Machines of Loving Grace, Bitter Lake, HyperNormalisation – portano questo principio di “espansione storico-narrativa” ad uno stiramento molto più radicale di quello messo in pratica da Edelman, ma paradigmatico della natura rizomatica del web. Nel suo scavare negli archivi della BBC per trovare filmati esclusi dalla versione dominante degli eventi ma meglio aderenti alla sua visione dei fatti, anche Curtis asseconda un impulso organizzatore che enfatizza legami lineari e deterministici. Se da una parte questo approccio sembrerebbe contraddire il carattere articolato e reticolato della realtà virtuale e non, dall’altra l’impiego di uno storytelling basato su associazioni idiosincratiche più che su cause-effetto comprovanti, rispecchia la modalità molto umana in cui interpretiamo la realtà, un atteggiamento che ci porta – parafrasando Joan Didion – a vivere di idee con cui impariamo a congelare le fantasmagorie che compongono la nostra esperienza. Il regista ucraino Sergei Loznitsa, soprattutto in doc recenti come Maidan, The Event e Austerlitz, mette in pratica un’operazione paragonabile a quella di Curtis, sebbene giocandola esclusivamente sul piano del linguaggio cinematografico, ovverosia tramite il montaggio e l’inquadratura. Che mostri le rivolte nella piazza principale di Kiev come una coreografia spettacolare, le reazioni a San Pietroburgo all’indomani del fallito colpo di stato del 1991 come bivio storico già risolto mentre accade, o il turismo nel campo di concentramento di Sachsenhausen come testimonianza di una mai sradicata superficialità umana, Loznitsa propone giudizi soggettivi che ciononostante valgono anche come documenti veritieri. Anche Kitty Green, raccontando in Casting JonBenet l’omicidio di una bambina nota nei concorsi di bellezza negli anni Novanta, argomenta le proprie tesi con le immagini più che con i fatti: impiegando il re-enactment come strumento di indagine sia contenutistica che formale, ingrandisce l’episodio di cronaca sotto la lente più generale della violenza subita dalle donne tramite la manipolazione della loro immagine.
Al contempo oggi possiamo rintracciare documentaristi, tra loro molto diversi, ma che sembrano incarnare in modo molto più contemporaneo e realistico la complessità, raccontando e mostrando storie in un modo molto simile a quello in cui la realtà, e dunque poi internet, si srotola verso di noi e, letteralmente, ci informa.
Presenti in modo parziale o totalizzante, nei doc sopracitati sono le immagini d’archivio inedite, che in Amazing Grace sono condizione d’esistenza: il concerto live durante il quale Aretha Franklin incise l’album omonimo venne filmato da Sydney Pollack nel 1972, senza però usare i ciak e rendendo così all’epoca impossibile sincronizzare suono e audio. Solo nel 2008, col supporto della digitalizzazione dei vari nastri, si riesce a ricomporre lo spettacolo musicale tenendo anche fede alla registrazione del disco. Da questa premesse tecnica emerge un cortocircuito commovente: uno sforzo ordinatore che è possibile solo oggi grazie a nuove tecnologie e allo stesso tempo è l’unico capace di restituire l’energia di un evento passato, registrato dal vivo. Anche doc come Citizenfour, American Factory e Collective, pur molto più tradizionali sia narrativamente che stilisticamente, propongono documenti che non si concludono con una morale inequivocabile o un messaggio positivo, inglobando e rispettando così l’ambiguità dei propri soggetti.
A concludere questa carrellata e facendo propri diversi dei tratti descritti negli altri doc, è la filmografia variegata di Matt Wolf, documentarista classe 1982. Già dai suoi primi lunghi – Wild Combination, su Arthur Russell, e Teenage, sull’invenzione del concetto di adolescente – Wolf crea un cinema non-fiction che racconta storie vere impostate su un continuum organico di immagini d’archivio, sia originali che contraffatte. La sua è una delle risposte possibili al problema del “peccato originale” del documentario, posizionando il genere sul crinale della verosimiglianza piuttosto di dover scegliere tra quello dell’arte visiva o dell’informazione. Il desiderio di condividere storie e biografie poco conosciute nonostante siano caratterizzate da una complessità “strabordante” ed esemplare di fenomeni sociali contemporanei, si ritrova anche nei recenti Recorder: The Marion Stokes Project e Spaceship Earth.
Archiviazione e rivisitazione costante di ciò che è stato, imitazioni e riproduzioni, individualismi spiccati e collettività pensanti, reti informative, maglie di sistemi, sinestesie emotive: ecco i veri protagonisti di questi doc, che pur non avendo nulla da spartire con la nozione di millennial, incarnano le qualità più radicali e ambigue di una generazione di spettatori che è nata o diventata adulta venendo esposta alla sofisticatezza di un reale che scorre su due binari – IRL e URL – senza aver potuto (o voluto) ancora scegliere da che parte stare.









