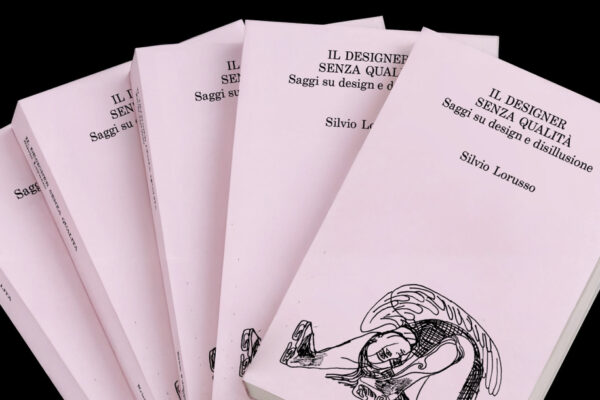Il ”terzo luogo” è il posto alternativo in cui le persone scelgono di trascorrere il tempo tra il primo luogo (la casa, il posto in cui si vive) e il secondo luogo (il posto di lavoro). Il termine, coniato dal sociologo Ray Oldenburg, fa riferimento a luoghi dedicati al relax e alla socialità in cui avvengono scambi di idee, ci si diverte e si costruiscono rapporti. I terzi luoghi sono cruciali per la costituzione sana delle comunità. Ciò che il terzo luogo garantisce è l’appiattimento delle differenze, che tuttavia non scompaiono, ma diventano punti di forza e interessanti spunti per dibattiti approfonditi: qui le classi sociali e i background culturali vengono livellati affinché tutti si sentano a proprio agio nella dinamica di una conversazione, che ha ”l’obbligo” di essere informale.
Dalla Taverna al pub digitale
Ray Oldenburg parla di uno schema comune che si rivela tra il Caffè arabo (di cui Matisse catturò l’essenza nel primo ventennio del ‘900 in Le café Maure), la bierstube tedesca, la taverna italiana e altri tipici luoghi d’incontro sparsi per il mondo. Questi luoghi offrono da sempre una via di fuga dalla routine quotidiana, alleggerendo il peso delle pressioni domestiche e lavorative. Come scrive Josie Barboriak in un articolo per The Chicago Maroon, nel terzo luogo ci si spoglia del proprio status e si abbandona momentaneamente l’ossessione ormai intrinseca di comprare, vendere o fare soldi, sintomo degli sviluppi di una società sempre più consumistica.
La preoccupazione generale emersa nei contenuti virali di TikTok mette in evidenza come negli ultimi anni si sia perso di vista il reale valore del terzo posto. Se prima, al di là del lavoro e delle ore passate nella propria dimora, si sceglieva un luogo in cui incontrarsi per stare insieme e chiacchierare del più e del meno (a questo proposito verrebbe in mente l’intera trama della sitcom statunitense How I Met Your Mother, in cui cinque amici si incontrano assiduamente nel McLaren’s, un pub onnipresente e cruciale per tutta la narrazione, punto essenziale per le dinamiche del gruppo), con l’avvento e lo sviluppo dell’era digitale pare che siano i social a soddisfare la necessità di incontrarsi altrove.
Viene perciò spontaneo chiedersi: in futuro il simulacro di socialità offerto dai social media sostituirà davvero il bisogno di contatto umano che si risolve nello scambio che avviene nel third place? La comodità della costante disponibilità di contatto dovrebbe garantire una sorta di rimedio alla solitudine di cui i giovani della GenZ denunciano di soffrire da un po’ di tempo a questa parte. In un articolo per thred. Jeremy Pearson spiega che lo stereotipo della solitudine sentita maggiormente da parte di persone over 65 non è realistico: un sondaggio di Cigna ha stabilito che il 73% della generazione Z ha affermato di sentirsi solo qualche volta o sempre, e quelli di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono più soli di qualsiasi altra fascia di età.

Sulla base di questi dati, è chiaro che i GenZ, come scrive anche Giovanna Gallo in un articolo per Cosmopolitan, nonostante siano nel pieno della loro giovinezza e nonostante abbiano moltissime opportunità di socializzazione letteralmente a portata di mano, si sentano sempre più soli, sviluppando così anche una paura nei confronti della solitudine che viene percepita come un fallimento personale.
Murgia sostiene che non è possibile considerare le esperienze vissute tramite i mezzi di comunicazione come esperienze fasulle e illusorie.
Tuttavia, se da una parte si può pensare che l’esperienza digitale sia molto più limitata rispetto ad un’esperienza fisica, dall’altra non sempre è così. Nel libro God Save The Queer (Einaudi, 2022), Michela Murgia mette in discussione proprio questa convinzione, secondo cui ciò che si vive virtualmente non è tanto reale quanto le esperienze che si hanno in carne e ossa. Nel capitolo intitolato ”Tyrone Power mi sta fissando”, Murgia racconta un simpatico aneddoto su sua nonna, nata nel 1904, che durante tutta la sua vita non riuscì mai a nascondere l’infantile stupore che provava ogni volta che si trovava davanti alla televisione, per lei oggetto misterioso e incomprensibile. Un giorno, mentre guardava un film, fu intimidita dallo sguardo perforante di uno dei protagonisti, tanto da esclamare: ”Quell’uomo mi sta fissando, ditegli di smettere”. Aprendo una finestra sulla sua vita privata, Michela Murgia elabora una riflessione sul tema della percezione del virtuale, e scrive:
[…] la passività nella comunicazione non esiste più, e gli stessi algoritmi dei social media funzionano sulla base dei comportamenti di risposta: selezionano i contenuti utente per utente a seconda del numero di interazioni che in potenza generano. Quanto possiamo ancora permetterci di definire illusoria una comunicazione che si fonda su una risposta così diretta e immediata? Davvero basta la presenza di un dispositivo che filtra il contatto tra i corpi per rendere illusoria un’esperienza?
Murgia sostiene che non è possibile considerare le esperienze vissute tramite i mezzi di comunicazione come esperienze fasulle e illusorie. L’immaginazione immersiva, secondo l’autrice, genera nel cervello le stesse reazioni dell’esperienza sensibile. Per questo motivo, tutto quello che smuove una persona, che la spinge a vivere un mutamento, è da considerarsi reale. ”In termini di cambiamento”, scrive Michela, ”può essere molto più autentico il botta e risposta di messaggi con un amico o la discussione che segui su una piattaforma digitale piuttosto che la frase fatta che ti ripete tua madre in carne e ossa mentre a tavola ti porge le patate al forno”.
Nuove forme di interazione digitale
In un’era postumana in costante evoluzione, l’esperienza virtuale può essere considerata tanto valida quanto quella fisica, proprio perché, come nel mondo reale, è capace di attivare in chi la vive un cambiamento che è concreto, fisico ed emozionale. Inoltre, è bene sottolineare che nel mondo virtuale l’identità è infinitamente più flessibile rispetto a quella fisica. Pertanto, la costituzione di terzi luoghi online potrebbe essere più inclusiva rispetto a quelli del mondo reale, che sono spesso fondati su regole implicite o esplicite, a volte anche escludenti. Michela Murgia, a questo proposito, scrive:
Se una persona con un handicap crea un’identità digitale che l’handicap non lo ha e stabilisce relazioni, sta producendo una realtà falsata o ne sta ipotizzando una più autentica rispetto a sé? Se una persona che appartiene a un’etnia razzializzata si inventa un’identità digitale grazie alla quale le diventano possibili legami con persone che altrimenti non si relazionerebbero mai a lei, sta mentendo o sta producendo una distorsione creativa nella società razzista in cui vive? Se una donna nata in un corpo maschile aggira la disforia di genere attraverso un’identità digitale che corrisponde al genere in cui si riconosce, possiamo parlare di inganno oppure siamo davanti a una realtà più sincera?
Nell’America analizzata da Oldenburg, il problema della scomparsa dei terzi luoghi nasce per la disorganizzazione urbana. La società americana, secondo il sociologo, è una società della sconvenienza: a differenza delle società europee – che pure nelle loro singolari caratteristiche hanno in comune il fatto che sono costruite in spazi non esageratamente dispersivi – in America, per la maggior parte dei casi, i luoghi sono raggiungibili solamente con una vettura o con i mezzi pubblici. Per questo si parla di sconvenienza: anche se l’America cerca di risparmiare tempo colmando le sue lacune con carte di credito di plastica, macchinette del caffè pubbliche, pranzi e cene congelati e preconfezionati, queste nuove abitudini limitano di molto l’interazione sociale, favorendo la scomparsa di alcuni ”rituali” di interazione – come li definisce Oldenburg – che sono cruciali per il funzionamento della società.
In Europa, invece, gli spazi si possono definire equi e convenienti, perché i servizi sono distribuiti in maniera abbastanza adeguata – tanto da favorire l’interazione – e non sempre è necessario usufruire di un’automobile o di un mezzo per arrivare da qualche parte. Soprattutto negli ultimi anni, però, tra la società americana e quella europea il senso di solitudine e circoscrizione rimane una caratteristica comune, a prescindere dalla convenienza della costruzione degli spazi urbani.
Durante la pandemia siamo stati costretti a vivere in maniera limitata dal punto di vista sociale. Togliendo ad una comunità la possibilità di contatto fino ad allora data per scontata, dunque la possibilità di accedere ad un secondo e terzo luogo, il primo luogo (la casa) e il quartiere circostante si sono trasformati in un simulacro del terzo luogo. Poiché tutti erano costretti a condividere un unico spazio, il primo-terzo luogo generato dalla pandemia ha dato modo al senso di unità delle comunità di emergere in un momento di difficoltà che richiedeva un certo livello di compassione collettiva, in un clima di paura e incertezza generali. Soprattutto nei primi mesi di quarantena, la comunità si è trasformata in maniera inaspettata, nuova: ogni individuo che la costituiva aveva una luce puntata su di sé da parte dei propri vicini, tutti diventarono importanti ed essenziali. Di fronte alla rottura della routine frenetica di tutti i giorni, nessuno era più invisibile, e ogni cosa era classificabile come un atto di resistenza.
Anche qualora dovessero nascere nuovi terzi luoghi, questi sarebbero inutilizzati per via della facilità e dell’agio nell’interazione offerti dal mondo digitale.
Ciononostante, quando la società ha ripreso i suoi ritmi, la routine collettiva è esplosa nuovamente in uno scatto frenetico, e l’isolamento del singolo individuo ha ricominciato a diventare una normalità. Per questo motivo, come spiega anche Natalie Perri in un video sul canale Unraveling Architecture, le piattaforme virtuali hanno senza dubbio offerto una soluzione alternativa ai luoghi d’incontro fisici: alcune ricerche scientifiche degli ultimi anni ipotizzano che anche qualora dovessero nascere nuovi terzi luoghi, questi sarebbero inutilizzati per via della facilità e dell’agio nell’interazione offerti dal mondo digitale. Da non dimenticare è anche la questione della salute mentale: l’isolamento cronico può infatti portare a sensazioni di insostenibile solitudine e a delle serie lacune a livello cognitivo.
I terzi luoghi di domani
La drastica diminuzione di interazioni vis-à-vis delle ultime generazioni e non solo, dimostra quanto sia diventato complicato negli ultimi anni e soprattutto dopo la pandemia interagire di persona. Molto spesso, afferma Natalie Perri, il topic principale delle conversazioni sembra essere cosa succede sui social, che sia un audio, un video, una foto o un nuovo trend. Pare insomma che anche la conversazione affrontata nel mondo reale si svolga intorno a quello digitale, rendendo chiara l’idea della difficoltà a disconnettersi dalle proprie alternative identità digitali anche quando si è davanti ad un essere umano in carne e ossa. Sarà davvero questa la nuova modalità standard per socializzare? O prima o poi riusciremo a convivere serenamente e in maniera perfettamente equilibrata tra questi due emisferi di esistenza senza che uno prevalga sull’altro?
Come evidenziava Oldenburg già diversi anni fa, la vita senza comunità ha prodotto, per molti, uno stile di vita che consiste principalmente in una navetta casa-lavoro-e-ritorno. È bene ribadire che il benessere sociale e la salute psicologica del singolo dipendono anche e soprattutto dalla partecipazione alle dinamiche di collettività. Alcune rappresentazioni del terzo luogo, indubbiamente fondamentali per la cultura a livello mondiale, si possono individuare in più discipline artistiche e lungo una linea di tempo che è intergenerazionale: in How I Met Your Mother, come citato in precedenza, c’è il McLaren’s; in Friends, celebre sitcom americana, c’è la caffetteria Central Perk; in letteratura verrebbe da pensare a Il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald, libro in cui la casa di Gatsby funge da terzo luogo per un’intera comunità di persone di diverse estrazioni sociali che si incontrano e scontrano diventando un vero e proprio specchio realistico delle reazioni umane.

Ray Oldenburg sostiene che quando le persone vengono ”thrown together”, cioè raggruppate insieme in un unico posto, scoprono che c’è molto a cui possono affezionarsi, molto da adorare, da aggiungere alle proprie vite e molto che potrebbe ampliare le loro prospettive. La prova di questa tendenza tutta umana l’abbiamo avuta a livello globale durante la pandemia. Sarebbe bello, come scritto in precedenza, riuscire a riscoprire l’importanza del terzo luogo del mondo reale e trovare un equilibrio perfetto con quello che è il terzo luogo virtuale, senza che uno predomini in maniera asfissiante sull’altro. Dopotutto, ciò che importa è lo scambio: quando le persone si rendono conto di quanto è importante dedicare del tempo alla sfera sociale – anche se l’impostazione della società capitalistica non sempre lo permette – crescono, si evolvono, e spesso hanno l’opportunità di cambiare per il meglio. Senza questo, e tenendo le persone in disparte, si chiede Oldenburg, che tipo di crescita potremmo avere?