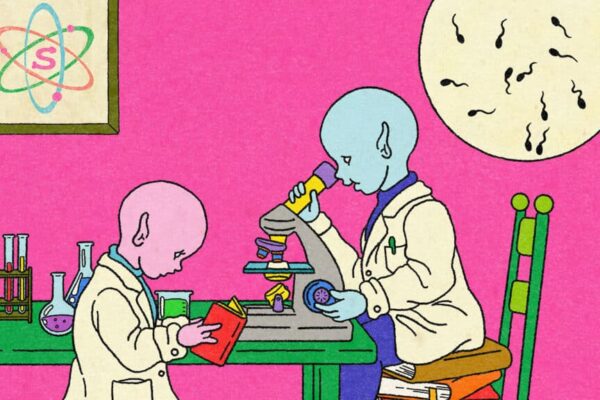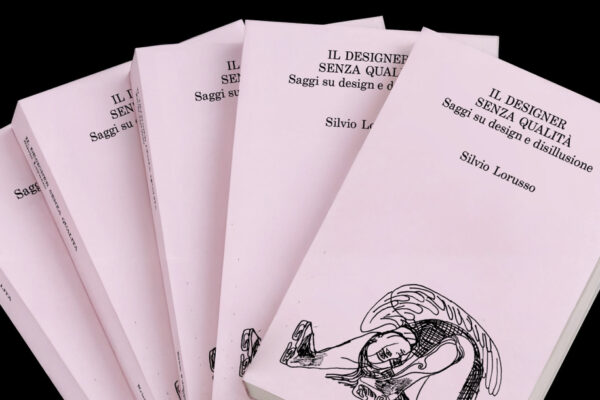Pubblichiamo un estratto di “Problemi – Una guida per capire l’assurdità del presente” pubblicato da Blackie Edizioni. Ringraziamo la casa editrice e l’autore per la gentile concessione.
Per mesi ho fatto un percorso che tutti chiamano «terapia». Terapia è una parola orribile che in pieno illuminismo siamo andati a rubare alla medicina per illuderci che, così come siamo riusciti a curare il colera, avremmo imparato a curare il nostro dolore. Una cura, però, prevede l’esistenza di una malattia, di una rottura, di un’alterazione della normalità a cui a un certo punto, dopo un percorso di «terapia», si può ritornare. Ma quello che veniva fuori in quelle «sedute di terapia» non era la «rottura» di qualcosa; quello che veniva fuori era la mia normalità. Io non avevo vissuto niente di diverso da quello, non c’era uno stato di partenza sano a cui poter tornare e a cui qualcuno sapesse come farmi tornare.
La mia normalità, vista dalla collina della signora Giovanna, non sembrava così normale. Ma non c’era niente da «curare» e da far tornare alla normalità. C’era un dolore represso da attraversare, da rivivere, da mettere in ordine. Se proprio c’è bisogno di prendere in prestito parole da altri settori, io lascerei stare la medicina e comincerei a esplorare il settore dello «sgombero cantine». In quel periodo, quello che facevo con la signora Giovanna era dedicare due ore a settimana a sgomberare la cantina nella quale per trent’anni avevo accumulato robaccia che non mi serviva. Ora la cantina era piena e serviva uno sgombero per fare posto a robaccia nuova, che nella mia vita continuavo ad accumulare. C’era da tirare fuori tutti gli scatoloni per vedere cosa c’era dentro, buttare tutto quello che aveva fatto la muffa, cambiare l’aria, mettere su dei nuovi scaffali. E proprio come gli sgomberi veri delle vere cantine, è meglio per tutti se c’è qualcuno di pagato per farli. Non che serva un grande professionista, uno sgombero di una cantina è uno sgombero di una cantina. E l’umanità è sopravvissuta per centinaia di migliaia di anni anche senza psicoterapia. Ma a farlo da soli si arriva fino a un certo punto. Una volta nella vita un favore un amico o un parente te lo può fare, ma se devi sgomberare un sacco di roba è meglio che chiami un’impresa che fa quello di lavoro, che significa prima di tutto assumersi l’onere in cambio di una retribuzione. Che poi era quello che mi aveva detto lo psichiatra: dovevo pagare qualcuno per stare seduto ad ascoltare quello che avevo da dire. Non che ci si potesse fare molto con le cose dette, ma almeno erano defluite.
Per questo tutti consigliano agli altri di «andare in terapia»: in realtà, quello che stanno dicendo è: «Pensaci tu alla tua cantina, che io ho già la mia a cui pensare». Per altro era la stessa cosa che avrei dovuto dire io alla persona che mi ha rivelato il suo enorme segreto, segreto per il quale io non avevo posto perché, a mia volta, avevo la mia cantina piena.
Dopo un paio di mesi di sedute sfiancanti la signora Giovanna mi disse che il lavoro massiccio di svuotamento era stato fatto e d’ora in poi potevamo vederci tranquillamente una volta a settimana, per rimettere a posto quello che avevamo tirato fuori. C’era un pochino più di posto adesso, dopo il lavoro di sgombero. Più posto per gli errori degli altri, più posto per gli errori miei, più posto per gli errori nuovi che sarebbero venuti da lì in avanti. Erano più ordinati e riconoscibili, non accatastati, ed era più semplice a questo punto dare loro un nome e metterci sopra un’etichetta, in modo da ritrovarli facilmente quando avessi avuto bisogno di ricordarmeli. C’era più posto per accogliere gli errori degli altri, tra tutti quelli dei miei genitori, due persone che mi avevano messo al mondo all’età in cui mi facevo 20 bombette di fila con le lattine di birra. E, cosa più importante di tutte, c’era più posto per l’acquiescenza, l’accettazione di qualcosa che non si ha la possibilità di cambiare. Acquiescenza del fatto che mia madre il 6 luglio del 1992 mi aveva portato a Monza a vedere Michael Jackson nel tour di Dangerous.
Acquiescenza del fatto che mio padre mi procura del vino e della grappa che non troverei da nessun’altra parte nel mondo.
Quello che veniva fuori in quelle «sedute di terapia» non era la «rottura» di qualcosa; quello che veniva fuori era la mia normalità. Io non avevo vissuto niente di diverso da quello, non c’era uno stato di partenza sano a cui poter tornare e a cui qualcuno sapesse come farmi tornare.
Dopo qualche mese la signora Giovanna mi ha dovuto comunicare che per cause di forza maggiore non mi avrebbe più potuto seguire nello sgombero della cantina e che per finire i lavori avrei dovuto trovare una nuova ditta. Ho provato prima con un collega del suo studio, ma portava delle Monk con doppia fibbia, per cui durante le sedute mi veniva solo voglia di tagliargli i piedi. Ho fatto un po’ di pellegrinaggio, ma sentivo che ormai quella parte di riordino delle cose svuotate la potevo fare anche da solo. Qualche anno più tardi è arrivata la mia seconda relazione tossica e dopo due anni di continua tensione ho pensato che fosse arrivato il momento di rimettere in ordine l’immondizia che quella persona aveva scaricato nella mia cantina. Ho provato con la ditta del signor Ezio, che aveva la porta dello studio che in realtà era uno scaffale della libreria.
Cioè una volta che lui chiudeva la porta, non c’erano più porte. C’erano solo un’enorme libreria su un lato, e una grande finestra dall’altro che teneva sempre aperta, e mi dava l’idea che la scelta fosse: «O parli con me, o ti butti di sotto». Niente Jung stavolta, il signor Ezio aveva studiato gli sgomberi da Jacques Lacan. Per un’ora io parlavo a ruota libera e lui non diceva nulla. All’ottavo incontro mi ha detto, molto pacatamente, che secondo lui io stavo benissimo e che la mia compagna stava proiettando su di me un suo deficit terapeutico. Il signor Ezio aveva ragione. Chissà per quale motivo, a un certo punto nella mia vita mi sono messo in mente che un modo per farsi voler bene dagli altri era diventare una ditta che faceva sgomberi gratis: ho cominciato ad appendere volantini con il mio numero strappabile ovunque e mi sono dato allo sgombero delle cantine degli altri, senza occuparmi della mia. Col tempo sono diventato pure bravo, e per questo le persone si sono sempre sentite di poter venire da me e scaricarmi addosso i sacchi neri che stavano accatastati nelle loro cantine. E io ho sempre risposto caricandoli sulle mie spalle e stoccandoli nella mia, in attesa un giorno di liberarmene. Tutto quel faticare mi faceva sentire utile, e meno solo. Mi sentivo utile nello sgomberare le cantine altrui. Non posso quindi fare una colpa agli altri se si sentono a loro agio a venire a confidarmi i loro segreti più dolorosi. Sono io che devo correre il rischio di provare a farmi voler bene per quello che ho nella mia cantina, e non per quanto sgombero quelle degli altri.
Oggi ho quarant’anni e mi servo ancora di una ditta di sgomberi. Pochi incontri, dilatati nel tempo ma a cadenza regolare. Niente Jung, niente Lacan, questa volta servono Erving Goffman, Ludwig Wittgenstein, Werner Heisenberg. La mia cantina oggi la so svuotare per conto mio, quello per cui chiedo un aiuto è la manutenzione e la gestione delle cose più grandi di me.
Alla fine alprazolam, bromazepam e zolpidem non li ho mai presi. Giusto uno spritz al Cynar al tramonto, una volta ogni tanto, quando lo sgombero è più faticoso del solito.