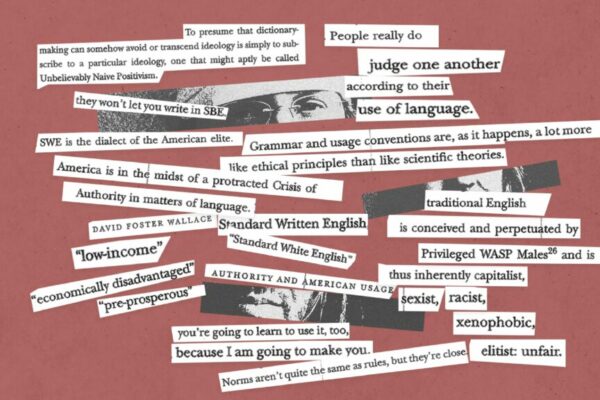Come la maggior parte delle persone che vive in un sobborgo residenziale romano, ogni tanto mi capita di andare al centro commerciale per effettuare gli acquisti più banali, quelli che in un’altra vita avrei potuto semplicemente svolgere nei negozietti sotto casa, ma che in questa sono costretta (o incentivata dalla prossimità, facciamo così) a effettuare nello stesso, gigantesco, fabbricato.
Il posto è vicino a dove abito, per questo ci vado spesso a piedi, passeggiando tra i sonnolenti palazzi in cortina del mio quartiere fino alla nuova zona commerciale, caratterizzata da imponenti grattacieli e uffici in vetro blu petrolio dietro i quali si nasconde la mia meta.
Occultato dalle facciate riflettenti di questo complesso ultra-moderno, c’è anche un piccolo casolare che, proprio come nel cartone di animazione Up, giace ormai solitario tra gli enormi edifici aziendali che gettano ombra sulla sua vecchia struttura, come a ribadirne l’intollerabile obsolescenza.
Dentro non ci vive nessuno e online non si trovano informazioni a riguardo, ma per me è presto diventato un piccolo simbolo di resistenza in un’area della città sempre più modellata dal consumo e dall’alienazione tipica dei quartieri sprawl.
Ogni volta che ci passo davanti mi fermo a osservarlo e gli scatto una foto come piccolo reminder della sua esistenza, al punto che oggi ho un intero album sul mio smartphone dedicato alle diverse angolature e fasi solari in cui sono riuscita a ritrarlo. Ogni tanto fantastico di scrivere un lungo articolo a riguardo, anche se il più delle volte penso che dovrei semplicemente farci un carosello su Instagram.
Quella casa per me rappresenta un esempio molto concreto di quello che l’artista e scrittrice Jenny Odell definisce resistenza sul posto, ovvero un modo di convivere con il sistema economico attuale in uno stato di rifiuto permanente, assumendo una forma difficile da confiscare e capitalizzare, una forma inutile, almeno dal punto di vista commerciale.
Si tratta di un concetto ricorrente nel suo saggio pubblicato in Italia da Hoepli Come non fare niente. Resistere all’economia dell’attenzione nel quale delinea una serie di strategie “improduttive” per sottrarsi all’invasività del mondo digitale e combattere le logiche estrattive con cui vengono disegnate le piattaforme online che utilizziamo quotidianamente.
Lontano dal presentarsi come un manuale di auto-aiuto o una guida al digital detox, il libro di Odell mette al centro l’attenzione umana come risorsa limitata, una valuta preziosa che da anni è protagonista di un modello di business finalizzato alla sua misura, cattura e monetizzazione. Più tempo spendiamo a scrollare o fare binge-watching online, più profitto viene generato trasformando i dati raccolti in nuovi servizi, beni di consumo e, ovviamente, contenuti abbastanza accattivanti da continuare a catturare la nostra attenzione in questo circolo vizioso.
Il primo a parlare di economia dell’attenzione è stato il Premio Nobel Herbert Simon che nel 1971 spiegava come un mondo ricco di informazioni consumi rapidamente l’attenzione dei riceventi, con una conseguenza tanto ovvia quanto cruciale per un’economia in rapida crescita attorno alla dematerializzazione dei servizi: come afferma lo stesso Simon «l’abbondanza di informazioni genera una povertà di attenzione».
Se è vero che la scarsità delle risorse è una condizione di esistenza dell’economia, nel mercato neoliberista la scoperta dell’attenzione come materia prima limitata, ma anche estremamente remunerativa, ha generato quella che Shoshana Zuboff definisce nel suo Capitalismo della sorveglianza una nuova “logica dell’accumulazione basata sulla sorveglianza dei comportamenti” e sullo studio di strategie per trattenere la nostra attenzione sempre più a lungo.
Mentre i cosiddetti media tradizionali avevano già dimostrato il ruolo determinante di una comunicazione persuasiva per influenzare le scelte di consumo del pubblico, la rivoluzione digitale ha costruito attorno alla cattura del surplus comportamentale la sua nuova corsa all’oro.
Oggi l’economia dell’attenzione non vuole solo una fetta del nostro tempo, ma tutta la torta: social network e piattaforme digitali fagocitano progressivamente il tempo del lavoro, così come quello del sonno e del tempo libero, introducento il concetto di produttività anche nella dimensione privata
Parlando di come le piattaforme cerchino in tutti i modi di attirare la nostra attenzione e mantenerla il più a lungo possibile nel perimetro dei propri spazi virtuali, una delle prime cose che vengono in mente è l’utilizzo di strategie di coinvolgimento e tecniche di design persuasivo, quelle che nel documentario The Social Dilemma vengono dozzinalmente rappresentate da tre distopici oompa loompa che inviano un incessante flusso di notifiche a un giovane sprovveduto per alimentare il suo bisogno di interazioni online, ma che in realtà consistono in una serie di pratiche molto sofisticate che – ad oggi – continuano a fregarci un po’ tutti.
Infatti, nonostante le rivelazioni sempre più compromettenti sui processi decisionali dietro il funzionamento delle piattaforme che utilizziamo più frequentemente, da Facebook a Pinterest, e le onnipresenti ricerche sugli effetti negativi dei social network sulla nostra salute mentale, le statistiche sull’utilizzo di questi servizi continuano a riportare simboli positivi.
Secondo i dati globali del report Digital 2021 prodotto da Hootsuite e We Are Social, in tutto il mondo vengono registrati 4,20 miliardi di utenti sulle piattaforme social, con un incremento del 13% (490 milioni di persone) rispetto al 2020.
Per quanto riguarda il tempo speso online, citando la ricerca «spendiamo online praticamente lo stesso tempo che spendiamo dormendo. L’utente medio passa online circa 7 ore al giorno, vale a dire circa il 42% del nostro tempo di veglia se diamo per scontato un riposo di 7-8 ore. Si tratta di un aumento di oltre un quarto d’ora al giorno rispetto alla rilevazione di 12 mesi fa, o 4%, che se mantenuto porterebbe il tempo totale speso da tutti noi online a 1,3 miliardi di anni».
Queste informazioni mi ricordano la famigerata dichiarazione rilasciata dal CEO di Netflix, Reed Hastings, nel 2017: «Quando guardi uno spettacolo di Netflix e ne diventi dipendente rimani sveglio fino a tarda notte. Alla fine, siamo in competizione con il sonno ed è una grande quantità di tempo».
Si tratta di un tema centrale, che tocca anche Odell quando cita il motto della Federation of Organized Trades and Labor Unions per la conquista della giornata lavorativa di otto ore: «Otto ore di lavoro, otto ore di riposo, otto ore di quel che si vuole», dove la sacralità del tempo non è posta solo nel diritto al riposo, ma anche in quello di fare “ciò che si vuole”, un’espressione volutamente non traducibile in attività prestabilite e automanticamente controllabili.
Oggi l’economia dell’attenzione, però, non vuole solo una fetta del nostro tempo, ma tutta la torta: piattaforme come Slack e Zoom si sovrappongono all’ambiente di lavoro fisico trasformando il tempo di lavoro in uno spazio virtuale onnipresente, mentre i social network fagocitano il tempo del sonno e di “quel che si vuole” introducendo il concetto di produttività e di brand personale nel privato, attraverso la sollecitazione frenetica di metriche, interazioni vuote e dinamiche parasociali.
Come spiega Odell nel suo saggio «il tempo diventa una risorsa economica che non possiamo più giustificare trascorrendolo a fare “niente”», ogni momento può essere sfruttato per guadagnarci da vivere o per affinare la nostra reputazione online.

È qui che l’attenzione gioca un ruolo fondamentale, trasformandosi da valuta a elemento chiave per la costruzione di una resistenza sul posto che, senza pretese di isolamento utopistico da una società ormai immersa nel matrix digitale, può dirigere nuovamente il nostro sguardo fuori dallo schermo e aiutarci a occupare il terzo spazio, una zona di rifiuto che non si sottrae, ma che prospera proprio nella sua capacità di esserci in opposizione.
A differenza del mio casolare, la cui presenza rappresenta sicuramente un’affascinante anomalia, ma che non offre una via d’uscita dal sistema in cui è immerso, esistono diverse pratiche di resistenza sul posto che ognuno di noi può esercitare attivamente.
Uno gli esempi più interessanti individuati da Odell è sicuramente quello del bioregionalismo, ovvero lo studio e l’osservazione dell’habitat ambientale che ci circonda e l’apprezzamento della complessa rete di elementi che ne trasforma continuamente l’ecosistema.
Non si tratta della classica gita fuori porta o del retreat per disintossicarsi dallo smartphone (per poi tornare a utilizzarlo con più energia di prima), ma della capacità di riconoscere l’umanità come parte di una comunità biotica che include entità non umane e che ci ricorda i legami di interdipendenza che intratteniamo con le altre specie.
L’osservazione delle bioregioni richiede ascolto e la volontà di uscire da una visione antropocentrica del mondo in cui viviamo, oltre che da una concezione strumentale di ciò che ci circonda. È qui che la comprensione ecologica mostra il suo ruolo rieducativo rispetto alla monocultura sociale e contestuale costruita dalle piattaforme online: sui social impariamo a presentarci come brand, figure monolitiche definite da una gamma riconoscibile di interessi e una personalità sempre coerente a sé stessa nel tempo.
Le persone con cui interagiamo e che seguiamo, sono funzionali a confermare e rafforzare la reputazione che ci creiamo online, così come ogni contenuto pubblicato si inscrive in uno storytelling curato della nostra personalità.
Quando accarezzo l’idea di pubblicare un carosello Instagram con le foto del casolare non è solo per condividere la sua esistenza online, ma perché inconsciamente credo che la sua storia sia funzionale a raccontare la mia, quella di una persona abbastanza profonda da costruire un’impalcatura romantica attorno alla presenza di un vecchio edificio abbandonato in una zona consacrata al business e allo shopping.
È esattamente il tipo di comportamento incentivato dai modelli algoritmici che stabiliscono quali contenuti sottoporci, costruendo una cornice che classifica le persone per categorie (definite da interessi, obiettivi, idee politiche e così via) e che trasforma le relazioni in networking.
Il territorio fluido, permeabile e interconnesso della bioregione parla invece di una prospettiva dentro la quale combattere l’alienazione contemporanea per ritrovare un terreno comune e identificarci in una rete di supporto.
È essenziale riconoscere che finché le piattaforme sono disegnate con l’unico obiettivo di raccogliere dati è impossibile concepirle come spazi al servizio delle comunità.
In questa rete, è ovviamente impossibile non riconoscere il ruolo dell’attivismo. Quando Odell scriveva nel 2019, il dibattito sull’attivismo digitale aveva già individuato i primi elementi critici dell’elaborazione di un discorso politico veicolato dai social network: come sottolinea Veronica Barassi nel suo saggio del 2015 Social Media, Immediacy and the Time for Democracy la necessità di produrre continuamente nuovi contenuti che siano in primo luogo accattivanti e adatti a stimolare una reazione/emozione generale è una dinamica che influenza la comunicazione anche degli attivisti e delle attiviste online, oltre che degli utenti che condividono solo frammenti della propria vita privata.
Nel 2021 il discorso sull’attivismo performativo è più divisivo che mai, ma è essenziale riconoscere che finché le piattaforme sono disegnate con l’unico obiettivo di raccogliere dati è impossibile concepirle come spazi al servizio delle comunità.
Pur impedendo a questa consapevolezza di screditare l’impegno di utenti che quotidianamente svolgono un ruolo di informazione e coordinamento online, il discorso più importante che sottende il lavoro di Odell, e il problema della dimensione sociale online in generale, non può non riguardare l’importanza del ritorno a uno spazio pubblico, contrapposto a quello digitale.
Nel suo saggio Future Histories, la scrittrice e avvocato Lizze O’Shea ci chiede di pensare a internet come una città: «(…) cyberspace is a place in which we engage with the world, and the forces that shape this place have influence on us. The structures surrounding our personal experience online are the focus of much commercial interest and investment, so much so that any meaningful struggle to create space for our inner self, for a literal form of self-determination, has to begin with an analysis outside of the self. No one would expect to find a moment of quiet reflection in the middle of Time Square or Shibuya Crossing».
Come non possiamo aspettarci di coltivare un momento di introspezione nel caos di Time Square, così non immaginiamo i centri commerciali come i luoghi ideali per esercitare il confronto politico con le persone che ci circondano, meno che mai per coordinare un movimento e stabilire azioni collettive di rifiuto permanente.
Come scrive Odell, i veri ambienti pubblici sono luoghi per quel che vogliamo, spazi che non sono determinati da un copione né costruiti attorno a scopi commerciali. Se è vero quello che dice Franco (Bifo) Berardi in merito alla distinzione tra connettività e sensibilità, dove la prima è la circolazione rapida di informazioni tra unità formattate per essere compatibili, mentre la seconda è un contatto complesso e difficile con l’alterità, da cui si può uscire profondamente trasformati, diventa chiaro come lo spazio delle piattaforme si inscriva nella prima dinamica e che l’onnipresenza di annunci pubblicitari targettizzati e lo sviluppo di un linguaggio personale sempre più affine all’influencer marketing renda i social network luoghi più simili a Time Square che a piazze pubbliche dove dar vita a incontri significativi.
Quando osservo quel casolare dimenticato al centro della zona commerciale, percepisco la solitudine di vivere in un quadrante della città dove ogni spazio è organizzato per incentivare azioni atomizzate specifiche, eliminando dal paesaggio la possibilità di collisione di gruppi sociali diversi e, quindi, la complessità e l’imprevisto che sono l’anima di una città. Allo stesso modo, nel vasto spazio commerciale delle piattaforme, siamo tutti individui raccolti in gruppi d’interesse sempre più isolati tra loro.
Acquisire maggiore consapevolezza della natura degli ambienti virtuali in cui ci ritroviamo quotidianamente connessi, oltre ad allenarci a (ri)scoprire il paesaggio biotico che ci circonda e di cui facciamo parte, è quel modo di prestare attenzione di cui abbiamo bisogno oggi.
Non fare niente, allora, non diventa sinonimo di ozio o di sottrazione dalle proprie responsabilità, ma costituisce un percorso di de-programmazione e riparazione di quella rete di relazioni che le dinamiche digitali rendono ogni giorno più debole e smagliata.
Incamminandoci verso la fine di una pandemia che ci ha ricordato sì l’importanza degli affetti più cari, ma a discapito della dimensione pubblica e sociale, e legittimando inoltre la centralità delle piattaforme come strumenti di interazione quotidiana, il consiglio più prezioso per uscire da questo terribile loop evitando le banali esortazioni a spegnere lo smartphone l’ho trovato nella voce di Donna Haraway durante una puntata del podcast for the wild: «What is to be done? Showing up, going to the meeting that we’re afraid of or where we’ve been criticized. Showing up responsively and not always being right, the capacity to be with each other in our mistakes, in our political groups, in our actions. Show up, take the responsibility to learn something about something (…) not pretending that we can’t make mistakes or that we can do everything».
Nonostante siano parole pronunciate prima della pandemia, in questa esortazione ritrovo tutti gli ingredienti di un vero rifiuto permanente in grado di mettere l’attenzione e la partecipazione al centro della resistenza: essere presenti in quella maniera umile e caparbia che caratterizza gli ecosistemi più resilienti, quelli che prosperano nell’intreccio di differenze strategicamente inutili al mercato e, per questo, non colonizzabili.