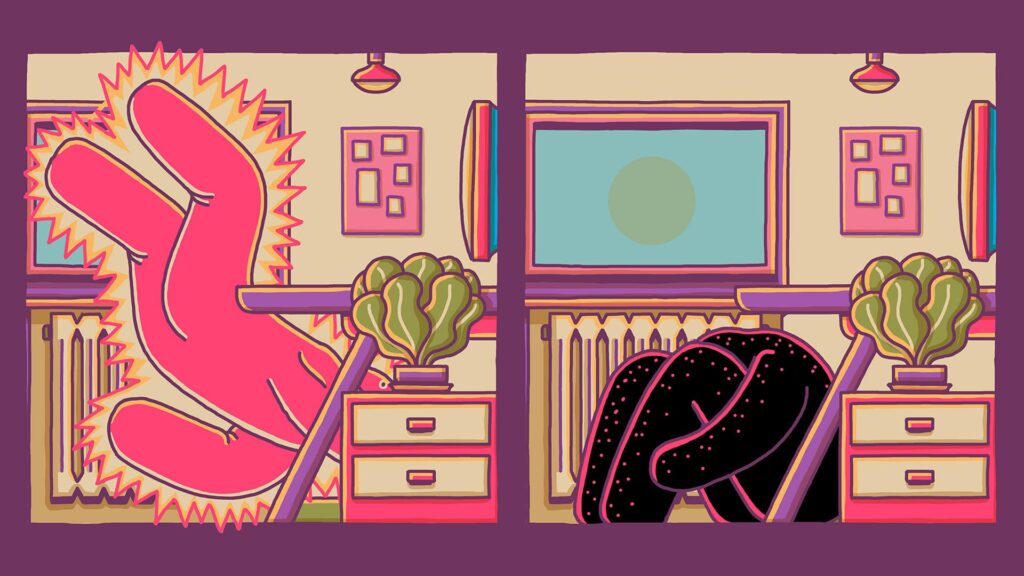Generazione burnout: il malessere dei Millennials
Da mesi dovete sostituire una lampadina, ma non avete mai voglia di farlo. L’idea di sbrigare le pratiche per il rimborso di un acquisto fallato vi disgusta al punto da lasciar perdere. Rimandate in continuazione la visita dal dentista che dovete fare da chissà quanto e a volte vi capita di lasciare andare a male il cibo senza aver mai trovato il tempo per cucinarlo.
Se vi identificate in qualcuna di queste situazioni e siete dei millennials (all’incirca i nati tra i primi anni ’80 e la metà dei ’90), conoscerete anche i relativi luoghi comuni: la nostra è una generazione pigra, viziata, priva di spirito di sacrificio, immatura e che si rifiuta di diventare adulta. E ci si potrebbe anche scherzare sopra: d’altra parte, l’unica cosa a tempo indeterminato che sembra esserci stata concessa è la giovinezza, che continuiamo a sentirci addosso anche se i più vecchi tra noi ormai sono prossimi ai 40.
La realtà è ben diversa: tutti i segnali citati nel primo paragrafo potrebbero in effetti essere i sintomi della vera cifra distintiva della nostra generazione: il burnout, una condizione identificata per la prima volta nel 1974 come “un collasso fisico o mentale causato dallo stress o dal troppo lavoro”. A differenza dell’esaurimento, a cui è comunque collegato, il burnout non comporta necessariamente l’incapacità di portare avanti ciò che si deve fare; significa più che altro essere esausti, stravolti, ma riuscire comunque – in qualche modo – a fare ciò che va fatto.
E allora perché può risultare impossibile fare cose semplici come cambiare una lampadina? «Mi sono resa conto che la grande maggioranza delle cose che rimando all’infinito hanno una cosa in comune: il primo beneficiario sono io, ma svolgere questi compiti non migliorerebbe drasticamente la mia vita», ha scritto Anne Helen Petersen, autrice di un saggio sul tema. In poche parole, quando state affrontando un burnout riuscite a trovare le energie solo per fare ciò che è davvero necessario o importante (o anche piacevole). Tutto il resto può aspettare.
Il 39,54% dei millennials italiani sostiene di star affrontando o aver affrontato un burnout, seguiti dal 25,62% dei membri della generazione X e il 15,32% dei boomer. Burnout: il confronto tra le generazioni che ne soffrono
Uscirne non è semplice: «Il burnout e i comportamenti che lo accompagnano non sono qualcosa che si può curare con una vacanza», prosegue Petersen. «Non è limitata ai professionisti che operano in ambienti a elevato tasso di stress. E non una condizione temporanea: è la condizione dei millennials. È la nostra temperatura di base. È la nostra musica di sottofondo. È la nostra vita».
In maniera semplicistica, si potrebbe dire che soffrire di burnout (ma senza aver raggiunto l’esaurimento) significa sentirsi sempre molto stanchi, molto stressati, molto demotivati. Condizioni che non vivono solo i medici sottoposti a turni sfiancanti in corsia o i professionisti della finanza che lavorano 16 ore al giorno. Capita a un numero elevatissimo di ragazze e ragazzi anche in Italia: secondo un recente studio, sostiene di star affrontando o aver affrontato un burnout il 39,54% dei millennials italiani, seguiti dal 25,62% dei membri della generazione X e il 15,32% dei boomer. Chiudono la classifica i giovanissimi della Generazione Z (7,53%), che in larga parte non hanno ancora affrontato il mondo del lavoro.
Numeri che vanno presi con le pinze, ma le cui variazioni intergenerazionali sono comunque significative. E quindi, perché siamo così facilmente colpiti dal burnout? Forse hanno ragione i nostri genitori quando ci accusano di essere deboli e senza spirito di sacrificio. O forse la ragione risiede nel fatto che lavoriamo sempre di più a fronte di stipendi ridicoli. Che fare progetti a lungo termine diventa complicatissimo a causa della precarietà del lavoro. Che un numero crescente di noi è lavoratore autonomo e quindi teme costantemente per la propria sicurezza economica. Che in tempo di crisi economica e scarsa crescita ci siamo abituati a venire trattati come “risorse” da cui estrarre sempre più produttività a qualunque costo, accettando questo trattamento – che ci porta a lavorare normalmente la sera o nel weekend – perché siamo entrati nel mondo del lavoro in piena crisi economica e già ci sembra un mezzo miracolo il fatto di averlo, un lavoro.
Tutte queste ragioni possono essere più o meno valide. Ma un altro aspetto da non sottovalutare è quanto la nostra generazione sia stata messa nelle condizioni di subire un’epidemia di burnout. Siamo stati spinti in quella direzione anche da tutta una serie di innovazioni tecnologiche che si sono dimostrate il miglior alleato del turbocapitalismo e della competizione forsennata nel mondo del lavoro.
Quando l’iPhone ha fatto la sua comparsa nel 2007, tra i vari slogan elaborati da Steve Jobs e colleghi c’erano: “Questo cambia tutto”, “Apple reinventa il telefono”, “È solo l’inizio”, ecc. ecc. Nessuno slogan diceva “adesso potrete lavorare molto di più”. Eppure è proprio la nostra vita lavorativa a essere stata enormemente colpita dall’avvento degli smartphone. Secondo una ricerca del Center for Creative Leadership, chi utilizza lo smartphone anche come strumento professionale rimane in qualche modo connesso al suo lavoro per 13,5 ore al giorno. Più o meno tutto il tempo in cui si è svegli esclusi i pasti. Un eccesso di lavoro causato dal fiume di notifiche (mail, Messenger, WhatsApp, sistemi di gestione come Trello o Slack) che ci inonda da appena svegli e ancora a letto fino a sera inoltrata; tracimando anche nei weekend.
Ovviamente, i lavoratori di qualunque età utilizzano lo smartphone, le chat e tutto il resto. Ma sono proprio i millennials ad aver introiettato la necessità di essere sempre reperibili, di inviare mail e rispondere a quelle in arrivo anche a mezzanotte, di controllare la chat di lavoro appena svegli, di intervenire in caso di bisogno anche mentre si è al parco con gli amici o con la famiglia. Da questo punto di vista, la diffusione dello smart working in seguito alla pandemia di Covid-19 rischia di compromettere ulteriormente gli equilibri, rendendo la distinzione tra vita privata e vita professionale ancora più sfumata.
«Siamo incoraggiati a definire strategie e schemi per trovare luoghi, tempi e ruoli in cui essere efficacemente messi al lavoro. L’efficienza è il nostro scopo esistenziale: siamo una generazione di strumenti finemente levigati, realizzati per essere delle macchine produttive»
Venendo meno questi confini, il rischio è di lavorare sempre, di non staccare mai, di avere – diciamo così – almeno un’area del cervello costantemente occupata dal lavoro. A quel punto il burnout è dietro l’angolo, se non inevitabile: «I tentativi di scoraggiare il lavoro fuori dagli orari prefissati si trasformano in un boomerang, perché i millennials li interpretano non come permessi per smettere di lavorare, ma come un’occasione per distinguersi rendendosi comunque disponibili», prosegue Petersen.
Le fa eco Malcom Harris, anche lui autore di un saggio sul tema: «Siamo incoraggiati a definire strategie e schemi per trovare luoghi, tempi e ruoli in cui essere efficacemente messi al lavoro. L’efficienza è il nostro scopo esistenziale: siamo una generazione di strumenti finemente levigati, realizzati per essere delle macchine produttive». Tutto questo, ovviamente, senza avere in cambio né lavori migliori, né stipendi migliori, né una maggiore stabilità.
E la situazione è destinata a peggiorare, mano a mano che nuove tecnologie si fanno largo, promettendoci di farci fare più rapidamente ciò che comunque dovremmo fare e obbligandoci invece a fare sempre più cose nella stessa unità di tempo. Scrive lo storico israeliano Yuval Noah Harari in Sapiens: «Durante gli ultimi decenni ci siamo inventati innumerevoli arnesi che fanno risparmiare tempo e ai quali si attribuisce la capacità di farci vivere più rilassati: lavatrici, aspirapolvere, lavastoviglie, telefoni cellulari, computer, posta elettronica.
Prima ci voleva un po’ di tempo per scrivere una lettera, apporre l’indirizzo, affrancare una busta e portarla fino alla buca della posta. E ci volevano giorni o settimane, magari anche mesi, per ricevere una risposta. Oggi posso buttare giù una mail, inviarla dall’altra parte del globo e (se il mio destinatario è online) ricevere una risposta un minuto dopo. Ho risparmiato tutto quel traffico e quel tempo, ma davvero faccio una vita più rilassata? Purtroppo, no. (…) Oggi io ricevo decine di mail ogni giorni, tutte da persone che si aspettano una pronta risposta. Pensavamo che questo volesse dire risparmiare tempo; invece abbiamo accelerato di dieci volte la ruota che macina la nostra vita e reso i nostri giorni più ansiosi e agitati».

Stress, lavoro, nuove tecnologie: l’innovazione che alimenta il burnout
Che cosa succederà quando, nel giro di qualche anno o al massimo un decennio, gli smartphone verranno sostituiti dagli smartglasses, visori in realtà aumentata che sovrappongono il mondo digitale a quello fisico permettendoci di vivere contemporaneamente in entrambi i reami?
Le mail, le telefonate, le notifiche, gli appuntamenti e quant’altro non saranno più nel nostro smartphone, ma appariranno direttamente davanti ai nostri occhi; aumentando ancor più la nostra capacità di gestirle in tempo reale, qualunque attività si stia svolgendo. E se adesso dobbiamo decidere di prendere in mano lo smartphone per collegarci, in futuro dovremo decidere di toglierci il visore per scollegarci. Una differenza fondamentale: la nostra condizione di base sarà connessa alla rete e al fiume di attività lavorative e non che possiamo gestire con gli headset; per staccare dovremo decidere di levarceli dagli occhi.Il nostro sistema operativo, vale a dire il cervello, riuscirà a reggere il colpo o rischia invece di collassare sotto i colpi di una tecnologia che ci costringe ad andare sempre più veloci, ad aumentare in rapidità, precisione ed efficienza anche se tutto ciò ci conduce inevitabilmente al burnout o all’esaurimento? In verità, questa domanda potrebbe essere mal posta. Invece di ripensare le condizioni che hanno trasformato i millennials in una generazione di esauriti, sono già allo studio innovazioni tecnologiche – anzi, biotecnologiche – che potrebbero consentirci di lavorare ancora di più. Alcuni scienziati stanno infatti lavorando a una pillola contro il burnout.
Una futura pillola contro il burnout dovrebbe avere il compito di inibire la produzione di nocicettina e impedirci così di arrivare al punto in cui, di fronte a troppo stress e a un eccessivo carico di lavoro, decidiamo estenuati di arrenderci.
In uno studio pubblicato sulla rivista accademica Cell nel luglio 2019, alcuni scienziati della Washington University hanno illustrato le loro ricerche volte a comprendere come e perché il burnout si manifesti. A questo scopo, hanno studiato il cervello dei topi da laboratorio per comprendere che cosa succede quando smettono di inseguire una gratificazione; in che momento, quindi, subiscono un burnout.
Nelle loro ricerche, sono riusciti a rintracciare le cause del burnout in alcune cellule che sembrerebbero essere all’origine della nostra necessità, a un certo punto, di alzare bandiere bianca di fronte a un compito non essenziale.
L’esperimento che ha permesso ai ricercatori di fare queste scoperte è piuttosto semplice. Una cavia aveva il compito di colpire con il naso un bottone presente nella sua gabbia, quando completava la missione riceveva in cambio acqua zuccherata. Mano a mano che lo studio procedeva, il numero di volte che il bottone andava colpito per ricevere in cambio il premio non faceva che aumentare; fino al punto in cui doveva essere colpito 100 volte per ottenerlo. Molte delle cavie si sono arrese prima. Erano quindi vittima di una sorta di esaurimento mentale, che imponeva di rinunciare al premio.
Dietro questa mancanza di motivazione ci sarebbe un neuromodulatore: la nocicettina. Nel caso del topo frustrato, la presenza crescente della nocicettina nel suo cervello stava rendendo sempre più difficile alla dopamina – legata alla motivazione che ci sprona a ottenere le ricompense – fare il suo lavoro di stimolante.
Per il momento, fortunatamente, l’obiettivo esplicito di questi studi non riguarda la produzione di una pillola che impedisca al burnout di evolvere in esaurimento, ma quella di combattere le dipendenze (che dipendono anch’esse dalle interazioni tra nocicettina e dopamina). Resta il fatto che questa inquietante prospettiva è tutt’altro che fantascienza. Anzi, vista l’esplosione di stimolanti come il Ritalin o l’Adderall – che aiutano a mantenere ritmi di lavoro forsennati – una pillola per sconfiggere il burnout non sarebbe altro che il logico passo successivo.
Più il topo va a caccia del premio, più le cellule della dopamina producono questa sostanza, motivandolo a proseguire e a schiacciare il bottone. Ma quando il lavoro inizia a farsi troppo complesso, le cellule deputate alla produzione della nocicettina entrano in gioco: «Di base, appena prima che l’animale si arrenda è il momento in cui questa attività neuronale raggiunge l’apice», ha spiegato a Inverse Michael Bruchas, primo firmatario dello studio. In sintesi, una futura pillola contro il burnout dovrebbe avere il compito di inibire la produzione di nocicettina e impedirci così di arrivare al punto in cui, di fronte a troppo stress e a un eccessivo carico di lavoro, decidiamo estenuati di arrenderci; passando dal burnout all’esaurimento.