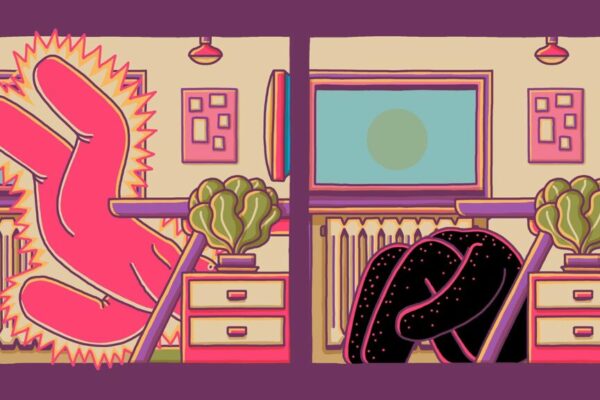Recentemente ho vissuto un periodo di burn out e depressione piuttosto pesante. Il mio lavoro è quello che generalmente si definisce culturale – giornalismo, scrittura e comunicazione -, lo svolgo principalmente da casa. La crisi di salute mentale mi ha costretto ad alcune settimane di pausa: ero impossibilitata a scrivere, mi riusciva difficile interagire con le persone, organizzare l’agenda, svolgere i compiti quotidiani. Per un lasso di tempo non indifferente ho dovuto semplicemente concedermi il tempo di guarire.
L’impressione di aver bruciato tutte le energie mentali e fisiche una condizione tipica dei lavori creativi. Il punto centrale è proprio la disponibilità di tempo. Ho beneficiato di un privilegio nascosto che è comune a molte persone che svolgono lavori culturali con un background di classe media – quello del tempo libero indispensabile al lavoro creativo.
La sensazione a freddo è quella di aver beneficiato di uno dei privilegi meno discussi nell’ambito delle professioni culturali: quello di classe. Alcuni dei suoi aspetti sono più visibili: una stabilità economica pregressa, risparmi da parte, un tetto garantito sopra la testa, un partner che si occupa del lavoro di cura e della casa mentre io mi posso dedicare alla scrittura. Altri sono più impliciti: l’aver avuto accesso alla cultura fin da piccola, l’aver potuto studiare all’Università, l’avere accesso a una rete di supporto in caso di difficoltà.
Il tabù
Dagli anni Ottanta in poi, con l’ascesa del neoliberismo, la classe è diventata un grande tabù: anche in un’epoca come la nostra, in cui i discorsi su altre forme di diseguaglianza (di razza, di genere, di orientamento) hanno raggiunto il mainstream. Parlare di capitali economici e di soldi ci mette a disagio, significa affondare i denti in un rimosso della società neoliberale e post-capitalista. Significa mettere in luce delle strutture a cui, per decenni, ci hanno abituato a non pensare. È stata assorbita a più livelli l’idea che la società sia composta da individui, da identità singole, scomponibili in micro-categorie, non da strutture sistemiche rette su interessi materiali.
Scrive Cynthia Cruz in Melanconia di Classe (edizioni Atlantide). “Poiché le persone della working class hanno sperimentato una morte simbolica, tentare di parlare di classe sociale significa evocare un fantasma”. Non solo le persone di working class e la loro esistenza sono cancellate, ma l’intera categoria teorica e analitica viene rimossa.
L’assenza della classe dal discorso pubblico – anche da quello progressista – si riflette a più livelli anche nell’industria culturale.
La rimozione delle analisi strutturali avviene in favore di un discorso meritocratico: ci si trova in una certa posizione e si gode di certi benefici come risultato del proprio lavoro, dei propri sforzi e del proprio merito.
L’assenza della classe dal discorso pubblico – anche da quello progressista – si riflette a più livelli anche nell’industria culturale. In Europa, e in Occidente, la musica, la letteratura, il giornalismo, il cinema sono tutte espressioni di una cultura di classe dominante, borghese (e spesso, di conseguenza, anche maschile e bianca).
In uno studio pubblicato nel 2018, la piattaforma britannica Analysis and Policy Observatory (APO) ha analizzato la composizione di classe dell’industria culturale del paese: “La mobilità sociale è stata un problema di lunga data per il settore” si legge,” il che significa che attualmente è dominato da coloro che provengono da origini sociali agiate. Inoltre, non c’è stato un “periodo d’oro” per la mobilità sociale nel settore culturale. Allo stesso tempo, la nostra analisi (…) mostra che gli intervistati meglio retribuiti sono più propensi a pensare che il settore premi il talento e il duro lavoro, e sono meno propensi a vedere esclusioni di classe, etnia e genere nella forza lavoro”.
In Italia si sta da poco iniziando a fare attenzione al tema delle narrazioni working class: la casa editrice Alegre ha inaugurato una collana dedicata alle storie operaie, che pubblica autori sia italiani che stranieri, curata da Alberto Prunetti – che ha firmato il libro “Non è un pranzo di gala, indagine sulla letteratura working class”. Si tratta di un caso abbastanza eccezionale nel nostro paese, dove la classe creativa è generalmente espressione di un ceto medio urbano e abbiente, ad altro tasso di capitale sociale ed economico.
Rappresentazione e cancellazione
Come si inserisce il discorso di classe all’interno di una riflessione sul settore culturale in Italia (ma non solo)? Ne ho parlato con Giusi Palomba, scrittrice e traduttrice, che ha partecipato recentemente al Festival di Letteratura Working Class organizzato dal Collettivo di Fabbrica GKN. Non si può, secondo Palomba, ridurre il discorso sulla classe a un discorso di pura rappresentazione o a un discorso di inclusività e identitarismo superficiale.
“Parlare di classe in chiave identitaria è un po’ una sconfitta, può diventare una scorciatoia facile per rendere appetibili le nostre storie, per semplificarle e rivenderle al miglior offerente, magari facendole diventare materiale per l’ennesima lezioncina di inclusione”, mi dice. “A mio avviso non possiamo ridurci a un problema di rappresentazione, non si tratta di rendere certi autori una categoria protetta, il punto è l’ingiustizia di un intero sistema, che parte dall’insostenibilità dei processi produttivi, di cui si parla molto poco. Se parliamo di libri, la filiera editoriale si regge su una precarietà materiale completamente silenziata, che parte da chi scrive e arriva fino a chi fabbrica e muove i libri. C’è chi può affrontare tutto questo con più disinvoltura e chi ne esce abbastanza a pezzi, con l’aggravante della quasi totale mancanza di riconoscimento del problema e di strumenti collettivi per affrontarlo.”
Parlare di classe in chiave identitaria è un po’ una sconfitta, può diventare una scorciatoia facile per rendere appetibili le nostre storie, per semplificarle e rivenderle al miglior offerente.
La filiera culturale italiana – chi la cultura la realizza , la produce e la distribuisce, – vede lavoratori con salari sempre più bassi e sempre meno garanzie. Tutto il settore dei media, dell’editoria, del giornalismo, soffre di una sorta di schizofrenia: è popolato di persone che vengono pagate pochissimo per giornate lavorative molto lunghe. I figli della classe media urbana, quindi investono grandi quantità di capitale economico per entrare in un’industria impoverita e precaria. Anche questo è un meccanismo di riproduzione di classe. Chi può permettersi di fare lunghi stage non pagati se non i figli dei più abbienti? E chi può mantenersi in un mondo di precariato e di rischio continuo se non chi ha già una stabilità economica alle spalle? È un fenomeno di cui si discute da tempo: Raffaele Alberto Ventura, nel suo Teoria della classe disagiata del 2017 la chiama disforia di classe, la tragedia di un ceto medio impoverito che non riesce a lasciare andare i propri beni simbolici, il suo attaccamento alle professioni considerate prestigiose ma, nella pratica, sempre meno remunerative. Nel settore dei media e della cultura è spesso più importante vedersi riconoscere dei traguardi (pubblicare un libro, partecipare a un evento, frequentare determinati ambienti) piuttosto che vedersi riconoscere un salario equo; diviene più importante il posizionamento rispetto alle rivendicazioni materiali. Questo non fa che escludere chi non possiede quel capitale iniziale da spendere. La classe sociale è quindi soggetta a una doppia cancellazione. Se la working class non è raccontata né rappresentata nei media, se non tramite stereotipi o romanticizzazioni il settore creativo continua a negare e di conseguenza a riprodurre le disuguaglianze ad esso intrinseche. Mettere in parallelo le due condizioni, però, non significa affermare che siano equivalenti.
Se la working class non è raccontata né rappresentata nei media, se non tramite stereotipi o romanticizzazioni il settore creativo continua a negare e di conseguenza a riprodurre le disuguaglianze ad esso intrinseche.
Di nuovo Giusi Palomba: “Aldilà dei percorsi individuali, questo vuoto di voci dai margini si riflette sull’immaginario collettivo. I problemi, i sogni, i desideri, le paure che entrano nel discorso culturale, sono quelli della classe media e diventano un’eco incapace di confrontarsi con altri suoni, almeno finché non è più possibile ignorarli. Allora, non mancano delle odiose distorsioni: condiscendenza, invalidazione o appropriazione, tanto per iniziare, o la presunzione di poter essere interpretati al posto di chi quei suoni li esprime. Un esempio di interpretazione distorta è che anche la classe media è di certo impoverita dal settore, ma la situazione di precarietà di chi ha altre sicurezze è differente da quella di chi non ne ha. Le due realtà vengono spesso sovrapposte, anche se non si equivalgono”.
Lotta e privilegio
Se parlare di privilegio è diventato quasi un modo cool di posizionarsi rispetto alle questioni sociali, parlare di privilegio di classe e di quello che comporta è ancora un argomento che mette a disagio. Eppure, il fantasma della questione di classe si aggira nel labirinto del settore culturale. Parlando del contesto britannico, Palomba continua: “Io vivo in Scozia, dove in questi ultimi anni l’attenzione verso l’autorialità working class è altissima. Il classismo profondo ed autoevidente di cui è pervasa la società britannica ha fatto emergere un desiderio di raccontarsi fuori dalle narrazioni paternalistiche e colpevolizzanti dei media. Sicuramente le risorse investite da grandi case editrici anglofone sono state importanti per dare spazio a nuove storie, ma credo che questo investimento sia conseguenza di un cambio nella cultura collettiva”. In Italia siamo ancora piuttosto indietro, anche se qualcosa si sta muovendo a livello di rivendicazioni sindacali, nell’ambiente artistico ed editoriale. “La critica (in contesto britannico, ndr) è anche molto accesa e avanzata sul tema, e rende evidente anche i rischi concreti che la nostra rabbia e le nostre condizioni di vita diventino l’ennesimo prodotto, addomesticato e vendibile, e alla fine controllato comunque dalla classe media”.
Se parlare di privilegio è diventato quasi un modo cool di posizionarsi rispetto alle questioni sociali, parlare di privilegio di classe e di quello che comporta è ancora un argomento che mette a disagio.
Le dinamiche di esclusione a cui assistiamo vanno dal costo della formazione, al precariato diffuso, alla mancanza di tempo e di energie. L’analisi delle diseguaglianze sistemiche che stanno alla base dell’esclusione dall’industria degli artisti di working class può essere uno strumento importante di lotta per una modifica radicale del sistema.
Per avere una possibilità di cambiare dobbiamo innanzitutto comprendere: per questo la rappresentazione della classe, del privilegio e dell’esclusione deve emanciparsi dagli stereotipi consolatori ed essere all’altezza della complessità dei tempi che stiamo vivendo.