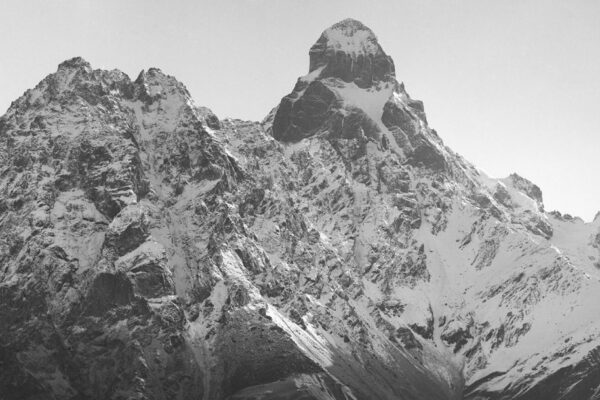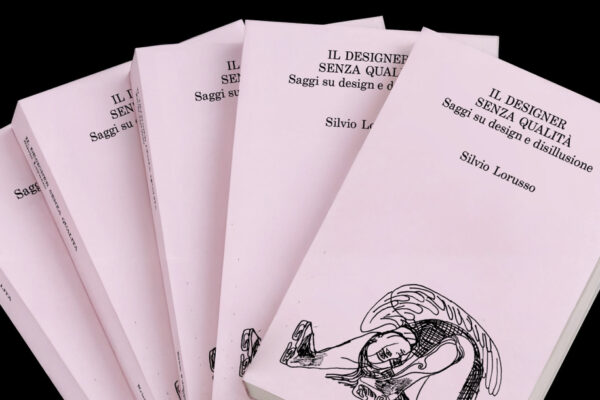Il progetto di ricerca scientifica e fotografica “The Cooling Solution” vuole indagare l’utilizzo dell’aria condizionata in vari paesi (India, Indonesia, Brasile, Italia) nonché i possibili stratagemmi per il raffrescamento offerti dalla costruzione edilizia consapevole e l’innovazione tecnologica. Abbiamo avuto modo di fare qualche domanda a Gaia Squarci, fotografa del progetto, e a Jacopo Crimi che, oltre al suo lavoro di divulgazione, ricerca e mediazione, ha viaggiato con Gaia nei paesi coinvolti nel progetto.
L’aria condizionata sembra la risposta più immediata a un problema sempre più diffuso, ma se da un lato per alcuni resta una soluzione irraggiungibile, dall’altro non è la strada migliore per ciò che i dati mostrano sul futuro che ci attende.
“The Cooling Solution” ci chiama in causa direttamente chiedendoci: qual è la nostra soluzione?
CA: Come è nato il progetto?
JC: Tutto è partito da una ricerca che stavo seguendo: da più di dieci anni mi occupo di divulgazione scientifica collaborando con le università. In questo caso, conoscendo già Gaia per altri progetti seguiti insieme, sono andato dalla mia referente, la Professoressa di Economia Ambientale dell’Università Ca’ Foscari, e ho proposto di coinvolgere lei piuttosto che comprare immagini stock. Una volta tornati con le prime immagini, la Professoressa è stata talmente entusiasta da proporci subito una mostra.
GS: Però non accettammo subito. Le fotografie realizzate in quella prima spedizione non giustificavano una mostra, a mio avviso, e quindi rifiutai. Però credo che questo primo rifiuto abbia spinto tutti a cercare i fondi necessari per ampliare il lavoro. Jacopo era molto determinato, Enrica De Cian ha combattuto per riuscire a finanziare il progetto, cosa che creò molto scompiglio in ambiente accademico. I fondi trovati, poi, sono serviti non soltanto a finanziare i viaggi, ma anche per confezionare i prodotti finali, tra cui l’allestimento curato da Kublaiklan, il collettivo che ci ha seguito, e la stampa del catalogo.
Sono entrata nelle case delle persone nello stesso modo in cui mi sarei comportata a due chilometri da casa mia.
CA: Oltre a un’attenzione molto lucida all’ambiente in cui vivono i soggetti (un aspetto che appartiene già molto alla ricerca di Gaia) trovo che non sia presente alcun elemento “pietistico” all’interno degli scatti: sebbene si tratti di un argomento che affronta situazioni di disagio, i soggetti non sono mai rappresentati con un esplicito riferimento alla sofferenza legata alle condizioni climatiche in cui vivono. C’è un’intenzionalità specifica dietro questo aspetto del tuo lavoro?
GS: Mi ha aiutato molto il fatto che il punto di partenza fosse una ricerca scientifica, sebbene da un lato abbia dovuto limitare un po’ la mia libertà di espressione rispetto ad altri lavori. Ero l’unica persona con un background creativo. Ci sono poi le mie considerazioni sull’approccio alla fotografia. Quando andavamo a incontrare le persone, spesso non potevamo passare con loro molto tempo, (due ore al massimo), quindi non mi sarei mai azzardata a voler raccontare più di quanto potessi vedere e interpretare oggettivamente. Un altro discorso è quello relativo alle vite che incontravamo, spesso legate a situazioni di difficoltà in paesi non occidentali che si stanno sviluppando ora. Questo ha fatto sì che cercassi non soltanto di non calcare la mano sugli aspetti pietistici, ma che cercassi anzi di fotografare all’estero come avrei fotografato in Italia. Sono entrata nelle case delle persone nello stesso modo in cui mi sarei comportata a due chilometri da casa mia. Naturalmente siamo sempre impregnati di una visione occidentale e imperialista, però più lo si tiene a mente, più si riesce a limitare questa componente.

CA: Sul sito dedicato al progetto si legge: “Abbiamo provato a disseminare indizi visivi nelle immagini, mostrando spazi claustrofobici senza finestre la cui architettura ignora il bisogno di aria condizionata, e aree il cui sviluppo è basato sul profitto facile piuttosto che sulle necessità essenziali umane.” In effetti è difficile comunicare il caldo, o la temperatura in generale, attraverso un’immagine. Non vedo neanche stratagemmi visivi operati in postproduzione o in ripresa, come ad esempio ha fatto Paolo Virzì nel film “Siccità”. A volte vedo che è stata usata un’illuminazione ausiliaria.
GS: Usavo principalmente uno stand (un treppiede regolabile in altezza con un braccio per poter posizionare il flash, nda): un set molto semplice. Per il discorso cromatico ho cercato di tenere a mente un certo rigore. Chiaramente, se un’immagine si presentava con tonalità molto fredde qualche piccolo intervento ho dovuto farlo, ma si tratta di poca cosa. Non ho mai voluto che il senso dell’immagine facesse leva o si basasse principalmente su questo.
Non c’è niente con cui possiamo identificarci di più rispetto a una persona che sta a casa sua.
CA: Esistono due binari paralleli nella narrazione fotografica: uno di descrizione degli ambienti esterni, della realtà sociale e delle sue forti disparità lette attraverso l’architettura, e uno relativo a singoli individui, ritratti all’interno delle proprie abitazioni. Avevate già in mente di strutturare così il lavoro o ha preso forma durante il corso della sua realizzazione?
JC: Ѐ arrivato un po’ dalla ricerca: i dati parlavano chiaramente delle disparità legate ai ceti sociali, e arrivati lì abbiamo toccato con mano la realtà effettiva di quei dati. Per il primo viaggio in India eravamo partiti per fare fotografie stock, ma è nelle immagini collaterali realizzate da Gaia, indirizzate alla realtà sociale e ambientale, che abbiamo capito che direzione prendere. A quel punto abbiamo deciso di coinvolgere un’antropologa nel progetto di ricerca. Ci siamo resi conto che l’aspetto umano era ciò che poteva veicolare con maggior forza il messaggio.
GS: Il primo viaggio in India, poi, è stato quello in cui si riusciva a vedere più chiaramente questo divario. C’erano quartieri che sono cambiati in poco tempo e che hanno ancora la traccia della grande trasformazione in atto: vedevi proprio la casa di lamiera con dietro l’hotel di lusso. In India, poi, stavamo seguendo molte storie diverse per un altro progetto, “Passenger”, ed è stato un bene seguirne così tante perché ci ha portati a scoprire posti e situazioni molto utili per “The Cooling Solution”. Il fatto di entrare nelle case è stato utile per strutturare un immaginario sull’argomento dell’aria condizionata, che rischia di essere astratto o troppo banale. Penso in fondo che non ci sia niente con cui possiamo identificarci di più rispetto a una persona che sta a casa sua, e questa idea mi ha guidata molto. Ci sono diverse capacità di far fronte a questo calore, ed è lì che ho pensato che se una persona in Occidente può identificarsi con una persona che vive in un insediamento illegale in Brasile, è proprio l’ambiente domestico che può creare quel parallelo.
Un incontro che abbiamo avuto con due persone, entrambe in sedia a rotelle, che usavano l’aria condizionata solo in una stanza e solo di notte. Sebbene facessero parte della lower middle class non potevano permettersi questo utilizzo di aria condizionata, perché andava a costare il 40% del loro budget mensile.
CA: Oltre all’Italia siete stati in India, in Indonesia e in Brasile. Quanto è durata mediamente la vostra permanenza nei paesi coinvolti nel progetto?
JC: Abbiamo passato circa tre settimane nei paesi tropicali. All’inizio la ricerca riguardava, oltre all’India, l’Indonesia e il Brasile anche il Messico. Ho proposto di rinunciare al Messico in favore dell’Italia proprio per creare un legame reale con le persone che volevamo coinvolgere. In Italia invece siamo riusciti a frammentare il lavoro con vari soggiorni in più città. Spostare l’attenzione sull’Italia è stata un’intuizione importante, proprio per capire, grazie alle fotografie di Gaia, la vera connessione di realtà così distanti con la nostra dimensione.

GS: Esatto. Questi tre paesi sono stati scelti per motivi precisi: perché tropicali, perché in via di sviluppo, perché molto popolosi e perché l’Università aveva dati demografici più accurati rispetto ad altri. Ci si è focalizzati sulle case private e si è scoperta una differenza netta di comportamento rispetto all’acquisto dell’aria condizionata. Dato che questi paesi sono già molto caldi, le persone comprano l’aria condizionata appena possono permetterselo; in Italia, in cui le temperature non sono altrettanto torride e culturalmente siamo meno predisposti all’acquisto dell’AC (come magari sono invece gli Stati Uniti o il Giappone), siamo comunque portati a utilizzarla di più perché le temperature stanno effettivamente crescendo.
JC: Nella ricerca si vede che è proprio il reddito la discriminante per l’acquisto dell’aria condizionata nei paesi tropicali in via di sviluppo. In Italia la ragione è quasi esclusivamente climatica.

CA: Quale episodio o situazione in particolare vi sono rimasti più impressi?
GS: Ci sono state tante situazioni in Brasile. Una che può dare un’idea di cosa voglia dire il concetto di “povertà energetica” è un incontro che abbiamo avuto con due persone, entrambe in sedia a rotelle, che usavano l’aria condizionata solo in una stanza e solo di notte. Sebbene facessero parte della lower middle class non potevano permettersi questo utilizzo di aria condizionata, perché andava a costare il 40% del loro budget mensile. Rivelatorio se pensiamo a chi non può fare a meno dell’aria condizionata, persone più fragili come anziani, bambini, donne incinte, disabili, e su quanti strati di povertà energetica esistano.
JC: Io citerei quando ci siamo sentiti in situazioni estreme per il caldo. Noi in un certo senso cercavamo il caldo, perché era l’oggetto della nostra ricerca, ma quando siamo arrivati a Giacarta non ci potevamo credere, pensavamo di essere all’inferno. Anche Dandara è stata una città scioccante.
CA: L’allestimento del lavoro e la sua razionalizzazione in termini di scelta delle immagini e struttura della sua narrazione interna hanno avuto un ruolo importante ed è stato seguito dal collettivo Kublaiklan. Ce ne parlate?
GS: Il collettivo Kublaiklan era l’unica realtà slegata dall’esperienza sul campo, quindi quando siamo arrivati a sei/ottocento fotografie da selezionare, è stato in grado di riconoscere quali potessero avere più attinenza ai dati e al progetto e quali avessero un’omogeneità stilistica (ci sono state varie discussioni su alcune foto). Così, attraverso il confronto, e talvolta lo scontro, dei nostri punti di vista, si è arrivati a un risultato ottimale.
JC: Kublaiklan, poi, si è occupato della veste grafica: a partire dall’idea dei colori, molto semplice, ma forte (rosso-problematiche / blu-soluzioni / nero-storie), in grado di dare ritmo alla narrazione e utilissimo per fare ordine tra tutto il materiale raccolto.
Ho visto alcune persone entrare in crisi perché capivano per la prima volta il peso e la responsabilità delle proprie azioni.
CA: Che tipo di riscontri avete avuto presentando il progetto nelle città in cui lo avete esposto?
JC: C’è da dire che inizialmente abbiamo creato la mostra esclusivamente per Venezia. Poi, vista la qualità del prodotto, ci siamo convinti che avremmo trovato i fondi per proporla in altri spazi. Siamo così riusciti a trovare l’interlocutore giusto per portare il lavoro a Londra, all’Istituto di Cultura Italiana, a New York in occasione di Photoville, e a Milano grazie a Edison.
GS: Abbiamo proiettato uno slideshow ad un festival in Indonesia, unico posto non Occidentale dei paesi coinvolti. La differenza nei posti è stata legata a quella presente fra grandi istituzioni e festival più piccoli. Nelle località in cui una parte di allestimento è stata disposta in strada (New York e Venezia) c’è stata molta partecipazione. Anche nei vari talk è stato bello sentire un coinvolgimento sincero e attivo nei vari momenti di confronto.
JC: In ogni città abbiamo portato il pannello che ti mostro, che porta a far riflettere le persone e a posizionare un bollino per rispondere a una domanda sulle modalità con cui affrontano il caldo. Questo ha portato a mettersi in discussione, a confrontarsi coi propri familiari. Una modalità semplice che prendeva declinazioni diverse rispetto alle varie città in cui andavamo, nonché uno strumento che potrebbe essere utile anche per la ricerca accademica.
GS: La domanda principale era: “What is your cooling solution?” proponendo quattro risposte diverse tra cui scegliere. Ho visto alcune persone entrare in crisi perché capivano per la prima volta il peso e la responsabilità delle proprie azioni.
Avrei preferito tornare a casa senza fotografie, piuttosto che con le immagini sbagliate.
CA: In questo genere di operazione, il fotografo è investito di una grande responsabilità, ovvero quella di illustrare, di portare a un pubblico più vasto possibile alcuni dati che altrimenti rimarrebbero forse oscuri, intelligibili soltanto dagli addetti ai lavori. Come percepisci e ti rapporti (Gaia) con questa responsabilità?
GS: Avevo molto chiaro quello che non volevo fare rispetto a quello che volevo effettivamente fare. Non volevo perpetrare stereotipi visivi, come hai notato, ma volevo creare un senso di empatia. Così come volevo evitare di focalizzare l’attenzione su eventi catastrofici, bensì raccontare una quotidianità che già vive in una situazione di emergenza. La responsabilità l’ho sentita in modo molto forte in questo sapere cosa non voler fare: avrei preferito tornare a casa senza fotografie piuttosto che con le immagini sbagliate.

CA: Un aspetto chiave del progetto “The Cooling Solution” è la parte dedicata ai possibili stratagemmi che l’architettura ha messo in atto, o potrebbe mettere in atto, per fare fronte alla necessità di controllo della temperatura nelle abitazioni. Nel progetto viene riportato l’esempio di Tegal, città indonesiana, come “edilizia sociale a basse emissioni di carbonio”, ci puoi (Jacopo) spiegare di cosa si tratta?
JC: Quello di Tegal è il progetto che preferisco. Tutte le altre soluzioni sono in fin dei conti applicabili solo da persone di ceto alto: si ha bisogno di spazio, di un giardino, di una doppia esposizione, e quindi spesso la soluzione diventa una cosa elitaria e poco distribuibile. Quello che citi è l’unico che prende in considerazione sia la situazione sociale e popolare, sia una effettiva praticità della soluzione. A Tegal è stato affascinante perché in questa casa avevano disposto moltissimi sensori sulle diverse superfici per testarne l’efficacia. Finiti gli esperimenti, quindi, questa casa sarebbe davvero confluita in un progetto di edilizia popolare per poterne replicare il modello per le nuove costruzioni.
GS: Parlando con un architetto indonesiano abbiamo scoperto che una decina di anni fa venne costruito l’edificio del Ministero dell’Agricoltura di Giacarta a forma di piramide di vetro, naturalmente insostenibile in termini di temperatura. Ho capito così quanto sia fondamentale l’idea di status sia nei nostri paesi, ma ancora di più nei paesi emergenti, dove l’uso dell’aria condizionata è simbolo di un certo grado di benessere (penso agli hotel di lusso che in estate tengono la temperatura a 19 gradi, o a chi in Brasile può andare in ufficio in giacca e cravatta perché prende il taxi e lavora in luoghi climatizzati).

CA: Ѐ un progetto considerabile concluso o c’è la volontà/possibilità di andare anche in altri Paesi per espandere il raggio di ricerca?
JC: La volontà c’è tutta, anche da parte della Professoressa De Cian. Vorremmo analizzare gli Stati Uniti, in cui Gaia lavora. Adesso con Gaia andremo in Etiopia per un altro tema, e ci piacerebbe sfruttare l’occasione per ampliare il progetto. Dopo l’estate avremo quindi USA ed Etiopia, con l’idea in generale di andare avanti trasformando il progetto in un lavoro in itinere che andremo di volta in volta ad aggiornare.
CA: Volete fare delle considerazioni finali?
GS: Vorrei sottolineare il significato del titolo del progetto, che mette in discussione il fatto che l’aria condizionata possa essere una soluzione, ma gioca anche con ciò che noi consideriamo una soluzione, a chi è accessibile e quali conseguenze comporta.
JC: Parte della soluzione infatti sono certamente i sistemi ultra efficienti, ma che ad oggi rimangono appannaggio di pochissimi. Vorrei ancora aggiungere solo che per il mio lavoro di divulgazione scientifica è una grande soddisfazione poter raggiungere un pubblico più ampio di quello che normalmente viene stimolato dalla normale divulgazione attraverso paper e articoli. Vedere le persone discutere e fare domande mi dà la certezza che questo lavoro smuova la riflessione e il pensiero critico, che è esattamente ciò a cui si punta facendo ricerca. Ed è così che le cose cambiano.
Fotografie di Gaia Squarci
European Research Council a cura del team ENERGYA guidato dalla Prof.ssa Enrica De Cian di Economia ambientale a Ca’ Foscari e ricercatrice presso la Fondazione CMCC.
Progetto coordinato da element6.eu
Con la curatela di Kublaiklan
La mostra a Milano è realizzata con il supporto della Fondazione CMCC e di Edison.