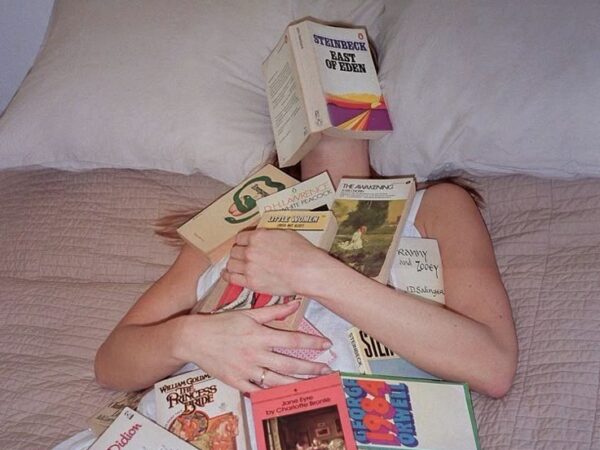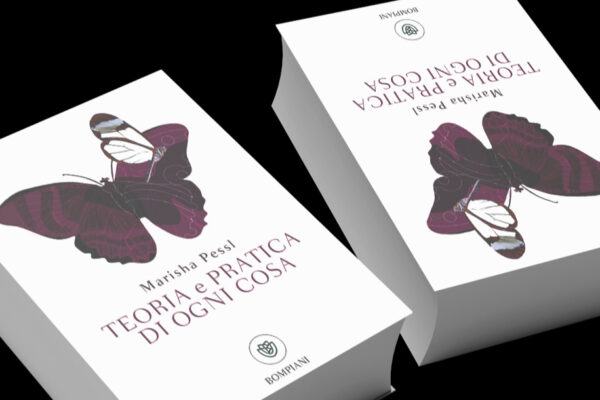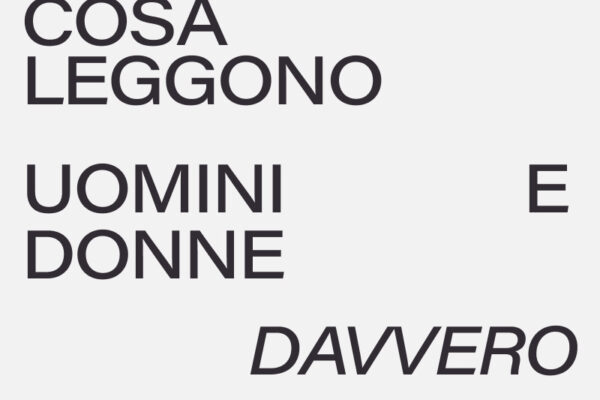Da bambina volevo leggere tutti i libri del mondo. Sono cresciuta in una casa con più librerie che pareti, dove la lettura era considerata un rito sacro alla stregua della preghiera. La mia curiosità, insieme alla mancanza di senso del numero tipica dell’infanzia, mi avevano convinta che fosse un obiettivo realizzabile. Ovviamente, mi sono accorta presto del contrario; ma non avrei mai immaginato che, da grande, avrei finito per trovare angosciante l’uscita di un nuovo libro.
Il Book Pride Milano 2025: una “fase delicata”
Lo scorso weekend si è tenuto il Book Pride Milano 2025, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente. Io ho seguito l’evento da lontano, rallegrandomi nel constatare la sua discreta riuscita – un’ottima affluenza nonostante la pioggia – senza però riuscire a togliermi dalla testa il pensiero della crisi. Sarà stato il tema, “Danzare sull’orlo del mondo”, un claim a metà tra Battiato e Nietzsche che alludeva suo malgrado all’abisso; oppure, più probabilmente, la consapevolezza delle particolari premesse su cui questa edizione si è retta. Come forse ricorderete, infatti, a gennaio ci era stato annunciato che il Book Pride entrava a far parte dei progetti del Salone del Libro di Torino per salvarsi da una difficile situazione finanziaria. La notizia è passata un po’ in sordina, forse perché ha seguito le polemiche legate a Più Libri Più Liberi; eppure è stata senza dubbio significativa per quanto riguarda il costante rischio di crollo che ormai caratterizza tutto il settore, in cui gli indipendenti, come sempre, fanno solo da canarino del minatore. Non a caso, si legge su Il Libraio, la scelta strategica di affiliarsi al Salone avrebbe anche lo scopo di sostenere il risanamento della piccola e media editoria italiana, che attraversa una “fase delicata”. Per giunta, a questa affermazione fanno eco i dati NielsenIQ-GfK presentati dall’Associazione Italiana Editori a fine gennaio, secondo cui nel 2024 il mercato del libro italiano ha chiuso con una perdita stimata di 62,7 milioni di euro.

Sono “cintura nera di tsundoku”, quindi non condanno la pratica di comprare libri senza leggerli.
Lo stato di salute dell’editoria italiana è tanto complesso da non poter essere ridotto a un’analisi di mercato annuale, ma questa, insieme alla vicenda del Book Pride, ci dà l’idea della sua notevole fragilità. Negli anni, la crisi dell’industria del libro nostrana ci è stata motivata in molti modi: il calo generale dei lettori, i Grandi Gruppi che divorano le PMI, il peggioramento della qualità delle pubblicazioni, i media digitali che influenzano le nostre abitudini, la demolizione del sistema educativo nazionale, le librerie che chiudono a causa delle piattaforme di vendita online. Certo è che oggi in Italia si pubblica molto di più di quanto si legge, e per saperlo non servono statistiche: è una verità che tutti possiamo constatare nella vita quotidiana. Ma che ripercussioni ha questo fenomeno sulle nostre vite, in particolare sulla nostra salute mentale e sul nostro sapere? Non posso promettervi risposte esaustive, ma sento l’urgenza di condividere alcune riflessioni fatte di recente, nella speranza di rinfocolare il dibattito sul tema.
L’ansia dei libri non letti
Sono “cintura nera di tsundoku”, quindi non condanno la pratica di comprare libri senza leggerli. Al di là del sostegno economico al settore in contrazione, la mia posizione in merito deriva dall’aver abbracciato la lezione dell’anti-biblioteca di Umberto Eco. Credo fermamente che i libri non letti siano più importanti di quelli letti, e li accumulo per nutrire la mia collezione personale, che considero uno strumento di ricerca. L’esperienza mi ha insegnato che anche i titoli più insospettabili, prima o poi, possono tornare utili, perciò non mi faccio mai problemi ad accoglierne di nuovi – anche solo per nutrire la mia insana bibliofilia. Per giunta, penso che i libri non letti rappresentino un monito contro la superbia: parafrasando quel che scrive Nassim Nicholas Taleb in Il cigno nero, mi ricordano quanto sia limitata, provvisoria e fallace la mia conoscenza.
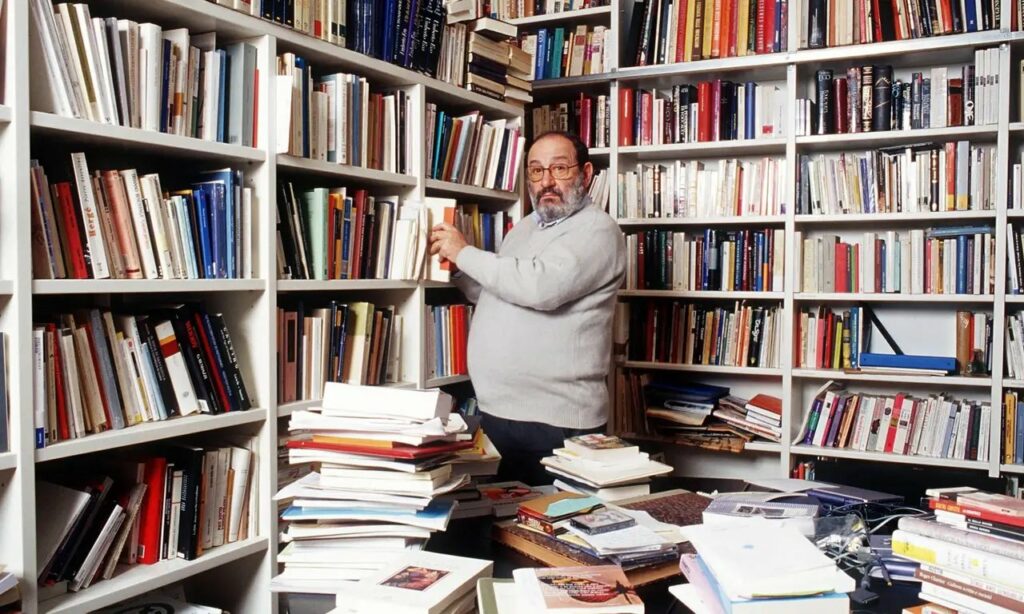
Ciò detto, devo ammettere che, negli ultimi tempi, i libri non letti hanno iniziato a suscitare in me una certa ansia. Non solo faccio fatica a trovare la concentrazione per leggere, ma stento ad arrivare alla fine dei tomi più lunghi, fatto che mi genera frustrazione e vergogna. Dovendo leggere per lavoro, poi, mi trovo spesso a portare avanti più letture allo stesso tempo, consuetudine che avevo anche in passato, ma mai in maniera così disordinata e frammentaria. Come se non bastasse, mentre il mio comodino si affolla di libri interrupti, ho iniziato a soffrire nel sapere che ogni giorno vengono stampate nuove opere che meriterebbero di essere lette. Così entro sempre meno in libreria, evito presentazioni e firmacopie, tollero poco e male le fiere, schivo rubriche e recensioni, non tengo più nota dei suggerimenti di amici e parenti (la mia to-read-list ha già superato i 350 titoli), chiedo espressamente che non mi si regalino altri libri… e a ogni nuovo personaggio famoso che promuove il suo esordio, soprattutto se si tratta di qualcuno che non scriveva già di professione, esclamo: “Oh no, eccone un altro! Ma cos’è, una malattia? Tutti a pubblicare libri adesso! Pare diventata una tappa obbligatoria della carriera!” Non vi dico quando vengo a sapere dell’ennesimo romanzo casareccio edito in self publishing.
Bookworm culture is saying "I have nothing to read" whilst having approximately 3682791 unread books on our shelves.
— Maliha (@CaffeinatedLiha) January 28, 2025
Sospetto che molti di voi si stiano rispecchiando nelle mie confessioni. Non perché siano particolarmente illuminate, ma perché ho già avuto modo di notare come tanti provino la mia stessa ansia. Potrebbe suonare esagerata, ma temo piuttosto sia l’unica possibile risposta alla realtà dei fatti: siamo effettivamente soverchiati dai libri. Il ritmo delle pubblicazioni editoriali è diventato forsennato, stando agli stessi addetti ai lavori; prendendo in prestito le parole dei Coma_Cose, ormai persino i best seller durano come temporali, anche se sono molto popolari. Abbiamo ufficialmente surclassato il concetto di sovrapproduzione editoriale, anzi, di sovrapproduzione culturale. Perché il discorso può essere esteso anche ad altre tipologie di prodotti: film, serie tv, show, album musicali, spettacoli dal vivo. Persino coi podcast è diventato impossibile tenere il passo. Nel caso dell’editoria è semplicemente più evidente perché i libri cartacei occupano un volume fisico all’interno delle nostre case.
Il problema della sovrapproduzione culturale
Di sovrapproduzione culturale hanno parlato recentemente Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon, pubblicando un post che, a mio parere (e non solo, a giudicare dai commenti), mette bene in parole questo sentire. Nella breve ma densa riflessione, il duo di filosofi descrive il mondo della cultura come “una catena di montaggio impazzita, che produce senza sosta e senza chiedersi se c’è davvero qualcuno dall’altra parte in grado di assorbire questa valanga di stimoli”. In questo meccanismo infernale sono intrappolati non solo i consumatori, “paralizzati dall’abbondanza”, ma anche gli artisti, che il mercato costringe a una produzione continua e serrata, intaccando vieppiù il tempo necessario al processo creativo. Il risultato è “un senso di colpa culturale cronico”, “come se fossimo sempre in debito nei confronti di qualche opera che non abbiamo ancora consumato.” Insomma, una specie di enorme e inestinguibile FOMO culturale.
La riflessione di Tlon include nel problema anche una controparte che, pur facendone parte, rischiavo assurdamente di trascurare: chi i contenuti culturali li produce. Lavoro da più di dieci anni come autrice di teatro, quindi rientro in un settore di nicchia che, per molti motivi, non sottostà pienamente ai ritmi delle altre industrie – complice una certa antieconomicità secondo molti connaturata all’arte teatrale stessa. Eppure, anche lì, nonostante la scarsità di pubblico e la tragica crisi di settore, si è iniziato a percepire la pressione a creare sempre di più e sempre più velocemente, a fronte di una circuitazione pressoché nulla. Il mercato teatrale è sovrappopolato, frammentato, sempre più povero di finanze e di contenuti, ma l’offerta supera nettamente la domanda, anzi: assistiamo a una generale sovrapproduzione di spettacoli, quasi tutti destinati incontrare pochissimo pubblico e a morire in un paio di repliche. A ergersi su questo panorama desolante, sono pochi artisti fortunati, costretti a produrre incessantemente per non perdere l’invidiata porzione di oligopolio.
Ma sono ben contenta che qualcuno di famoso abbia rotto il silenzio sul problema e, al contempo, ci abbia anche dispensati dall’ennesimo spettacolo senza urgenza creativa.
È in questo contesto che, a mio parere, si inquadrano eventi come il recente annullamento dello spettacolo Non hanno un amico 2 a opera di Luca Bizzarri – con tanto di lettera di scuse agli spettatori. Un gesto che ha destato l’indignazione di molti miei colleghi, costretti come me a lottare ogni giorno per sbarcare il lunario, ma con cui io non posso non empatizzare. Bizzarri ha ammesso pubblicamente di non essere riuscito a scrivere lo spettacolo a causa dei troppi impegni lavorativi e della mancanza di idee; non solo la cosa non mi sorprende – visto che, tra i suoi impegni, c’è la produzione quasi giornaliera del podcast, che l’artista stesso ha sempre descritto faticosa – ma sono ben contenta che qualcuno di famoso abbia rotto il silenzio sul problema e, al contempo, ci abbia anche dispensati dall’ennesimo spettacolo senza urgenza creativa. In questo “diluvio incessante di contenuti”, non produrre perché non si ha nulla da dire rischia di diventare un atto rivoluzionario.
Qualche rimedio momentaneo
La sovrapproduzione culturale è storia vecchia: anche se con altre parole, ne sentiamo parlare da quasi un secolo. Per rintracciare il filo del discorso, possiamo risalire indietro nel tempo, andando a scomodare la nozione di industria culturale messa a fuoco dalla Scuola di Francoforte, la società dello spettacolo di Guy Debord, le riflessioni di Baudrillard e del pensiero Postmodernista. Così come possiamo legittimamente chiamare in campo il fenomeno dell’information overload, cioè il sovraccarico informativo enucleato da Bertram Gross nel 1964, o il concetto di infodemia, tornato alla ribalta durante gli anni del COVID-19. Insomma, sappiamo già da molto tempo che fine ha fatto la cultura nel capitalismo avanzato: è diventata una delle tante merci usa e getta a disposizione del nostro consumo, nonché un meccanismo di controllo sociale, funzionale al potere nel ridurre la capacità critica degli individui. Ma la consapevolezza intellettuale non ci salva; siamo tutti, ugualmente, vittima dell’ansia da consumo culturale, di cui già parlava Bauman in Vita liquida. Spinti all’incessante ricerca di novità, stressati da irraggiungibili aspettative sociali, soccombiamo al flusso incessante di contenuti, vedendo minate la nostra autonomia e riflessività.
Tuttavia, queste associazioni di idee possono aiutarci a individuare qualche rimedio momentaneo all’ansia e alla FOMO da sovrapproduzione culturale.
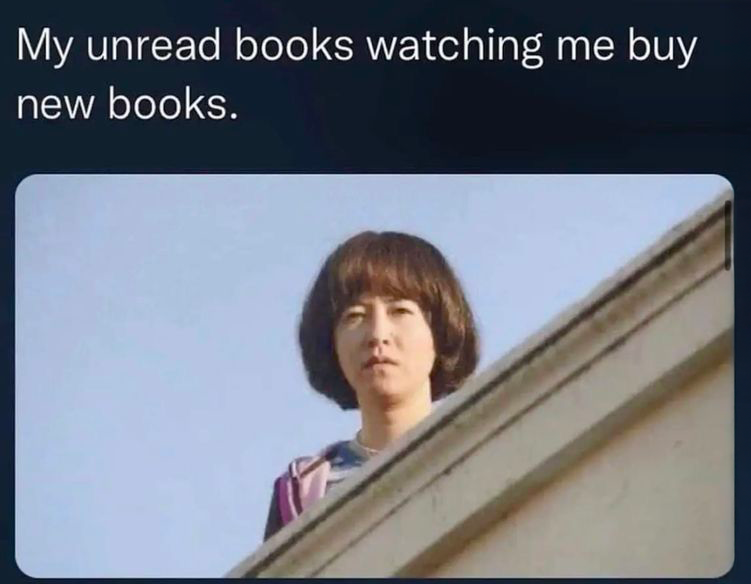
Trattando quest’ultima come un’altra forma di sovraccarico informativo, partirei dal fare pace con i nostri limiti: anche se percepiamo una forte pressione a stare al passo, non potremo mai soddisfare la richiesta. Non siamo noi a essere deficitari, è proprio impossibile riuscirci, umanamente e fisicamente. Dobbiamo tenerlo sempre a mente e raggiungere un’accettazione profonda, per poter uscire dalla paralisi e iniziare ad agire su ciò che è in concretamente nostro controllo. Se non sapete da dove iniziare, imitate Bizzarri e provate ad ammettere pubblicamente le vostre difficoltà. Quando vi chiedono se avete “letto l’ultimo libro di” o visto “l’ultima serie uscita su”, dite di no senza vergogna.
In secondo luogo, suggerisco di allenarci a riconoscere l’ansia e la FOMO nel momento in cui emergono, chiedendoci di volta in volta cosa le abbia scatenate. Così, potremo fermarci prima di aver raggiunto il livello massimo di stimolazione e non subirne tutti gli effetti negativi. Come con i social media, dobbiamo imparare a filtrare le fonti e scegliere consapevolmente quando e come aggiornarci.In terzo e ultimo luogo, propongo di concentrarci su cosa ci piace, anche a costo di fruire un prodotto culturale già noto. Non dico di ignorare qualsiasi novità, anche perché significherebbe isolarsi dal mondo; dico che, per contrastare gli effetti dei social sul nostro cervello, sia più efficace andare in profondità. Nell’era della conoscenza orizzontale e multi-flusso, andare in controtendenza vuol dire praticare la verticalità, preferendo la qualità della fruizione alla quantità dei contenuti. Quindi, in nome del nostro amore per la lettura, dedichiamoci ad accumulare ricordi positivi di lettura e torniamo ad allenare il nostro cervello all’attesa, alla concentrazione e al pensiero critico.
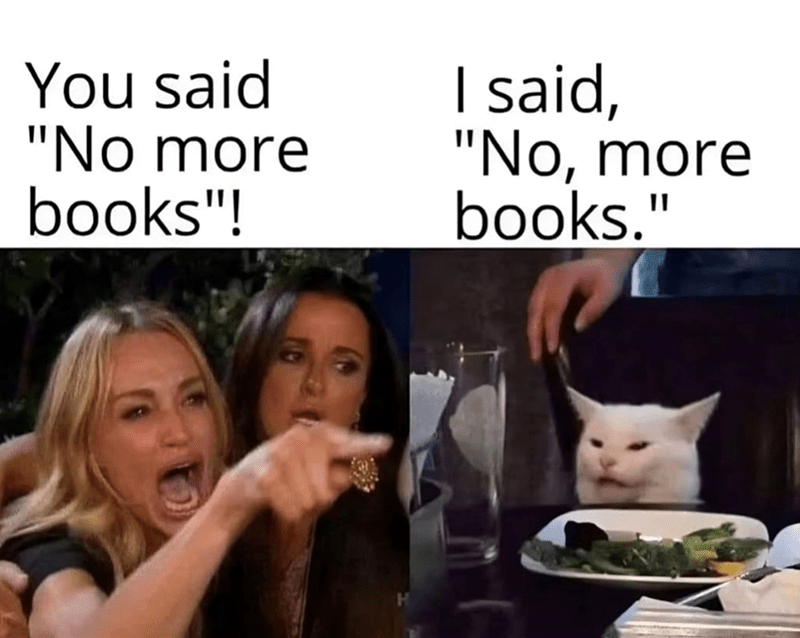
Nel Wasteocene della Cultura
In tutto questo, che ne sarà della cultura, intesa non solo come industria, ma come sapere umano? Abbiamo parlato di come arginare il problema individuale, ma affrontare il fenomeno collettivo – sempre che sia possibile attuare una trasformazione sistemica, vista atomizzazione sociale che ci affligge – è ben altra faccenda. In meno di un secolo, grazie al progresso tecnologico, abbiamo visto la cultura trasformarsi notevolmente: da integra, solida e omogenea a frammentata, liquida ed eterogenea.
Come in tutti i campi dell’attività umana, la sovrapproduzione culturale genera rifiuti.
Benché stiano emergendo nuove teorie, come il Metamodernismo, molte delle istanze del Postmodernismo sono ancora valide: iperproduttività, standardizzazione, citazionismo nostalgico, decostruzione, iperrealtà – i simboli non rimandano più a significati reali, quindi diventiamo sempre meno capaci di distinguere il falso dal vero – cui si aggiungono nuove tendenze dettate dai social media, come la personalizzazione estrema e la cultura della performance. Soprattutto, è più che mai presente il fenomeno delle scorie: come in tutti i campi dell’attività umana, la sovrapproduzione culturale genera rifiuti.
Stiamo quindi vivendo il Wasteocene della Cultura. Ciò mi induce ad azzardare un’ipotesi: forse sarebbe l’ora di ingaggiare una lotta sociale alla sovrapproduzione di prodotti culturali. Non solo prendendo scelte di consumo individuali più oculate, ma ripensando l’azione collettiva e i processi sistemici, al fine di ottenere una transizione ecologica anche in questo ambito. Sinceramente non saprei da dove cominciare, anzi, probabilmente questa scelta decreterebbe la fine della mia attività come autrice, ma credo che sarei pronta ad accettarlo. Anzi, mi sento già ispirata da questa idea di militanza; potrete trovarla ideologica, irrealizzabile, un po’ reazionaria – e probabilmente avete ragione – ma sembra avere il pregio di spingere all’azione. Staremo a vedere… nel frattempo, un augurio per tutti: che si possa riconquistare al più presto una postura attiva e consapevole nell’atto di consumare prodotti culturali. Così, magari, non soccomberemo.