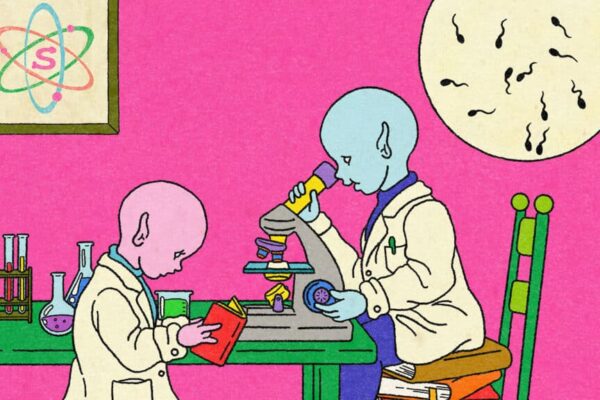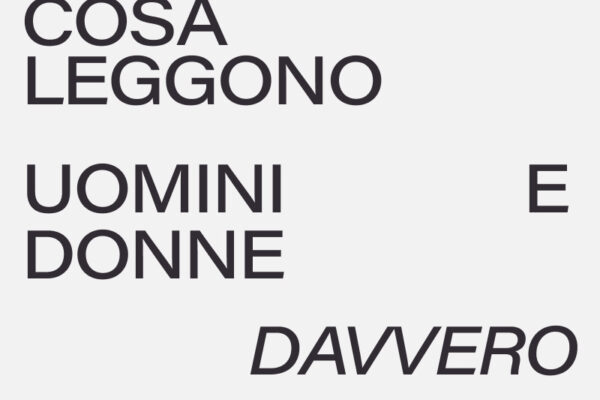«Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare». Sono le parole che la tata del primogenito dei Ferragnez rivolge al bambino in una story pubblicata dalla mamma. La storia Instagram è stata poi cancellata e ricaricata senza audio da Chiara Ferragni. Questa è solo l’ultima delle polemiche che riguardano i coniugi più famosi d’Italia, accusati spesso di sovraesporre i loro figli sui social. In questa occasione in molti hanno avanzato l’ipotesi che la frase pronunciata dalla tata inviti il bambino a interrompere la sua attività ludica per dover posare davanti alla fotocamera del telefono. Questo, sostengono alcuni commentatori su Twitter, dimostra lo spasmodico bisogno di documentare la vita dei figli a costo di interrompere le loro attività quotidiane. Dei due è Fedez ad aver spesso risposto a questo genere di critiche spiegando che, sostanzialmente, questa decisione parte da una consapevolezza ben precisa: i figli sarebbero comunque sovraesposti. Data la loro notorietà, sostiene Fedez, se non fossero loro stessi a condividere la vita genitoriale ci sarebbero paparazzi ovunque pronti a immortalare ogni istante di vita quotidiana. Data l’inevitabilità , dunque, preferiscono essere loro gli artefici per poterne avere quantomeno il controllo in prima persona.
Il dibattito che con cadenza regolare investe i coniugi Ferragnez e che crea spirali di indignazione sui social ha un nome, si chiama sharenting. è un neologismo coniato negli Stati Uniti che deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). Con questa parola si fa riferimento al fenomeno della condivisione delle foto di minorenni sui social.
Tutta quanta la vita dei figli di Chiara Ferragni è stata documentata sui social, dalla nascita fino alle loro prime parole, ma si tratta di un caso eclatante e circoscritto. È vero, questi bambini sono sovraesposti e spesso utilizzati come strumento di marketing, eppure non è una novità. A destare scalpore è l’utilizzo di un medium che rende fruibile ad un vastissimo numero di persone un contenuto intimo come il volto di un bambino, ma l’indignazione dovuta alle opportunità della tecnologia non deve essere scambiata con il contenuto. Non c’è niente di nuovo nella capitalizzazione dei neonati, basti pensare ad esempio alle opportunità lavorative nell’utilizzo delle immagini per film o shooting che vengono offerte già in ospedale ai neo genitori. Se era loro intenzione rendere famoso un figlio, i genitori hanno sempre avuto l’opportunità di farlo, anche ben prima dei social.
Ho deciso di iniziare a raccontare questo fenomeno con il caso più eclatante e famoso, quello che catalizza spesso l’attenzione mediatica su un problema che è in realtà molto più comune e trasversale. Spiegare che cosa sia lo sharenting ha inevitabilmente un’eco nell’immaginario collettivo che riguarda quelli che sono i simboli emblematici di tale comportamento. Vorrei però provare a parlare di questo tema andando oltre quella che è la scelta privata, per quanto nota, di una sola famiglia in Italia. L’intento è infatti quello di domandarsi quale immagine si è costruita oggi dell’infanzia grazie alla promulgazione delle foto dei bambini sui social network. In che misura la rappresentazione codificata e divulgata dai genitori può incidere nell’auto rappresentazione del sé? E come, quindi, si relazionerà un mondo di futuri adolescenti e adulti con l’immagine virtuale di se stessi?
Per questo motivo, a mio parere, è importante partire da alcuni chiarimenti di fondo: parlare di sharenting non significa esprimere giudizi di valore su cosa sia essere un buon genitore né tantomeno confondere questo fenomeno con la capitalizzazione dei bambini. Significa, piuttosto, aprire uno spazio di discussione sull’incosapevolezza dell’utilizzo dell’immagine e la funzione della genitorialità nello spazio digitale. A mio parere, infatti, è molto più interessante indagare l’evoluzione della responsabilità genitoriale su spazi prima impensabili. Non solo perché prova ad aprire uno spiraglio molto meno setacciato sul comportamento mediatico dei genitori, ma anche e soprattutto perché permette di allargare il bacino d’utenza su un problema che è molto più diffuso. Mentre i genitori desiderosi che i loro figli diventino famosi con o senza Internet ci sono sempre stati, genitori che costruiscono un’identità digitale al figlio sono invece una novità.
Non c’è niente di nuovo nella capitalizzazione dei neonati, basti pensare ad esempio alle opportunità lavorative nell’utilizzo delle immagini per film o shooting che vengono offerte già in ospedale ai neo genitori. Se era loro intenzione rendere famoso un figlio, i genitori hanno sempre avuto l’opportunità di farlo, anche ben prima dei social.
Sharenting significa prima di tutto creare un’identità virtuale senza il consenso dei figli. Questa pratica inizia ben prima della nascita e si sviluppa in diversi momenti della gestazione. È interessante allora fare un po’ di storia della fotografia neonatale. Bisogna notare come, ad esempio, le prime ecografie abbiano permesso negli anni ‘70 di dare un volto a quello che accadeva dentro il grembo materno. Secondo Sara Dubow, autrice del libro Ourselves Unborn, nell’immaginario collettivo la rappresentazione fotografica del feto ha dato modo alle tesi dei pro life di sostenere che quella fosse una creatura e si trattasse di vera vita. Come sappiamo si sono costruiti dei veri e propri schieramenti che hanno contrapposto i diritti della donna versus i diritti del feto. Questo non è lo spazio giusto per addentrarci nelle rispettive ragioni ma lo cito a titolo esemplificativo proprio per tracciare un minimo di preistoria della rappresentazione neonatale. Oggi spesso le foto dei bambini vengono diffuse sui social network o nelle app di messaggistica prima ancora del parto, quando sono appunto ancora un feto in evoluzione. Spesso sono inviati a parenti ed amici stretti, ma non è raro trovare annunci di una dolce attesa anche sui social attraverso proprio la foto dell’ecografia. Ma c’è un altro importante momento che rappresenta in maniera ancora più significativa lo sharenting ed è il gender reveal party. Si tratta di una festa organizzata dai genitori per rivelare ad amici e parenti il sesso del nascituro. Anche in questo caso ci sono degli esempi di spettacolarizzazione come nel caso del gender reveal party di Chiara Nasti che ha affittato un intero stadio per scoprire se si trattasse di un maschio o di una femmina. Il video ufficiale ha scatenato molte critiche, soprattutto perché in molti lo hanno considerato un gesto tamarro ed esagerato. Ma anche in questo caso è interessante notare che il fenomeno del gender reveal party sia in realtà una nuova forma di rito collettivo che si sta instaurando sempre di più nel processo educativo di un figlio. Al pari di un battesimo, è possibile considerare il gender reveal party come un rito pagano che interessa moltissimi futuri genitori. Di solito funziona così: la coppia chiede espressamente al tecnico che fa l’ecografia di non rivelare il sesso del nascituro ma di scriverlo dentro una busta da sigillare che verrà consignata a un parente o ad un amico incaricato di svolgere il gender reveal party. Per scoprire se si tratti di maschio o femmina spesso viene bucato un palloncino che contiene dei coriandoli colorati, tagliata una torta il cui interno è colorato di rosa o blu oppure usati dei fumogeni. Di fatto viene creata una forte aspettativa tra i partecipanti e spessissimo il filmato che immortala il momento della scoperta viene caricato sui social. Si tratta, quindi, anch’esso di sharenting. La pioniera di questo nuova celebrazione si chiama Jenna Karvunidis. Dal lontano 2008 la sua idea di tagliare una torta ha avuto un successo incredibile ma, recentemente, ha affermato al Guardian di essere molto dispiaciuta di aver dato avvio a questo fenomeno proprio perché ‘il genere non è poi la cosa più importante da cui iniziare’. Se fino ad oggi la divisione binaria dei ruoli di genere più autoevidente e ingiustificata come l’attribuzione di colori differenziati all’uno e all’altro sesso sembrava oramai superata, qui invece, ritorna con preponderanza ad acquisire un significato gnoseologico. La connessione rosa-femmina e azzurro-maschio è tramite questi gender reveal party talmente tanto rafforzata da essere stata naturalizzata come linguaggio condiviso. Ci sono anche qui alcuni tratti da sottolineare. In prima battuta quello che stupisce, almeno nel mio caso, è quale sia l’oggetto della contentezza. Credo che, maschio o femmina che sia, ci sia solo da essere contenti di attendere l’arrivo di un essere umano. Invece, l’esito euforico della scoperta sembra indicare un inebriamento simile alla gioia di una vittoria come se la scoperta di portare in grembo una bambina e non un bambino faccia la differenza. Insomma, se l’esito fosse stato l’opposto i genitori sarebbero stati felici allo stesso modo? Probabilmente sì, e quindi il gender reveal party suggerisce una certa finzione di fondo. Ma quello che è più interessante di questo nuovo rito contemporaneo è la testimonianza che ne rimarrà negli anni successivi sui social: il bambino o la bambina vedrà sul profilo dei genitori ogni singolo momento della sua crescita compresa la scoperta del sesso. Nessuno, per ovvi motivi, gli ha mai chiesto il consenso e potrebbe non gradire il modo stereotipato con cui il festeggiamento si è tenuto. Inoltre, il bambino o la bambina potrebbe un giorno riconoscersi come persona non binaria, o decidere di cambiare sesso e vedere una simile costruzione della sua identità di genere potrebbe essere motivo di dolore e di disagio. Sarebbe molto interessante riuscire a capire il portato gnoseologico delle immagini che sono ad oggi lo strumento principe del linguaggio mediale ma la maggioranza di noi ne è analfabeta. È quello che di fatto pone lo studio Figli in vetrina condotto da Davide Cino e Silvia Demozzi. In uno dei passaggi cruciali del paper viene detto: ‘(i bambini) si trovano ad avere un’identità virtuale sin dai primi attimi di vita, all’insegna della più totale inconsapevolezza (…) E come lavorare, dal punto di vista pedagogico, con una generazione sempre più devota al culto del sé e al narcisismo , se la società adulta, in primis, educa all’importanza di un’esposizione virtuale e alla ricerca di continue conferme di quel Sé mediatico che, già dalla più tenera età, può arrivare ad assumere un’importanza sempre più prorompente’. L’obiettivo della ricerca non è condannare l’utilizzo dei social network e della tecnologia. Questo sarebbe un atteggiamento quasi primitivista di chi non vuole confrontarsi con le difficoltà della contemporaneità rigettando il problema ad un generico ‘era meglio prima’ o evitando di partecipare allo sviluppo della socialità online che è ad oggi parte integrante della socialità di una persona umana, recidendo così la possibilità di viverne una piena.
Per questo motivo i due autori hanno svolto un sondaggio che interessa esclusivamente madri. È interessante notare che secondo altri studi da loro condotti o citati a partecipare c’è sempre una maggioranza femminile e non maschile. Sono le donne quindi ad utilizzare il web come estensione della cura genitoriale, sia per quanto riguarda il cercare supporto online su questioni inerenti alla cura sia per quanto riguarda l’educazione dei figli. A titolo di esempio, basti ricordare che i nomi dei principali blog online che creano community di supporto contengono tutti la parola ‘mamma’ e mai ‘genitore’. I siti più famosi sono: Pianeta Mamma, il forum Al Femminile, il blog e gli account social Mammadimerda. In questi siti i genitori sono co-costruttori della genitorialità e sarebbe interessante indagare con un’attenzione maggiore qual è l’idea di cura e amore che egemonizza questi scambi. Quale sia, di fondo, l’ideologia pedagogica che promuovono. In particolare il motto del sito Mammadimerda (MM) è sii pinguina. Le mamme pinguine infatti depositano le uova e lasciano che siano i papà a covare finché non si schiudono. Con questo motto si vuole creare un idealtipo pedagogico materno alternativo a quello secondo cui il “buon genitore” deve dimostrarsi costantemente dedito alla cura dei figli per garantirne il benessere psicosociale. Con un linguaggio dissacrante e provocatorio MM vuole creare un ambiente per mamme disperate che si sentono in colpa per il sollievo che provano quando stanno lontano dai figli. Con questa controcultura si creano intensi scambi, testimonianze, consigli, contatti utili per sopperire a quella solitudine che ha condotto molte, secondo il sondaggio, a cercare in questa comunity una risposta.
Parlare di sharenting non significa esprimere giudizi di valore su cosa sia essere un buon genitore né tantomeno confondere questo fenomeno con la capitalizzazione dei bambini. Significa, piuttosto, aprire uno spazio di discussione sull’incosapevolezza dell’utilizzo dell’immagine e la funzione della genitorialità nello spazio digitale.
Secondo il sondaggio riportato nel paper Figli in Vetrina chi fa uso dei gruppi FB solo il 30% pubblica anche le foto dei loro figli sugli stessi social. Questo dato cambia quando si tratta di condividere le foto dei figli sulla propria pagina personale: il 68% delle intervistate dice di aver condiviso le foto dei figli sul proprio profilo con la privacy ‘Amici’. Tra coloro che hanno affermato di aver condiviso la foto sui social ben l’88% non ha mai consultato il figlio o la figlia prima di farlo. Al contempo quelle stesse mamme dicono che sia un loro diritto farlo, ma che forse si tratta di una esposizione precoce. Questo atteggiamento fortemente ambivalente è il nodo centrale che permette, forse, di dare qualche interpretazione dello sharenting. Infatti, questo fenomeno, interseca due aspetti che prima non si erano mai incontrati: il tema della responsabilità genitoriale (con anche il peso cultura dell’essere un buon genitore come prima abbiamo visto) e la dopamina rilasciata dal gradimento che si riceve sui social, soprattutto quando è in relazione all’immagine. C’è quindi il tema del desiderio anche nel fenomeno dello sharenting. Per spiegare in che modo il desiderio interessi la pratica di pubblicare le foto dei figli viene introdotto da i due autori il concetto di desensibilizzazione. Durante questo sondaggio è stata mostrata alle partecipanti una foto pubblicata su una testa online. La foto ritrae una bambina di 22 mesi truccata con i capelli acconciati e in posa insieme alla madre. Il 63% del campione complessivo reputa che la foto sia ‘carina’ contro un 37% che la trova inappropriata. Al contempo il 31% delle mamme pensa che questo tipo di esposizione possa urtare la sensibilità della bambina fotografata mentre il restante 69%, quindi la maggioranza, che non la considera problematica. Nel corso del sondaggio è stata fatta però anche un’altra domanda: è stato chiesto di rispondere se concordano con la frase i bambini devono poter essere/comportarsi e vestirsi da bambini. Quasi la totalità delle mamme hanno risposto in maniera affermativa. Ma di queste solo il 31% pensa che la foto della bambina truccata precedentemente sia impropria, il restante della mamme la trova invece bella, adatta e piacevole. Ecco quindi una contraddizione di fondo: quando si tratta di concordare con delle frasi generiche di tipo pedagogico si riscontra che tutte le mamme concordino ma quando si tratta di veder applicato quel principio in maniera indiretta attraverso l’utilizzo di una foto che rappresenta una negazione della frase su cui si sono dette d’accordo, la maggioranza si contraddice. Come mai? Nel paper viene introdotto il concetto di desensibilizzazione per dare una spiegazione a questo atteggiamento. Questa è la definizione di desensibilizzazione: si tratta di un processo per cui alla sovraesposizione a uno stimolo culturalmente controverso (perché violento o di natura sessuale) può far seguito nei fruitori un innalzamento della soglia di tolleranza allo stesso. Questo significa, in sostanza, che c’è un’assuefazione inconscia e che il desiderio ed il piacere sono modellati da stimoli culturali e sociali che si diffondono tramite l’utilizzo della piattaforma. Insomma, come prima provavamo ad anticipare, l’immagine ha un potere comunicativo molto forte, soprattutto come modello di rispecchiamento e mimesis a cui però noi non riconosciamo tale ruolo. C’è un’introiezione significativa di un modello di riferimento che condiziona il nostro desiderio. Un elemento quindi che forse lega il fenomeno dello sharenting nelle sue varie declinazioni (dal gender reval party alle foto dei bambini su instagram) è il bisogno di condividere quel momento se non addirittura il desiderio di organizzare riti e momenti, come per esempio uno shooting, con l’esclusiva finalità di poter postare quella foto. Fenomeni come la fotografia newborn, la cui più famosa esponente è Anne Gueddes, sono pienamente accettati e apprezzati nonostante venga costruito un contesto artificioso per un bambino di appena pochi mesi.
Il tema della contraddizione emerge anche in un altro momento del sondaggio, quando si parla esplicitamente di sesso e desiderio. Il 77% del campione (167/216) è d’accordo nel ritenere che «foto di bambine/i online con pose, vestiti o atteggiamenti da adulti possano funzionare da richiami sessuali». È interessante notare, tuttavia, che il 74% di queste (123) concorda nell’affermare che «la malizia sta negli occhi di chi guarda». Anche qui il comportamento è nuovamente contraddittorio: sono i bambini a provocare o la colpa risiede unicamente nel possibile aggressore?
La conclusione della ricerca Figli in vetrina conclude che i bambini vengono visti come proprietà e che c’è un insindacabile giudizio del genitore sul quale non è possibile soprassedere. C’è quindi da chiedersi che idea di bambino abiti l’infanzia attuale e distingua il fenomeno dello sharenting e quanto questo influenza non solo lo sviluppo della sua crescita ma anche nel rapporto con i social. Come dice una madre intervistata in una puntata di Reality il profilo della figlia minorenne è stato bloccato più volte nell’arco dell’ultimo anno e la stessa mamma ammette che ‘è vero, i bambini sotto i 13 anni non possono avere un profilo su Instagram, ma anche se le foto sono di Gaia, il profilo è mio, scelgo io cosa mettere’. Intrinsecamente legato al fenomeno dello sharenting anche quindi l’impossibilità di trovare una sinstesi legislativa che tuteli il minore.
L’art. 96 della L.633/1941 dice che ‘nessun ritratto di una persona può essere esposto senza il consenso di quest’ultima’ mentre l’art. 10 del Codice Civile garantisce al soggetto, fotografato senza il suo consenso, ‘la facoltà di richiedere la rimozione dell’immagine e un eventuale risarcimento’. E ancora: l’articolo 31 della Costituzione difendere l’infanzia e la gioventù, così come la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (ratificata in Italia dalla L.176/1991). Insomma, tutte queste leggi di rilevanza anche internazionale dovrebbero tutelare il minore ma finché sono minorenni le decisioni spettano ai tutori legali che spesso coincidono con i genitori. Di fatto, i genitori hanno quasi il completo arbitrio nella diffusione delle foto dei figli. Non è quindi facile discutere di consenso dell’immagine di un minore.
Infine, anche Save the Children si è occupata del tema. In questa puntata podcast Brunella Greco, esperta di Save The Children in tema di tutela dei minori, spiega le conseguenze dell’over-sahrenting.
Se comunque lo sharenting può funzionare là dove è gestito come una dieta bilanciata e fatto con consapevolezza e rispetto, l’oversharenting porta con sé dei risvolti educativi e psicologici notevoli. Si parla infatti di: violazione della privacy, mancata tutela dell’immagine del bambino (una volta caricate le foto sui social se ne perde il controllo), rischio di diffusione di contenuti pedo-pornografici. Ma quello più significativo sono le ripercussioni psicologiche dei più piccoli perché interessano ancora una volta il tema del desiderio e dell’introiezione di precisi modelli culturali e comportamentali attraverso l’immagine. Un bambino a cui viene richiesto continuamente di posare o sorridere a una fotocamera può alla lunga desiderare lui stesso di essere fotografato e che quelle foto vengano condivise online. Ci può essere quindi un addomesticamento del desiderio e della performatività virtuale già in tenera età. Un bambino che, invece, all’età consentita per aprire un proprio profilo social si dovesse scontrare con la costruzione di una sua precedente vita digitale potrebbe non apprezzare l’utilizzo della sua immagine e provare imbarazzo. Ma potrebbe anche incorrere nel cyberbullismo: una foto ritenuta dolce da una sorella che posta la foto di suo fratello a 6 anni che mangia il gelato con golosità in costume da bagno sulla spiaggia può essere utilizzata come strumento per fare body-shaming. I ragazzi infatti non guarderanno quella foto con affetto ma avendo già introiettato i canoni estetici egemoni.
Insomma, anche il fenomeno dello sharenting comprende tutte le logiche virtuali che già conosciamo. C’entra il tema della performatività del ruolo genitoriale come c’entra la performatività del figlio/a. C’entra l’orgoglio dei genitori nel vedere i like alle foto del figlio, così come il possibile desiderio dei bambini a vedersi rappresentati e apprezzati. Si promuovono modelli culturali di riferimento, estetici e comportamentali e nella maggior parte dei casi, per non dire sempre, viene fatto senza consenso degli interessati.