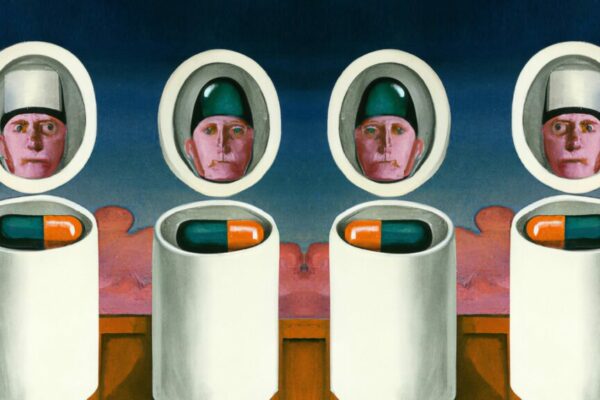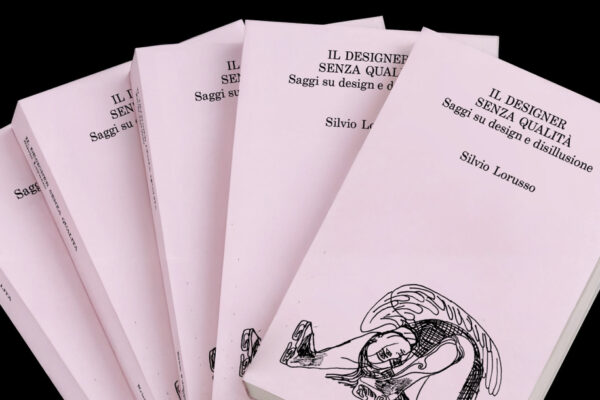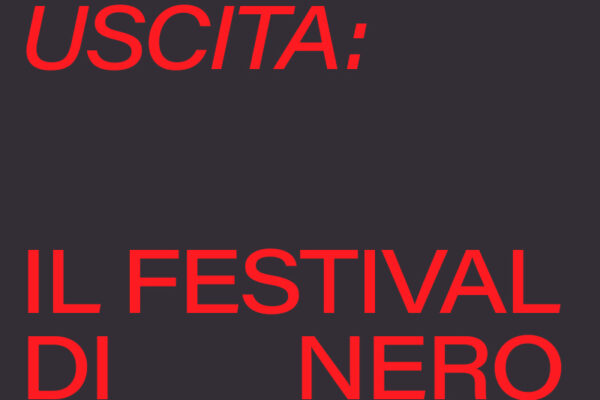È una bellissima sera di luglio e sono seduta con i miei genitori e mia sorella minore in un ristorantino di Sestri Levante, Liguria. E’ una di quelle cene che mi piacciono un sacco da quando sono diventata adulta, da quando vedo i miei genitori come due persone e meno come la mia mamma e il mio papà. So che stapperemo una bottiglia di rosso, mangeremo trofie al pesto, e parleremo tanto di tutte le cose su cui abbiamo voglia e bisogno di confrontarci. Tra l’arrivo del cestino del pane e il giro di antipasti, mia sorella Chiara accenna che forse vorrebbe iniziare ad andare in terapia. “Ma come?! L’unica che speravo fosse normale!” ironizza mio papà ridendo dolcemente.
Problema, malessere, debolezza?
Io, infatti, vado in terapia da quando ho iniziato ad accorgermi che la vita è un casino, quindi potete immaginare. In realtà i miei genitori sono stati i primi a portarmici, quando ero una ragazzina con un’ossessione strana per la pulizia, e sono stati di nuovo loro a spronarmi a cercare aiuto quando ho iniziato ad avere attacchi di panico a 23 anni. Mi hanno sempre supportata nel percorso, emotivamente ed economicamente, apprezzando i frutti del lavoro fatto in anni e anni: psicologo, psichiatra, psicofarmaci. Tutto senza alcun tabù, e ben consci di quanto la terapia mi abbia poi cambiato la vita.
Com’è possibile, allora, che nonostante tutto questo, i miei genitori, boomer illuminati, vedano ancora un problema dietro la terapia? Che facciano ancora resistenza? Un po’ mi cadono le braccia, e un po’ voglio capire cos’è che ci distanzia. E così, mentre arrivano le trofie al pesto, facciamo una veloce ma feroce analisi terapeutica, boomer vs millennial.
Boomer men will not go to therapy but will have 9 jack and cokes then spill their guts out in the comments of a YouTube video of a song they first heard at the age of 17
— Connoisseur of Fine Internets (@innanet_man) January 25, 2025
Il fulcro del discorso sembra essere racchiuso nella parola problema. Per loro (i boomer) andare in terapia è un problema, perché manifesta l’esistenza di un problema: parola di per sé negativa, che rimanda a qualcosa da risolvere, da mettere a posto. Qualcosa di sbagliato, di non nella norma. Tutto il contrario di noi (millennial e genZ), che nella terapia abbiamo iniziato a vedere un arricchimento, una positività, una crescita. E per questo ne parliamo senza vergogna e senza filtri. Per lo meno tra di noi. Per loro parlare di terapia significa ammettere un problema; per noi dimostra che ci si vuole capire qualcosa, di sé stessi e della vita.
I miei genitori sferrano allora la seconda arma: mi sfidano a nominare anche solo uno dei miei amici che abbia davvero iniziato ad andare in terapia per “arricchimento, positività, crescita” e non per l’esistenza di un malessere. Citano le mie stesse parole, sanno argomentare, mannaggia. Ci penso e ripenso e no, effettivamente non mi viene in mente nessuno. Elisa, Claudia, Marco, Giulia, Michele… tutti ne sentivano il bisogno.
Non è il malessere di chi va in terapia, è il malessere umano.
Quindi un malessere c’è. Concedo ai miei questo punto di ri-partenza, su cui siamo d’accordo. Però mi viene da pensare: ma chi è che non lo prova questo malessere? Chi è che a un certo punto non si scontra con il fatto che la vita è un casino? Spoiler, mamma e papà: nessuno. Tutti arriviamo a un momento in cui l’attrito con il mondo è tale da voler capirci qualcosa. Quella sofferenza a cui stiamo pensando, è tutta umana, e inevitabile. Non è il malessere di chi va in terapia, è il malessere umano. Mio padre ride e dice che si vede che ho studiato filosofia. Poi però mi versa altro vino rosso nel bicchiere, e mi dà perfettamente ragione. D’altronde ha trent’anni di malessere umano in più di me sulle spalle.
Dopodiché, i miei genitori si guardano, e quasi in coro dicono che però, ai loro tempi, evidentemente, riuscivano a gestirselo bene da soli questo malessere umano. Riuscivano ad accettarlo come parte della vita e a non farlo diventare un problema. Ma è davvero così? I boomer non avevano bisogno della terapia? Gli dico che secondo me è una stronzata. E che forse, semplicemente, non era uno strumento che avevano a disposizione. Forse la terapia sta ai giovani di oggi come la fede, la filosofia, il culto del posto fisso e la famiglia patriarcale stanno ai giovani di un tempo. Ti danno una lente con cui interpretare il mondo e cercare di muoverti al suo interno come meglio puoi, nel non troppo tempo che hai a disposizione. Aiutano a capirci qualcosa e a restare in piedi. E la terapia, noi lo possiamo dire, lo fa meglio di tutto il resto. È lo strumento più efficiente, è il regalo che l’evoluzione della società e del pensiero ci ha donato. Avete sempre avuto bisogno della terapia e non l’avete mai saputo, cari mamma e papà.

Con un sorriso nostalgico mi dicono che la psicoterapia l’hanno vista in effetti per le prime volte nei film di Woody Allen, e che gli faceva molto strano perché non erano abituati a vedere l’attenzione rivolta così tanto verso se stessi. E qui, ci si accende contemporaneamente una lampadina. Forse questa difficoltà di inquadrare la terapia ha a che fare con la grande differenza nel modo di vivere delle due generazioni: ha a che fare con quell’abisso tra la dimensione sociale del mondo boomer e la dimensione individuale del mondo presente. I nostri genitori erano proiettati molto più all’esterno che all’interno: la dimensione collettiva, di cui si piange tanto l’assenza ora, era per loro la dimensione prescelta.
Ci si interrogava su che forma dare al mondo, mi dice la mia mamma, non su come trovare nel mondo un proprio posto.
E non penso soltanto ai collettivi politici e ai sindacati frequentati da chi ha vissuto quei decenni con fermento, ma anche semplicemente alla vita di quartiere, al potere aggregativo degli oratori, all’assenza di cellulari e social media: il tessuto sociale era il principale luogo del vivere umano. E i pensieri plasmano e sono plasmati dal mondo in cui si vive, per cui il tessuto sociale era forse anche il principale oggetto del pensiero umano: ci si interrogava su che forma dare al mondo, mi dice la mia mamma, non su come trovare nel mondo un proprio posto. Se c’era un malessere, la soluzione veniva vista più all’esterno, come azione collettiva, e non come riflessione individuale. Forse è per questo che la terapia non poteva essere il loro strumento, e forse è per questo che adesso, riconoscendone la validità, non riescono ad afferrarne fino in fondo l’essenza.
@hannah.grabau Replying to @honeybunchesofkat #yourboomerdad #therapy #dad #boomer #millennial #boomerparents #mentalhealth ♬ original sound – hannah.grabau
Egoismo o consapevolezza?
E oggi? La dimensione individuale è quella che regna sovrana. L’attenzione di ognuno di noi è come prima cosa rivolta verso sé stessi, alla ricerca del miglior modo per vivere la propria vita, a volte purtroppo anche con totale noncuranza verso l’esterno. Ci è stato rimproverato di essere egoisti ed egocentrici, e in questa prospettiva è sicuramente molto vero, e ci è stato anche fatto notare di essere sempre più distanti dalla dimensione della collettività, il che è un disastro in un mondo che va progressivamente a rotoli.
Conosco narcisisti che, sdraiati sul lettino, non hanno fatto altro che rafforzare il loro narcisismo.
Però, se devo spezzare una lancia a nostro favore e vedere il lato buono di questo Ego che è cresciuto a dismisura, è che forse ci ha regalato anche una maggiore capacità di introspezione. Le due cose non sono collegate, sia chiaro, si può essere individualisti senza alcuna volontà di introspezione. Ma la mia ipotesi è che la nostra dimensione individuale sia stata terreno fertile per una maggiore affermazione della terapia: a forza di pensare a Me Me Me e al mio profitto, forse io Millennial x ho intravisto l’opportunità di esplorare Me Me Me e la mia individualità. E se sono un Millennial x con un certo tipo di volontà, quell’opportunità l’ho colta e ho cercato di farne qualcosa di buono, per me stesso e, per riflesso, anche per la collettività.
Che poi non sia così per tutti, è chiaro. Non per forza andare in terapia ci rende migliori, o più empatici. Conosco narcisisti che, sdraiati sul lettino, non hanno fatto altro che rafforzare il loro narcisismo. Ma è raro trovare qualcosa che valga per tutti, quindi cerco di pensare a livello generazionale: se la terapia si infila dentro un numero sempre maggiore di vite, ha più probabilità numeriche di fare un buon lavoro, no? Capire meglio sé stessi può aiutare a capire meglio gli altri, e a stare nel mondo in un modo sentito e collaborativo, per costruire una collettività più solida e funzionale. Non lo so eh, ma è un augurio che mi e ci faccio.

E mi sembra anche un buon punto di rivalsa per la nostra generazione bistrattata, e spesso additata come molle, fragile, e sola. Il nostro individualismo, a voler essere acidelli, dimostra il fallimento di quel discorso collettivo che i nostri genitori hanno cercato di costruire. Ed è inoltre la naturale conseguenza di quell’educazione al successo che ci è stata data (da loro). Ma dopotutto ogni generazione fa il meglio che può con i propri figli, quindi noi ce lo teniamo l’individualismo, va bene. Forse con l’aiuto della terapia cerchiamo però di capirlo e di renderlo un più dolce compagno di vita, un alleato. Per lo meno finché toccherà a noi trasmettere nuovi problemi alle generazioni future: e chissà quale sarà il loro strumento di rivalsa.
Siamo stanchi, i nostri piatti sono stati ripuliti dalle trofie al pesto e forse un punto di arrivo non lo troveremo mai. Decidiamo di cambiare argomento e di commentarele gare olimpiche della giornata. Che il casino della vita sarà ancora lì domani, per tutte le generazioni, per sempre. E spero anche la terapia, perché cavolo se abbiamo ragione noi ad usarla.