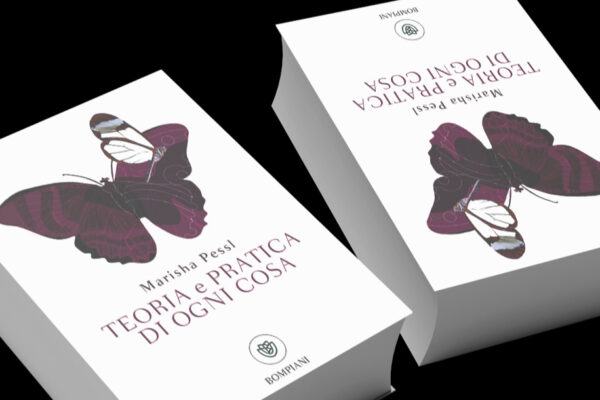JD Vance ha compiuto quarant’anni il 2 agosto del 2024, è da poco il vicepresidente degli Stati Uniti d’America e la sua faccia da paffuto panda wasp ospita, come degli estranei, due occhi molto chiari che emanano un bagliore di ferocia. La sua giovane età, il suo ruolo politico e il contrasto raccontato dal suo viso mi hanno spinto a leggere il suo Hillbilly Elegy, tradotto in italiano col titolo di Elegia Americana. Non è un saggio e nemmeno un romanzo: è un memoir, pubblicato quando di anni, JD, ne aveva trentadue e non era per nulla vicino a Donald Trump, che anzi considerava un populista nel senso peggiore del termine, un non-politico incapace di proporre soluzioni sensate e attuabili per i problemi degli Stati Uniti.
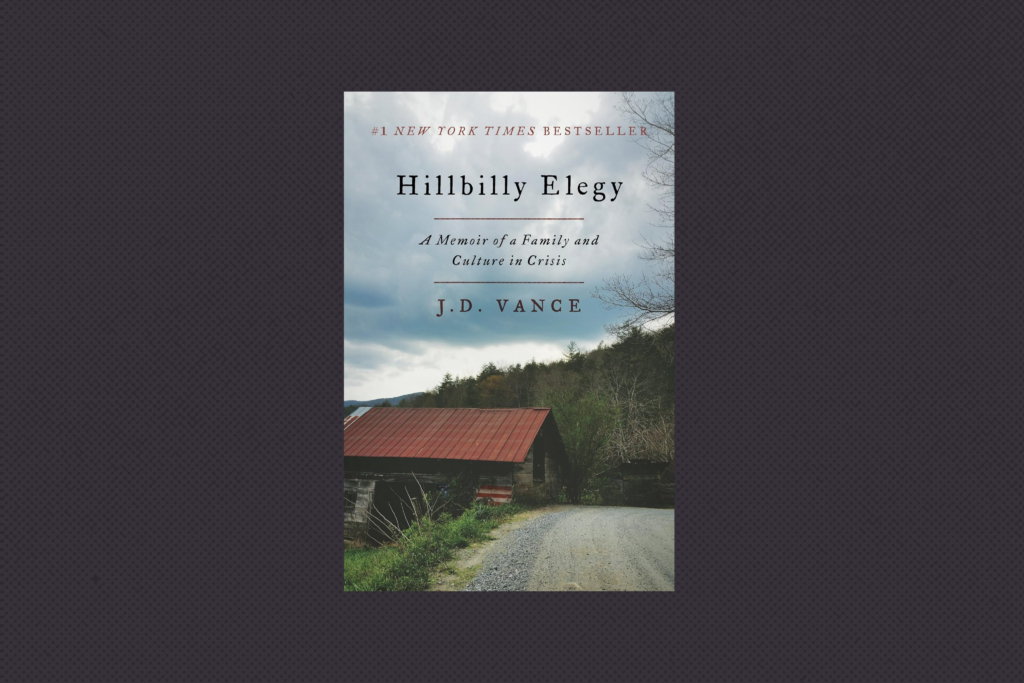
La ferocia affascinante di JD Vance
Quando ho preso il libro, prima di aprirlo ho osservato per un po’ il titolo in italiano. Elegia americana… Elegia – americaaana… Mi è venuto tutto uno stranguglio di epica e melanconia, spazi immensi, personaggi tragici e dai modi spicci abbandonati ai loro sogni di gloria senza neanche il conforto di un sistema sanitario pubblico. Sì, subisco il fascino di certi titoli, come subisco il fascino di certi volti. Bisogna dire, però, che il titolo originale, Hillbilly Elegy, è molto diverso dalla resa in italiano. La definizione dell’Oxford Language del termine hillbilly è questa: “an unsophisticated country person, as associated originally with the remote regions of the Appalachians”. Tolto il riferimento specifico agli Appalachi, in italiano il titolo si potrebbe quindi tradurre come Elegia Cafona, Elegia Zoticona, Elegia Buzzurra, per avvicinarsi un po’ al senso in inglese: tutt’altra cosa, converrete con me. Solo che da noi sarebbe stato un ottimo titolo per un disco di Califano, ma, editorialmente, un suicidio. Quindi non sono arrabbiata con chi (traduttore? Editore? Entrambi?) ha deciso di romanticizzare il titolo in italiano. Va bene così: si perde il contrasto tra parola alta (elegia) e bassa (buzzurra), ma si guadagnano lettori e questo è sempre un bene e penso che traduttore e editore saranno confortati dalla mia assoluzione. Ma perché la faccia di JD mi affascina? Con quelle guanciotte tonde, quella barbetta ben rasata, è il ritratto dello statunitense agiato almeno per chi, come me, in USA non ha mai messo piede. Niente più e niente meno che un americano qualsiasi: ergo, sempre per me, ciò che di meno interessante l’umano possa esprimere. Se non fosse per quel lampo di ferocia nei suoi occhi che neanche le fotografie ufficiali riescono ad attenuare. Perché sì, ormai lo so: il fascino del male io lo subisco tutto. Non si tratta di un fascino erotico o sentimentale. E in fondo non si tratta nemmeno di male in senso stretto. Anche perché ciò che è male per me (Trump, i fasci de noantri eccetera) per altri è non bene ma benissimo, e non voglio ergermi a fustigatrice morale perché la storia è un guazzabuglio di storie e di raccontatori ed è vero che cambiare il punto di vista significa cambiare anche la trama e il senso, della storia stessa. In più l’opposizione Sole-Luna nel mio tema natale mi ha dato, oltre alla repulsione per le gonne e i tacchi, questo supernonpotere di entrare facilmente nel punto di vista altrui, e per contro mi impedisce di avere le idee chiare sul mio, di punto di vista, ché addirittura se uno mi ruba il portafogli nel tram e io me ne accorgo sono capace di non dirgli niente per paura di ferirlo.

Mi affascinano i cattivi, quelli che stanno chiaramente dalla parte sbagliata, e non ne fanno granché mistero
Dicevo, comunque, che non è che la faccia di JD mi piaccia come mi piacciono certe facce di certi uomini. È proprio quella ferocia nello sguardo che mi attrae. E quella ferocia mi fa sistemare JD nella categoria “personaggi che mi affascinano perché non hanno l’aria rassicurante dei buoni, quelli che poi sotto sotto scava scava alla fine scopri sempre che c’è un bel po’ di ipocrisia”. Io i buoni non li sopporto molto, quei buoni che vendono bontà, spacciano bontà, scrivono bontà, che si preoccupano della buona educazione, che si indignano, che accarezzano i cuoricini di noi cuccioli di analfabeti funzionali e emotivi e ci dicono il bene è di qua, il male di là, e accendono un grande sole da un milione di megatoni che azzera le ombre, e si sentono autorizzati da un’etica delle cose-per-bene ad imporci un’etica delle cose-per-bene che funziona solo finché qualche amichetto loro non manda tutto in cortocircuito e allora li vedi agire nella più limpida e cristallina logica da branco della legalità che è una cosa ampiamente distante dalla giustizia.
Rifiato.
Mi affascinano i cattivi, quelli che stanno chiaramente dalla parte sbagliata, e non ne fanno granché mistero. JD rientra tra questi. A scanso di equivoci, non ho mai votato gente come lui, né mai la voterei, e se un giorno arriveranno gli Ufo e con loro indice lungo e nodoso indicheranno proprio me tra otto miliardi di abitanti del pianeta terra e mi diranno “Gjksh! Fhdu, fhi hf-mmn gaayha” che significa “Bipede terrestre! Scegli in libertà e coscienza chi sbattere nei nuovi gulag”, JD ce lo manderei, insieme a Trump, Musk, Thiel e insieme ai cattivi-manifesti e ai buoni-ipocriti di cui il mondo è pieno, da ovest a est, da nord a sud. Rimarrebbe comunque una bella fetta di popolazione mondiale, che non ha altra aspirazione se non quella di vivere nel modo più dignitoso possibile i pochi giri di ellittica attorno all’astro solare che ci sono concessi come esseri viventi.

Le radici hillbilly
Dunque Elegia Americana è un memoir: JD racconta la storia propria e della famiglia in cui è nato. Originari del Kentucky, in particolare della regione degli Appalachi, e completamente immersi nella cultura hillbilly, fatta di incapacità relazionali, uso smodato della violenza e un’etica manichea slegata dalla religione, i Vance sono una fra tante famiglie simili a loro, migranti interni (si trasferiscono in Ohio, dove è nato JD), senza prospettive reali di ascensione sociale, né di crescita umana e interiore. JD cresce soprattutto con sua nonna, un personaggio a metà strada tra la Sora Lella e l’Ispettore Callaghan, capace, comunque, di trasmettere al nipote quel po’ di valori e amore che a volte fanno la differenza di fronte a certi bivi della vita: di qua il burrone, di là il non burrone. Tra mille difficoltà, tra cui un disturbo dell’alimentazione e un’incapacità di gestire la rabbia, JD riesce in qualche modo a scampare al destino di tanti suoi simili. Si arruola nei marines – senza combattere però – si laurea in legge, si specializza alla prestigiosa Yale Law School. Qui si ferma il libro, che è uscito nel 2016 negli Stati Uniti. Non racconta l’ultimo tratto di vita di JD: né del suo incontro con Peter Thiel, che nel 2022 ha finanziato la sua campagna da senatore per l’Ohio con quindici milioni di dollari, né della sua gita a Mar-a-Lago, citofonare Trump, dove ha deposto ogni critica verso l’allora candidato e oggi neoeletto presidente e ha accettato l’investitura a vice: d’altronde la nonna è morta e forse il cartello con la scritta burrone non è più così leggibile.
un’intuizione drammaturgica: raccontare il proletariato bianco come se si trattasse di una minoranza etnica
Lo stile del libro non è particolarmente affascinante. Dedica troppe pagine alle sventure degli antenati, al reticolo parentale, alle contraddizioni della cultura hillbilly, e alcuni episodi nella sua vita sembrano proprio scritti per diventare una sceneggiatura, come poi è successo, ma senza grande successo. Eppure non è un caso se il libro è stato un bestseller, e se io stessa l’ho letto tutto, invece di abbandonarlo come a volte mi capita di fare. Credo dipenda da due motivi: il primo è un’intuizione drammaturgica: raccontare il proletariato bianco come se si trattasse di una minoranza etnica. Povertà, violenza, mancanza di prospettive, mancanza di un sogno, tanto caro agli statunitensi.
Le cause sono esterne ma anche interne, dice JD, e questa famiglia uguale a tante, di una comunità uguale a tante, questa grande fetta di paese che lotta per o si lascia semplicemente sopravvivere è uguale a tante minoranze, soffre come loro, soffoca come loro. È brutta, disperata e sporca come loro. Ed è l’emblema di un paese stanco, deluso, che amava pensarsi impero ma oggi non ne può più di pagare il prezzo. Quello che resta è il paesaggio spettrale, anche sotto un cielo sereno, di cittadine che hanno qualche scassato centro commerciale al posto del cuore. Cibo spazzatura, dormire coi jeans perché il pigiama è da signori, e la sensazione di non essere visti. Da nessuno. Né da chi sta in alto, né da chi sta intorno. Le tese note di violino (le sentivo io, non c’erano davvero) che accompagnano l’ascesa tormentata di JD sono un’eco di speranza, di sogno individuale, necessaria non soltanto alle vendite, ma all’intento politico del libro: riconoscere una crisi che è più estesa e abissale di quanto non si voglia ammettere, ma prospettare comunque una possibilità diversa. Missione compiuta, finora. almeno per JD.

La madre vittima e lo scettro del dolore
Il secondo motivo che mi ha fatto arrivare in fondo al libro è nascosto negli occhi feroci del suo autore. Prima non l’ho scritto, ma uno dei capisaldi della vita di JD è il rapporto con sua madre Beverly, figlia della nonna che di fatto lo ha cresciuto. Anche a lei sono dedicate molte pagine. Molti episodi, dall’infanzia all’età adulta. Diplomata infermiera, non è stata propriamente lo stereotipo della madre amorevole e dedita ai figli. JD racconta di come gli imponesse mariti diversi con una frequenza a dir poco atletica, di come questi uomini fossero spesso violenti, o incapaci di agire da adulti, e comunque ogni volta presenti per un tempo così limitato da impedire la nascita di una qualsiasi relazione padre-figlio. Racconta anche delle dipendenze della donna, dagli oppioidi all’eroina, degli entra e esci dalle cliniche di disintossicazione, delle bugie, dei furti, degli accessi d’ira ai limiti della psicosi, della sua disperata volontà di essere riconosciuta come l’unica vera vittima di casa, la detentrice dello scettro del dolore: quando la nonna di JD muore, Beverly cerca di vietare a JD e sua sorella di piangere. Rivendica il lutto tutto per sé, visto che lei è la persona che ha perso la madre. Per loro era solo la nonna. Una nonna che li aveva cresciuti, però, e si era fatta carico dei due bambini al posto suo. No, ha risposto a quel divieto di piangere la sorella di JD: Quella donna era anche nostra madre. Quelle parole sono vere per entrambi i ragazzi, e pesano più della sentenza di uno spietato tribunale.
È la banale constatazione che l’odio è una forza enorme, più grande dell’amore, più della paura, più di tutte le emozioni-per-bene che promettono pace e consegnano indolenza.
Con le parole, JD ci dice più volte di aver perdonato quella madre inadeguata. Ci dice di sapere che quella donna ha provato con tutta se stessa a essere una buona madre, e a volte ci è anche riuscita. Ci tiene a dirci di non essere più in collera con lei come lo era a dieci anni, o a dodici, mentre si ingozzava fino a scoppiare e era incapace di distinguere tra tristezza e rabbia. Ci dice che ora può guardare al passato senza rancore, perché è adulto, perché è cresciuto, in tutti i sensi, perché ha capito che impegno, un po’ d’amore familiare, e il coraggio di andare per il mondo possono salvare un individuo. Ma io non ti ho creduto, JD. Io so che tu la odi ancora, anche se forse tu non lo sai, e che quel sinistro scintillio nei tuoi occhi così chiari è fatto in gran parte di quell’odio.
Non è un giudizio. È la banale constatazione che l’odio è una forza enorme, più grande dell’amore, più della paura, più di tutte le emozioni-per-bene che promettono pace e consegnano indolenza. Quanti esseri umani sulla faccia della terra hanno madri o padri o entrambi i genitori come la madre di JD? Tanti. E non importa se siano tossicodipendenti o narcisisti, solo pigri o troppo taciturni, se il loro disvalore affondi le radici più nella chimica o in qualche remoto ingranaggio del cervello. Se esistesse un modo per conoscere la vera verità, probabilmente ogni genitore meriterebbe l’odio di almeno uno dei suoi figli. Se questo odio poi nascerà e avrà voce, se resterà inascoltato come un giradischi dimenticato acceso in una casa disabitata, o si trasformerà in un atto di vita o di morte, dipende dal figlio stesso. JD il suo piccolo gomitolo d’odio l’ha ingoiato e lo ha digerito, fino a renderlo parte della propria stessa natura. L’ha usato, consapevolmente o meno, per arrivare dove voleva. Che non significa dove è giusto o bene che arrivasse. Ognuno ha bisogno di qualcosa per diventare ciò che è, e JD ha avuto questo. I suoi occhi lo raccontano, e anche il dietro delle sue parole.

Come (non) tradire le proprie origini
C’è anche un altro aspetto nelle pagine del libro che mi ha colpito molto, perché l’ho riconosciuto come autentico. È legato ancora all’odio, o alla sua versione più sdentata che è il rancore. È un episodio che si svolge in una pompa di benzina. Lui è lì, con la maglietta della Yale Law School. È uno studente brillante, ormai, e sta tornando a casa in Ohio per una festa comandata. Milleduecento chilometri di strada fra New Haven, dove studia, a Midlletown, la sua città d’origine. Mentre fa benzina durante una sosta, si ferma un’altra auto. È guidata da una signora, che gli vede addosso la maglietta e gli chiede se anche lui abbia studiato a Yale, proprio come lei. JD esita, poi mente, dice che alla Yale studia la sua fidanzata, non lui. Mente per istinto, mente per quel pizzico alla bocca dello stomaco che non sente solo chi è hillbilly, ma che appartiene a tanti, tantissimi, alla maggior parte di noi abitanti della terra. Mente perché quella signora ricca, con la bella macchina e i capelli ben acconciati è evidentemente parte da diverse generazioni dell’élite a cui lui, per nascita, non appartiene, e nella quale solo ora sta cercando di entrare
Quello che JD prova è una sensazione amara, fatta un po’ di vergogna, un po’ di disprezzo, un po’ di desiderio, un po’ senso di inferiorità: la proviamo in tanti di fronte a chi appartiene a una classe superiore. Non parlo di soldi in senso stretto. Parlo di quelle persone che per tradizione di generazioni hanno avuto accesso a cultura e potere. Li distingui perché non camminano, loro: si sospingono nel mondo, senza paura dell’errore, senza il timore di parlare, di far parte di gruppi, di incontrare gli altri, di dire quello che pensano, di chiedere e concedere, di approfittare e tessere relazioni e interessi, nell’interesse proprio e altrui. JD mentì a quella donna perché, scrive, ammettere di essere uno studente della Yale avrebbe significato tradire la storia della sua famiglia. Rinnegare l’alcolismo di suo nonno, la volgarità dei suoi zii, le vene gonfie di sua nonna e le gravidanze precoci di sua sorella, quel modo di sopravvivere alla fatica e nella fatica, dove il massimo del nutrimento interiore è passare ore stravaccati sul divano a guardare un programma di tv trash. E rispondere di sì a quella signora, dire che effettivamente era uno studente della Yale avrebbe significato anche ammettere che appartenere a quella classe sociale così distante da lui, così nemica nella sua cotonata sicurezza, era proprio l’obiettivo di tutto il suo impegno, e dei suoi sforzi di cambiare il destino inscritto nelle sue origini.
Molti di noi, invece, la maggior parte forse, continueranno per tutta la vita a sentire quel groviglio di repulsione, desiderio e senso di inadeguatezza verso chi ha storie più altolocate o elitarie
Alla consapevolezza di questa contraddizione, JD fa seguire alcune pagine sull’importanza del capitale umano: chi è in alto sa che avere attorno persone utili (senza giudizio di valore sull’aggettivo) è necessario per crescere, e si avvale della rete di relazioni, il capitale umano appunto, senza incertezze di natura morale o romanticherie da eroi solitari fieri di “non dover dire grazie a nessuno”. Perché più dei soldi, più delle cariche, è la capacità di unirsi agli altri che fa la differenza. L’unione fa la forza, e il potere, nel bene e nel male, non è mai materia stabile nelle mani di uno solo, ma un fuoco tenuto acceso da molte, coese vestali, ognuna capace di stare, nelle cose e con gli altri. Buoni veri e cattivi veri lo sanno molto più di chi non è né così cattivo né così buono da cambiare non dico il mondo ma almeno la propria vita. Ora che ha quarant’anni, è vicepresidente degli Stati Uniti, e ha il sostegno delle potenti imprese della Silicon Valley di cui è diventato anche investitore, JD sembra aver sciolto quel sentimento che anni fa lo aveva spinto a mentire alla domanda di una sconosciuta. Molti di noi, invece, la maggior parte forse, continueranno per tutta la vita a sentire quel groviglio di repulsione, desiderio e senso di inadeguatezza verso chi ha storie più altolocate o elitarie.
La maggior parte di noi, di fronte a certi bivi della vita, di quelli che ti chiedono di cambiare pelle, esita. E mentre cerchiamo di capire se sia più autentico il desiderio che abbiamo di qualcosa di diverso, o il senso di appartenenza alla lunga catena di persone senza volto che ci hanno preceduti, lasciamo che la vita scorra. Non odiamo abbastanza chi ci sovrasta, né ne desideriamo abbastanza il posto. Non vogliamo tradire chi fu prima di noi, rinunciare come si dice alle radici, e allo stesso tempo di quelle radici conosciamo le mancanze, i vizi, i buchi.
Per la maggior parte di noi esseri umani la vita passa così, nel grigio rancoderio, un po’ rancore un po’ desiderio: un sentimento contraddittorio, identitario, confortevole come il letto di quel posto che chiamiamo casa. Che ci abbatte perché nulla cambierà, e ci consola perché nulla cambierà. È trino, quadruplice, multiplice, e ha la consistenza delle sabbie mobili. Non è unico, duro e limpido come lo sguardo di un figlio che non ha ancora smesso di odiare la sua storta madre. Se lo fosse, saremmo capaci di alzarci, lasciare a terra le zavorre, e di fare quello che serve per diventare quello che siamo.