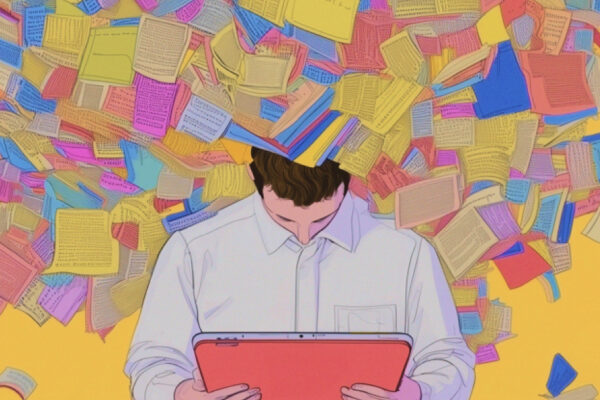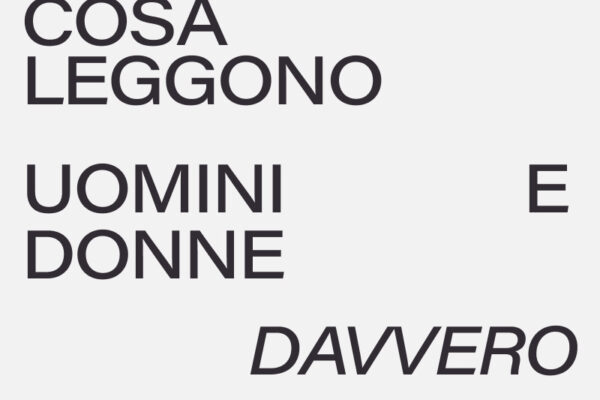La storia, la sappiamo tutti.
Eppure, nonostante leggiamo commenti social e articoli di magazine non ci sembra di aver capito così tanto di più. In primo luogo perché c’è una frattura semiotica tra la maggior parte dei commentatori e il linguaggio di internet.
Sappiamo che sui bossoli di Tyler Robinson erano scritte le seguenti frasi
“Notices bulge OwO whats this?”
“Hey fascist! Catch! ⬆️, ➡️, ⬇️⬇️⬇️”
“O bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!”
“If you read this you are gay lmao”.
La prima frase è un riferimento a un meme, un copypasta virale che parodia la cultura furry e dei giochi di ruolo online , apparso per la prima volta online nel 2013. Copypasta? Appunto.
La seconda è un riferimento al videogioco Helldivers 2 con una combinazione di frecce che attiva l’attacco bomba più potente del gioco.
La terza, la conosciamo tutti, ma sembra che il suo significato originario sia talmente sbiadito e che sia più probabile che Tyler Robinson l’abbia preso da un altro videogioco, Far Cry 6.
La quarta è una battutina omofoba adolescente che si trova online, come su qualsiasi banco di scuola.
Ryan Broderick e Adam Bumas su Garbage Day sostengono che Charlie Kirk è stato ucciso da un meme. E che molti episodi di violenza politica siano nati da questo brodo culturale. Il primo è avvenuto in Nuova Zelanda nel 2019. Da allora molto gruppi e singoli si sono organizzati su Discord e Telegram. C’è addirittura una cellula terroristica chiamata 764 che recluta su internet e incoraggia i suoi membri a compiere crimini per aver maggior seguito sulla rete. C’è una sorta di movimento accelerazionista nichilista che vuole creare semplicemente il caos e prendersi gioco di chiunque tenti di capire tramite la logica tradizionale.
Joker incontra Fight Club featuring Adolescence? Chissà.
Se già così non fosse abbastanza complicato, c’è anche la seconda parte della questione: siamo immersi in un’infosfera in cui ognuno cerca di persuadere grossolanamente con obiettivi di posizionamento politico o commerciale. Le nostre comunicazioni si svolgono spesso all’interno di piattaforme studiate apposta per creare flame e conflitto senza risoluzione. E nel nostro cervello si attivano sempre bias cognitivi in grado di distorcere il significato di quello che ascoltiamo.
Per esempio:
Chi possiede competenze limitate in un campo tende a sopravvalutare le proprie conoscenze e a ridurre la complessità dell’argomento. Chi è più esperto sottovaluta le proprie o comunque, a volte, fa più domande. Si chiama Effetto Dunning-Kruger. È un bias cognitivo tra i tanti che abbiamo visto nella comunicazione subito dopo l’omicidio di Charlie Kirk.
Io, per esempio, ho subito detto: “L’assassino è una persona con un addestramento militare. Non si spara da 140 metri con quella precisione.”
L’esperto: “Con un fucile bolt-action Mauser calibro .30-06 quella distanza non è impegnativa per un civile abituato a sparare: rientra nella normalità della caccia, per esempio. Certo, la certezza del primo colpo implica che…”
Poi c’è la Camera dell’eco: l’effetto per cui gli algoritmi e le nostre ricerche online creano un ambiente in cui non ci sono reali alternative alla nostra opinione, nessun suono che non ripete quello che già conosciamo riesce a filtrare dentro. Per esempio quasi tutti si sono divisi:
“Charlie Kirk è stato ucciso dalla violenza Antifa.”
“Charlie Kirk è stato ucciso dal suo stesso odio e dalla cultura delle armi statunitense.”
Un parente di questo meccanismo è il Bias di conferma per cui selezioniamo solo le informazioni che confermano quello che pensiamo ed evitiamo le altre. Anzi, se qualcuno ci mostra bruscamente le prove che contraddicono la nostra tesi si produce l’Effetto ritorno di fiamma per cui, paradossalmente, rafforziamo la nostra posizione originale.
“Sul proiettile di Tyler Robinson c’era scritto Bella ciao, era chiaramente una persona di sinistra.”
“Le testate più autorevoli hanno mostrato che era vicino al gruppo alt right dei Groyper e il riferimento Bella Ciao proveniva da un videogioco.”
“Le testate più autorevoli? Ovvio che, come sempre, vogliono mascherare la verità.”
L’influenza del gruppo di riferimento. Per milioni di anni l’esclusione della tribù ha significato la morte dell’individuo. Oggi produce isolamento, perdita dell’affetto o, addirittura, del lavoro. Evitiamo di esprimere dubbi e ci allineiamo alla versione del gruppo dominante, o del nostro gruppo.
Dentro un centro sociale: “Beh, alla fine come diceva lui la sua morte era un effetto collaterale del Secondo Emendamento. E poi era razzista, omofobo e maschilista…”
In un aperitivo di intellettuali conservatori (che scrivono per un giornale che professa il liberismo senza rinunciare a un centesimo di finanziamenti statali): “Beh, è morta una persona per le sue idee. È incredibile che ci sia tanta violenza in giro e ognuno non possa più esprimere un’opinione dissonante”
Di solito è difficile intervenire con un “Sì, tuttavia…”, e rimanere nel gruppo.
Per concludere, perché nonostante nessuno avesse potuto approfondire nulla i giornalisti e i politici già erano pronti per vidimare la verità? Si tratta dell’Effetto ancoraggio. La prima informazione ricevuta su un argomento (l’àncora) influenza sproporzionatamente tutti i giudizi e le interpretazioni successive, anche quando è: completamente irrilevante, palesemente sbagliata, fornita da fonti non credibili. Questo comporta anche che le smentite sono spesso inefficaci, i titoli clickbait funzionano anche quando l’articolo li contraddice, le prime ricostruzioni banali di eventi complessi diventano “verità” durature.
Quindi: il significato, lo sappiamo tutti.
Forse non c’è nemmeno bisogno di ascoltare la storia.