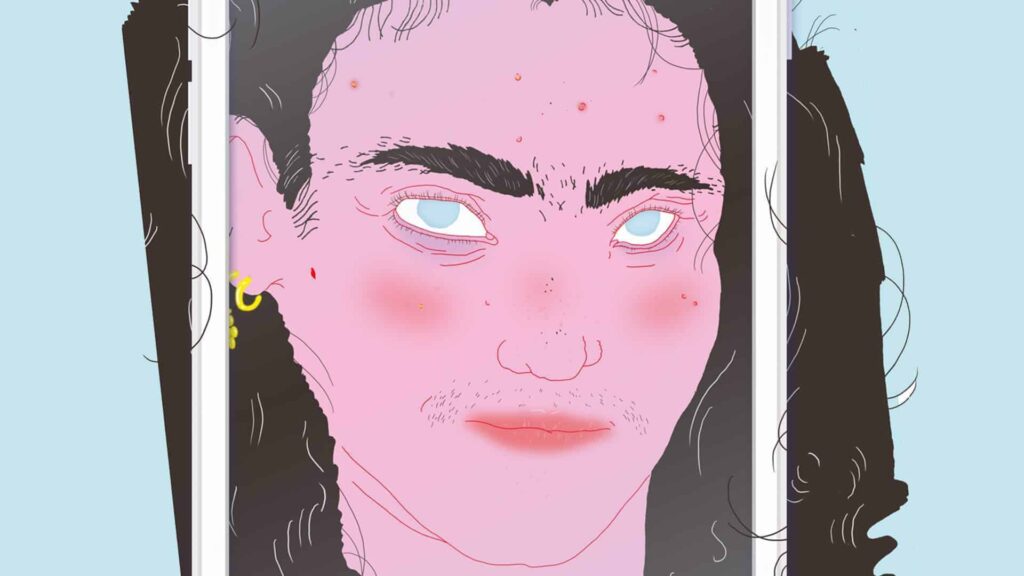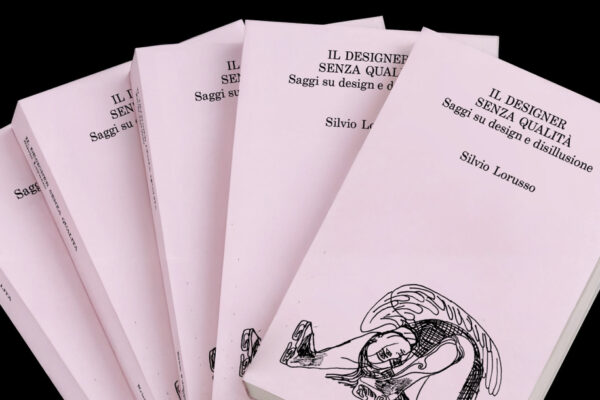Il 6 maggio 2021 esce su Repubblica un pezzo di opinione di Natalia Aspesi legato alla notizia della morte di Luana d’Orazio, l’operaia di 22 anni uccisa da un macchinario tessile nella fabbrica in cui lavorava. Il testo è stato ampiamente analizzato, persino le analisi sono state analizzate. Per farne il riassunto più breve possibile, Aspesi chiede alle femministe della nuova generazione di occuparsi di morti sul lavoro oltre che di bodyshaming e cat calling. (Vorrei dire che sto scrivendo in punta di piedi ma non avrebbe senso, come si dice in questi casi? “Scrivo in punta di falangetta”?)
Nell’introduzione, Aspesi sottolinea quanto fosse bella d’Orazio e la descrive raccontando alcuni fatti della sua vita e ipotizzando somiglianze e differenze con le sue coetanee, alcune delle quali impegnate a condividere temi del femminismo contemporaneo. Dice ad esempio che Luana forse “non si offendeva se qualcuno le fischiava in strada”, ma anche che “non aveva foruncoli di cui vantarsi per lamentarsene coi follower”.
Questa frase mi ha particolarmente colpito (cioè non solo questa, però il tema qui è un altro, mamma mia sono appena all’inizio e sono già sudatissima): tra i comportamenti considerati stereotipi del femminismo contemporaneo c’è la lotta contro il cat calling, quella contro il fat shaming, ma mi sembra sia la prima volta in cui tra le pratiche ripetute così assiduamente da diventare motivo di scherno c’è anche il mostrare i propri brufoli. Non che sia una nicchia, ormai è una pratica abbastanza diffusa tra certe ragazze che si esprimono su temi socialmente rilevanti, però alla fine solo quando una cosa diventa risibile ti accorgi che è reale.

Certo, il fatto che la mia lamentela sui brufoli l’abbia pubblicata un giornale, Domani, mi fa sentire un po’ colta in flagrante dalla frase di Aspesi, ma a questo punto non so bene dove collocarmi: se faccio una lamentela moderna su un mezzo di comunicazione del passato mi considero comunque parte della quarta ondata, o è più terza ondata e tre quarti? Comunque, il mio brufoloso passato recente mi ha portata a guardare con interesse le giovani donne famose che improvvisamente toglievano filtri e fondotinta per mostrare la loro acne.
Tre casi italiani sono Giulia de Lellis, Aurora Ramazzotti e Matilda de Angelis, ognuna con diverse modalità ma tutte hanno usato parole molto simili: “paura”, “coraggio”, “verità”. Tutte e tre si sono “rivelate” su Instagram, o con un post nel feed o con varie stories. Instagram è uno dei mezzi di comunicazione più usati da celebrità ventenni che hanno un lavoro legato all’immagine, quindi è abbastanza ovvio che il post rivelazione dell’acne venga pubblicato lì. Ma si capisce anche che, in modo più o meno consapevole, queste tre ragazze collegano il messaggio, e soprattutto la necessità di accompagnarlo a un tono epico o drammatico, al mezzo su cui viene condiviso. “Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano”, ha scritto Aurora Ramazzotti il 18 luglio 2020 quando ha pubblicato la prima foto senza ritoccare la pelle del viso, coperta dall’acne, “sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella”. La foto ha più di 700mila like.
Sono d’accordo con l’idea di Ramazzotti che Instagram non sia una piattaforma fatta per essere umani (non esistono piattaforme per essere umani, ma su Instagram devi essere brillante e insieme bona, a quel punto è più rilassante stare su Twitter dove devi solo essere stronzo), ma l’exploit del suo post e di molti altri sul genere mi ricordano quella fase della TV italiana commerciale in cui dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi, le sue reti continuavano a contenere delle nicchie di dissenso politico, come una piccola goccia di veleno assunta quotidianamente per diventarne immuni. Questi post dovrebbero rappresentare l’opposto di quello che è Instagram, e invece entrano a far parte del contesto in maniera naturale, senza disturbare gli altri post carichi di perfezionismo.
Un bellissimo articolo di Jia Tolentino per il New Yorker, The age of Instagram face spiega qual è la prassi estetica su questo social. La “Instagram face” è la faccia che avete visto sui corpi delle donne più seguite online, composta da un naso a punta, labbra carnose, zigomi alti, occhi e sopracciglia curvate verso l’alto – insomma, Bella Hadid. Un volto che si raggiunge in due modi: con i filtri già presenti su Instagram o su altre applicazioni come FaceTune; con la chirurgia estetica, che grazie ai filler è diventata sempre meno invasiva senza perdere in efficacia. Quindi questa storia del farsi vedere con l’acne è una reazione a tutto questo voler correggere la propria faccia? Un po’ sì, ma secondo me c’è un altro elemento che è stata l’ulteriore goccia. E ora sedetevi che inizia una lezione di storia che Barbero se la sogna.
Nel 2012, dopo una foto pubblicata su Instagram da Kim Kardashian, tutti impazziscono per il contouring. Con abbastanza allenamento e una carta oro Sephora è facile raggiungere risultati non troppo diversi da quelli della chirurgia estetica per il selfie perfetto. Dal contouring alla Glossier-mania e la skin positivity
Esiste una tecnica di make-up chiamata “contouring”, traducibile con un orrendo “contornatura” che è un attimo sbagliarsi e scrivere “contronatura”. Si basa sull’utilizzo di pigmenti più scuri di una o due tonalità in alcune zone del viso (sotto gli zigomi, ai lati del naso, sul perimetro dell’ovale…) e di più chiari in altre (parte alta delle guance, punta del naso…) per definire meglio o modificare in maniera sostanziale i tratti del volto.
Le prime tracce di contouring sono sulle facce degli attori del teatro elisabettiano tra fine ‘500 e inizio ‘600. Per rendere più visibili i segni delle espressioni del volto, si creava un effetto chiaroscuro con gesso e fuliggine. Con il tempo cambiano i prodotti usati, ma il countoring resta roba per attori e attrici per tutto il ‘700, l’800 e nella golden age di Hollywood a inizio ‘900 – gli zigomi di Marlene Dietrich? Tutto contouring.
Con fasi più o meno altalenanti, il contouring resta una cosa interna all’industria cinematografica, alla moda e alle esibizioni sul palco – in particolare viene usato nel mondo drag, insieme a tante altre tecniche che hanno cambiato il make-up. La ragione è molto precisa: il contouring non è fatto per essere visto da vicino, ma fa miracoli sullo schermo.
Ed eccoci qui, nel 2012 Facebook acquista Instagram e Kim Kardashian pubblica una foto in cui si vedono sul viso tutti i punti e le colorazioni che il suo truccatore le ha applicato per realizzare il contouring. Tutti impazziscono, tutti creano linee di cosmetici per il contouring. Con abbastanza allenamento e una carta oro Sephora è facile raggiungere risultati non troppo diversi da quelli della chirurgia estetica per il selfie perfetto.
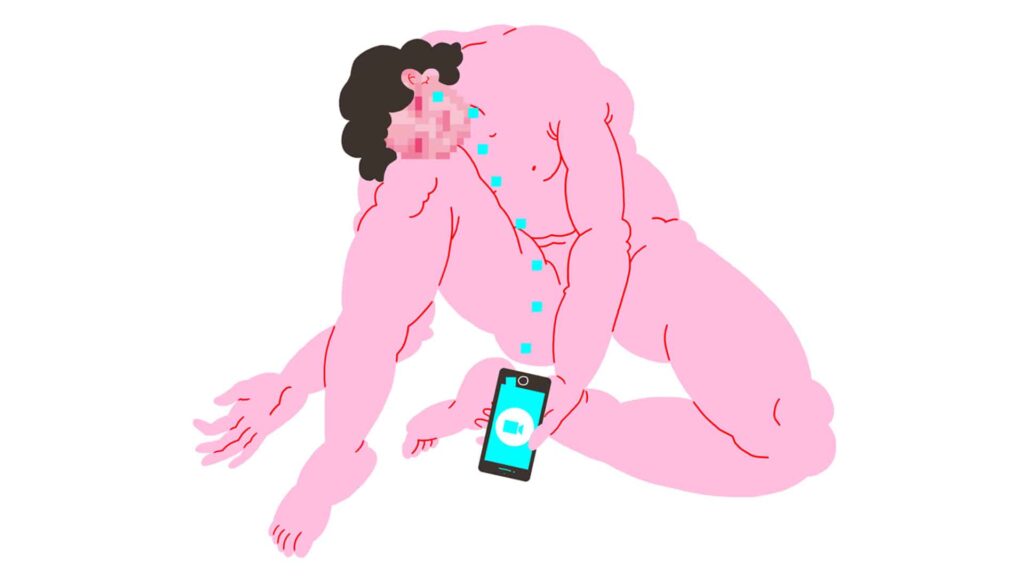
Ovviamente ha continuato a esistere un mondo di ragazze che non avevano nessuna voglia di investire in prodotti per il contouring. Scusate, riformulo: ovviamente tutte abbiamo comprato prodotti per il contouring, ma poche di noi hanno avuto la pazienza di capire come andavano usati. Per cui se ogni riforma ha la sua controriforma, il concilio di Trento del make-up potrebbe corrispondere al lancio di Glossier nel 2014 (vogliamo dire che Kim Kardashian è Martin Lutero? Perché no). Glossier è un marchio di skincare e make-up fondato da Emily Weiss a partire dalla piattaforma di news dal mondo beauty Into the Gloss. Le informazioni raccolte attraverso i commenti hanno fatto da base alla creazione di prodotti lanciati con il claim Skin first, make-up second – prima la pelle, poi il trucco.
I primi quattro prodotti a essere lanciati sono un balsamo multiuso (per lo più usato come un burrocacao), un tonico spray, una crema idratante per pelli normali e una “skin tint”, ovvero un fondotinta non coprente (quello che suona come un ossimoro, nella cosmesi è un affare da milioni di dollari). La campagna di lancio è accompagnata da foto di modelle con facce pulite e video di donne “vere” che integrano i prodotti Glossier nella loro beauty routine. Dalla prima inquadratura all’ultima i loro visi cambiano pochissimo secondo il principio del make-up your skin but better, la tua pelle ma meglio. Sui social è un successo incredibile, ma non è una linea di trucchi tradizionale, nel senso che a malapena trucca.
Non è un caso che l’anno dei primi successi di Glossier sia lo stesso in cui diventa un trend negli Stati Uniti e in Europa la skincare coreana. Il prodotto-simbolo è la maschera di tessuto imbevuta di siero, ma è composta da molti altri prodotti che compongono i 10 passaggi che andrebbero fatti ogni mattina per ottenere una pelle perfetta, ovvero senza brufoli, con pori strettissimi e un naturale “glow” (non ho idea di come tradurlo, “bagliore”? “Lucentezza”? Per rendere l’idea, è una pelle che riflette la luce – ovviamente non perché è unta, così sarebbero buoni tutti). Nello stesso periodo si diffonde nel mass market l’esfoliazione chimica, molto diversa dal vecchio scrub ruvido che gratta via le cellule morte, per ridefinire la grana della pelle. Con abbastanza ricerca del principio attivo giusto, e sempre una carta oro da Sephora, si può raggiungere una pelle a cui basta solo un filo di “skin tint” per essere perfetta in qualsiasi foto, anche quelle fatte a sorpresa (ne esistono ancora?).
Entrambe queste scuole dell’estetica hanno trovato la loro casa su Instagram, non solo per il risvolto pratico di renderci migliori in foto, ma anche perché l’influencer marketing sembra nato per il mercato della cosmesi: la promessa di autenticità delle persone sui social, insieme all’esposizione costante del proprio volto, hanno risolto la richiesta dei consumatori di campagne pubblicitarie più “vere” unendoci il piacere voyeuristico di sapere ogni dettaglio dietro all’immagine delle influencer.
Il mercato della cosmesi si sta adattando molto velocemente al nuovo trend della skin positivity, sia sfruttando le sue rappresentanti per promuovere altro genere di prodotti che lascino la pelle naturale, oppure per accompagnarle nel percorso di accettazione che le porterà a sconfiggere l’acne.
Sapete chi non può sfruttare il contouring, chi non se ne fa niente del trucco naturale e chi non vede nessun miglioramento dai 10 step coreani o dall’esfoliazione chimica? Chi ha l’acne. Quando nelle sit-com un’attrice restava incinta e la gravidanza non era prevista dalla sceneggiatura, i costumisti e i registi usavano stratagemmi di vario tipo per nascondere il pancione, che ovviamente si vedeva comunque. Il trucco sull’acne è la stessa cosa: essendo un difetto della pelle che crea spessori, fatto anche di piccole croste su sui è molto difficile applicare prodotti, il risultato del trucco non è mai soddisfacente. Per quel che riguarda invece la skin care, sono pochissimi i prodotti che possono fare qualcosa su una pelle molto infiammata, perché le cause principali dell’acne sono endogene e curabili con farmaci o terapie specifiche.
Vista l’eccessiva attenzione sui volti di social come Instagram e la pervasività delle pubblicità di prodotti che dovrebbero rendere la pelle splendida ma funzionano solo su chi ce l’ha già, nel 2019 si è iniziato a diffondere il movimento della #skinpositivity, che comprende al suo interno persone con vari problemi di pelle come vitiligine, rosacea e acne.
Visto che quest’ultima è la condizione più pervasiva, secondo i dati ne soffre in maniera più o meno lieve l’80% della popolazione giovane dai 13 ai 17 anni e il 15% delle donne sopra i 25 anni (eccomi qua), l’acne positivity ha un posto predominante, e i post di Aurora Ramazzotti e Matilda de Angelis si trovano in questo sottogruppo. Sempre più ragazze e ragazzi postano foto senza filtri in cui mostrano le loro papule oppure le cicatrici lasciate dalle cure aggressive, allegando racconti su quanto sia stato difficile convivere con questa pelle (l’acne non è semplicemente brutta, può essere anche molto dolorosa), quanto sia un atto di coraggio mostrarsi senza filtri in una società in cui l’estetica è un aspetto fondamentale e quanto sia importante amare la propria pelle così com’è ogni giorno. Ed è così che, rendendo superfluo il mercato della cosmesi, hanno sconfitto il capitalismo, una goccia di pus alla volta.
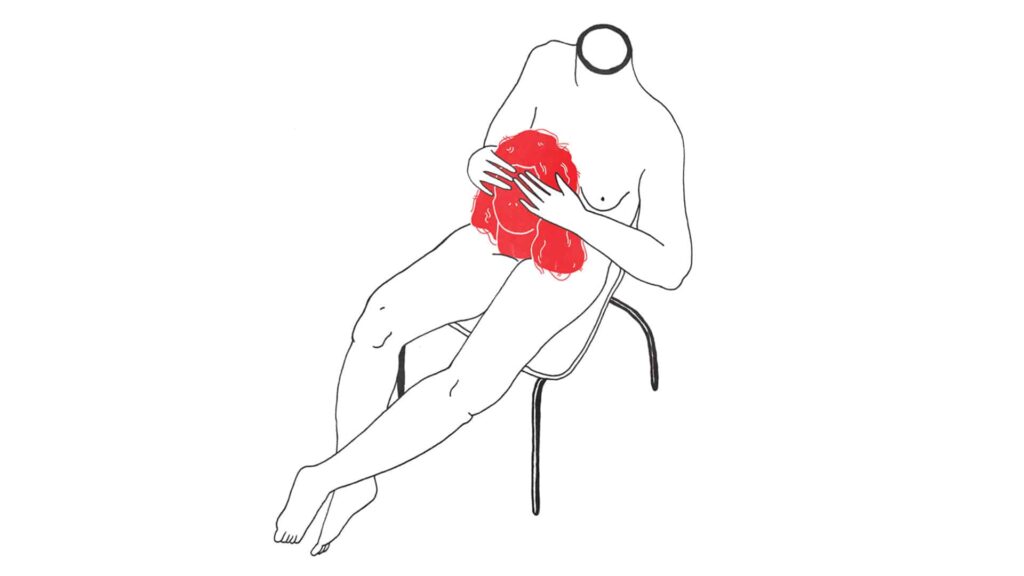
No, non è vero. Il mercato della cosmesi si sta adattando molto velocemente al nuovo trend della skin positivity, sia sfruttando le sue rappresentanti per promuovere altro genere di prodotti che lascino la pelle naturale – non è che una coi brufoli non si mette il mascara – oppure per accompagnarle nel percorso di accettazione che, com’è come non è, le porterà a sconfiggere l’acne.
Esempio in questo senso è Kendall Jenner, che nel 2019 è diventata testimonial di una celebre linea di skincare per pelli a tendenza acneica dopo aver fatto coming out. Scusatemi se rubo terminologie da altri contesti in cui hanno un peso più importante, ma l’enfasi usata in molti di questi post è spesso simile ad altri tipi di coming out che hanno delle conseguenze sociali e politiche ben diverse da una condizione transitoria. Ma è proprio in questa enfasi che resta il seme dell’invidiabilità, un concetto basilare della pubblicità: nel settimo saggio contenuto in Questione di sguardi, datato 1972, il critico d’arte John Berger parla del concetto di glamour, sottolineando che non può esistere se l’invidia sociale non è un’emozione comune e diffusa.
Le nobildonne ritratte nei quadri del ‘700 potevano essere ricche, belle, talentuose, ma non erano glamour perché quello che erano non dipendeva dal desiderio degli altri di essere come loro, mentre la Marilyn di Warhol è glamour, perché è una creatura dell’invidia altrui. E mentre la donna e l’uomo contemporanei vivono in balia del senso di impotenza verso la loro condizione e l’invidia verso quello che vorrebbero diventare, la pubblicità si posizione nel centro, eliminando la tua impotenza attraverso il consumo e rendendoti invidiabile grazie al prodotte che vende. Se nel 2021 una pelle liscia non è più così invidiabile, si proverà a vendere il coraggio di portare in giro la propria acne pensando di essere bella come la testimonial (che ha i brufoli, ma è anche incredibilmente fregna, però questo non lo diciamo).
Alcune persone che si sono inizialmente riviste nella skin positivity ora stanno cercando di spostarsi verso la skin neutrality, cioè un atteggiamento che va oltre la richiesta di amare la propria faccia sempre e comunque e che considera la pelle per quello che è: l’enorme sacco che contiene i nostri organi e che passa tutto il tempo a produrre robe tipo brufoli o nei o rughe o pruriti senza che possiamo farci troppo a riguardo – questa è la descrizione che faccio io, tardona della skin neutrality. C’è da chiedersi però se si può definire come “neutrale” un atteggiamento che ci fa comunque produrre degli hashtag, non è come scrivere a un ex per dirgli che non si pensa più a lui?
In ogni caso, il 28 aprile 2021 Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto per mostrare che l’acne è stata sconfitta. Le nostre congratulazioni.
Come spiegano Aloisi e De Stefano, mentre il mito del soluzionismo tech sembra poggiarsi su basi sempre più fragili e traballare anche agli occhi dell’opinione pubblica, è importante ridiscutere i valori dell’innovazione e i meccanismi di redistribuzione e protezione sociale. L’Universal Basic Income (reddito universale di base), è tra gli scenari più invocati, ma, nonostante rappresenti un importante strumento democratico per proteggere i lavoratori dal cedere a condizioni denigranti, potrebbe non bastare per risolvere la condizione nell’ultimo miglio, con la conseguenza indesiderata di distrarci dai bisogni immediati della forza lavoro di oggi.
Le proposte individuate sia da Aloisi e De Stefano, che da Gray e Suri sono diverse: dal rimettere gli esseri umani al centro delle decisioni algoritmiche (human-in-command) alla creazione di ambienti di lavoro digitali che restituiscano dignità alle lavoratrici e i lavoratori fantasma, ma anche la possibilità di contrattare l’algoritmo (e il trattamento dei dati degli utenti) con le piattaforme proprietarie, la ristrutturazione delle categorie di lavoro autonomo e subordinato per includere il lavoro non-standard (termine ombrello per tutte le definizioni che abbiamo dato sopra) e l’istituzione di codici di condotta e sindacati digitali. Infine, Casilli propone il ritorno all’origine del concetto di piattaforma, in quanto modello non predatorio in grado di sostituire la proprietà sociale a quella privata e rimettere al centro del discorso il lavoro come bene comune, non privatizzato e soggetto a dinamiche di sfruttamento ed estrazione.
È cruciale che queste proposte, insieme alle rivendicazioni sempre più frequenti di lavoratori e lavoratrici delle piattaforme, trovino spazio e voce al più presto possibile, insieme all’idea che il problema non risieda solo nel modo in cui utilizziamo determinati strumenti tecnologici, ma anche nei sistemi in cui quest’ultimi sono inseriti e all’interno dei quali vengono prodotti, in questo caso il capitalismo (o qualcosa di peggiore?) e del neoliberismo. La domanda più importante, allora, potrebbe non essere solo qual è il futuro per il lavoro umano e l’automazione, o se i robot riusciranno davvero a sostituirci nei processi produttivi, ma quali saranno le forze e i principi attori con il potere di ridiscutere questo futuro e decidere come e se continuare a percorrere questo interminabile ultimo miglio.