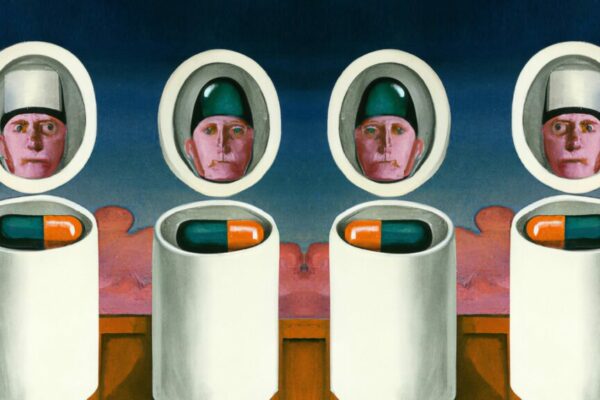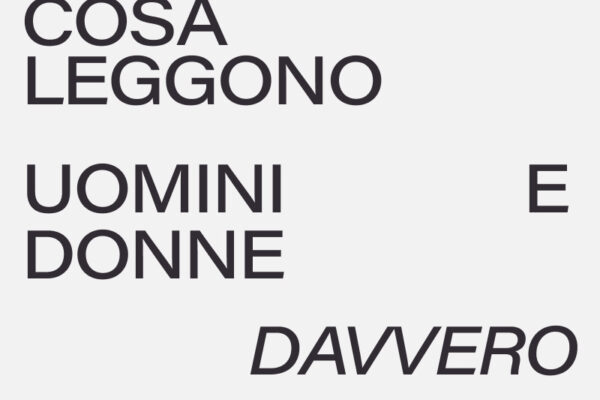Tredici anni, l’inizio della pubertà. Al “quartier generale” arriva un’emozione nuova, Ansia. È ciò che accade a Riley, la protagonista di Inside out 2, il sequel del cartone Pixar che ha battuto ogni record di incasso la scorsa estate. Ansia prova a influenzare le cosiddette funzioni esecutive della ragazza (memoria di lavoro, problem solving…), monopolizzando la “console”, una divertente rivisitazione dei centri di controllo del nostro cervello. Quando ci riesce Riley si paralizza, ha cioè un attacco di panico, che possiamo immaginare come un blocco delle comunicazioni tra le diverse zone celebrali.
Da un punto di vista cognitivo, l’ansia – così è definita nel DSM-5, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – è un dispositivo emotivo formidabile che si innesca «in risposta o previsione di un evento». In altre parole, l’ansia per esempio provoca l’input della paura, anticipandone persino la percezione dei nostri cinque sensi. Com’è intuibile, gli sceneggiatori di Inside out 2 non hanno scelto di rappresentare proprio l’ansia senza una ragione. Stando ai dati più recenti, infatti, il disturbo d’ansia generalizzato (GAD) è la patologia mentale che caratterizza di più i giovani, principalmente dalla generazione Z, o Gen Z (coloro nati dopo il 1995), in avanti. Tra i disturbi associati più frequenti, troviamo il cosiddetto disturbo depressivo maggiore (MDD), il cui sintomo chiave, sempre secondo il DSM-5, è l’inappetenza emotiva, ossia una continua sensazione di vuoto e tristezza.
Secondo lo psicologo sociale Jonathan Haidt, l’aumento del tasso di disturbi mentali dalla Gen Z in poi, scaturito tra il 2010 e il 2015, è stato provocato dall’utilizzo «costante» dei Social Network come Facebook, Instagram (e oggi TikTok)
In base alle rilevazioni dal 2010 in poi, tra gli studenti universitari statunitensi le percentuali relative a GAD e MDD sono aumentate rispettivamente del 134% e del 106%; se consideriamo i dati per fascia d’età, l’incremento invece è stato del 139 % tra 18 e 25 anni, del 103% tra 26 e 34 anni. La tendenza americana – comune ad altri paesi anglofoni – sembra avere riscontro anche oltreoceano: nel nord Europa, per esempio, gli adolescenti che riferiscono di un elevato disagio psichico sono in media aumentati del 63,8% dal 2010 al 2018. Riguardo l’Italia non abbiamo dati precisi, ma sappiamo che post-Covid un ragazzo su due soffre di ansia o depressione tra i 18 e 25 anni.
La «grande riconfigurazione»
Secondo lo psicologo sociale Jonathan Haidt, l’aumento del tasso di disturbi mentali dalla Gen Z in poi, scaturito tra il 2010 e il 2015, è stato provocato dall’utilizzo «costante» dei Social Network come Facebook, Instagram (e oggi TikTok), introdotti proprio attorno al 2010 (qui tralascio per semplicità l’argomentazione aggiuntiva di Haidt sulle cause dell’iperprotezione genitoriale). È la tesi riassunta nel saggio The Anxious Generation, appena pubblicato anche in Italia per Rizzoli, che amplia la ricerca di Haidt iniziata qualche anno fa in The Coddling of the American Mind (Penguin Press, 2018).
Più nel dettaglio, lo psicologo sostiene che a partire dalla Gen Z, ovvero la prima «della storia ad aver attraversato la pubertà con in tasca un universo alternativo», ha avuto luogo quella che chiama la «grande riconfigurazione» da un’infanzia e adolescenza «basata sul gioco» a una incentrata «sull’uso del telefono». In altri termini, per Haidt, le «generazioni ansiose» di oggi sono il risultato di un progressivo allontanamento dal «mondo reale» verso il «mondo virtuale» dello smartphone. L’attrazione verso quest’ultimo sembra aver colpito tra l’altro più le ragazze dei ragazzi, perché, si dice nel saggio, le aziende che controllano i Social Network (Meta, X, …) sfrutterebbero la cosiddetta «esigenza di comunione», cioè la necessità “più femminile” di fare networking. Le ragazze sarebbero cioè subalterne al confronto sociale, influenzate più degli utenti maschili soprattutto dai social di «tipo visuale» come Instagram e TikTok (i più usati).

La riduzione della nostra capacità cognitiva: che lo smartphone sia con noi o meno, controllare le notifiche resta un pensiero fisso
Per Haidt, quindi, i Social funzionano come degli inibitori di esperienze reali, che sono invece essenziali per la configurazione socioculturale di ognuno di noi. Lo psicologo difende la tesi per cui, come per altre abilità cognitive, anche per l’apprendimento culturale esista un «periodo critico», ossia una finestra temporale in cui le strutture cerebrali si modificano più facilmente in base alle esperienze che facciamo. Tale periodo, concesso l’uso del telefono in media attorno agli undici anni, secondo Haidt verrebbe compromesso. C’è di più: la «grande riconfigurazione» inciderebbe sul pruning, ovvero su quel processo tramite cui (semplificando) il nostro cervello rafforza e conserva solo i link sinaptici che durante l’evoluzione dell’individuo usa più di frequente. In tal senso lo studioso – ispirandosi alle ricerche di Laurence Steinberg in Adolescence (McGraw-Hill, 2023) – afferma che il sistema cognitivo dei più giovani ha subito – e continuerà a subire a meno che non si intervenga tempestivamente – una «riprogrammazione» in termini biologici.
Questo ri-cablaggio, a detta di Haidt, forma «una strada spianata nel cervello» dedicata «all’uso Social», in grado di colonizzare anche altri domini cognitivi. Ciò, per lo psicologo, asseconda l’insorgere di ansia e depressione, che a loro volta causano deficit di attenzione e dipendenza «da telefono». La prima riguarda la riduzione della nostra capacità cognitiva: che lo smartphone sia con noi o meno, controllare le notifiche resta un pensiero fisso. La seconda, invece, rimanda al fatto che le nostre «azioni online» siano «comportalmente manipolate». L’idea è che a ogni azione corrisponda una ricompensa, che, a livello neurale, può essere ad esempio il rilascio della dopamina, il neurotrasmettitore del piacere. Secondo il cosiddetto modello del gancio, il modo più efficace per stabilire questa dipendenza è costruire un meccanismo a ricompensa variabile, in cui non ottieni ciò che ti piace sempre con la stessa frequenza. Insomma, esattamente ciò che accade quando i feed di Instagram o TikTok ci mostrano apparentemente senza una regolarità i nostri contenuti preferiti.
Causa ed effetto
Dopo la sua pubblicazione, The Anxious Generation ha rapidamente riscosso un grande successo di pubblico. Il saggio, d’altronde, traccia un’ipotesi seducente, che a livello intuitivo era ed è già molto diffusa: i Social Network stanno rovinando i giovani. Ma quanto sono accurate le ipotesi di Haidt? Il «mondo virtuale» ha realmente causato «un’epidemia crescente di disturbi mentali» dalla Gen Z in avanti?
Per quanto riguarda l’aumento progressivo delle patologie mentali nell’ultimo decennio, la comunità scientifica è in gran parte concorde. Tuttavia, va sottolineato come la totalità degli studi citati da Haidt in questo senso siano delle «autovalutazioni», ovvero dei lunghi questionari in cui studenti e studentesse valutano autonomamente e soggettivamente la propria salute mentale. Questi, ai fini scientifici, sono degli indicatori da leggere quantomeno con cautela: come per molti altri fenomeni della contemporaneità, il fatto che oggi se ne si parli con maggior sensibilità e consapevolezza, di per sé non significa che tali fenomeni non fossero diffusi e radicati precedentemente. Questo vale anche per tutti gli altri studi che lo psicologo porta a supporto della sua tesi – per esempio, l’aumento di casi di autolesionismo -, contro chi sostiene che il fenomeno abbia numeri più contenuti, in parte mistificati proprio dalle autovalutazioni.
I dati più controversi, però, interessano soprattutto il nocciolo della tesi di Haidt, la «grande riconfigurazione». Infatti, le interpretazioni dello psicologo sembrano non tener conto della regola aurea di ogni ricerca sperimentale: correlazione e causalità non sono la stessa cosa. Il fatto cioè che l’aumento di disturbi mentali coincida cronologicamente con l’avvento dello smartphone prima e dell’uso “sregolato” dei Social Network poi, non è sufficiente a dimostrare che tra i due eventi ci sia un nesso di causalità. In tempi recenti, un ragiomento per certi versi simile (se non peggiore) ha supportato l’ipotesi della cosiddetta «recessione sessuale» tra i giovani. Si tratta, insomma, di un esercizio tanto fallace quanto pericoloso, che mischia arbitrariamente cause ed effetti, demonizza un fenomeno, senza un’anamnesi accurata dei fattori che corroborano una tendenza.
Addirittura, alcuni studi non solo dimostrano l’inconsistenza della sua ipotesi, ma ne ribaltano persino l’inferenza. Non sono pochi, infatti, gli studiosi secondo cui l’utilizzo eccessivo dei Social Network non predirebbe dei sintomi compatibili con depressione o ansia, ma, al contrario, la preesistenza di tale sintomatologia favorirebbe l’uso costante di Instagram o TikTok. Inoltre, la letteratura scientifica a disposizione non fornisce alcuna prova empirica che dimostri la riprogrammazione sociale e biologica del cervello di cui parla Haidt, tanto che diverse ricerche ridimensionano notevolmente l’impatto della tecnologia sull’infanzia e l’adolescenza. In linea generale comunque, a oggi, non si conosce bene la direzionalità del fenomeno, di conseguenza, il rischio – come accade nel saggio di Haidt – è di offrire una panoramica incompleta e impressionistica, che non considera globalmente probabili cause genetiche, epigenetiche e puramente sociali (per esempio, discriminazione razziale, bullismo, condizione economica, abuso di stupefacenti) di ansia e depressione.
Parallelamente, anche la dipendenza “da telefono” (che al 2024 non è ancora riconosciuta nel DSM-5) è dibattuta. Il lavoro di Haidt è meritorio quando elenca i (noti) meccanismi manipolatori di Meta e co e ne auspica la regolamentazione, ma le evidenze scientifiche più recenti legate a ADHD o alla nomofobia (letteralmente, no-mobile-phone-fobia) non stabiliscono che queste patologie siano il prodotto della «grande riconfigurazione», ma, invece, che siano alimentate da una lunga serie di fattori tutt’ora non chiariti.
Eccoci
In una scena di Eccomi (Guanda, 2016), l’ultimo romanzo di Jonathan Foer, il marito, quando la moglie scopre il tradimento, la rassicura dicendole che si tratta solo di messaggi compromettenti, nulla di più. La moglie, avvilita, gli dice che lo immaginava, «so che non hai il coraggio, sei solo bravo a parole» dice. Credo sia un’ottima immagine per considerare da una prospettiva leggermente differente il fenomeno a cui guarda Haidt, priva di sensazionalismi inutili alla The Social Dilemma, il documentario Netflix del 2020 che metteva in guardia sull’uso dei Social. Al di là dei dati – che, lo ribadisco, smentiscono la «grande riconfigurazione» -, credo che Haidt (come altri) semplifichi troppo quando considera «mondo virtuale» e «mondo reale» come due universi ontologicamente non comunicanti, il primo abitato dalla comunicazione sincrona delle telefonate, il secondo da quella asincrona, come il chatting su Whatsapp o la condivisione su Instagram e TikTok.
il ritratto di una generazione agonizzante, encefalicamente paralizzata dallo smartphone, è ingenuo
La scena del romanzo di Foer lo mostra inequivocabilmente: il «mondo virtuale» corrisponde a una dimensione parareale, eterotopica direbbe Foucault, in cui, talvolta, le conseguenze di alcuni comportamenti sembrano essere più lievi di quelle che dovremmo affrontare nel «mondo reale». Per questa ragione è così attrattivo per i giovani, che tentano di sostituire alle macerie del mondo reale, le possibilità del mondo virtuale, con tutti i rischi del caso.
In quest’ottica, le soluzioni “comportamentiste” di Haidt – «Vietare [collettivamente] l’accesso ai Social Network prima dei sedici anni» – non affrontano la complessità del rapporto tra giovani, Social Network e disturbi mentali. Queste, al contrario, andrebbero sostituite per esempio da una capillare e strutturata campagna di educazione digitale che permetta di gestire potenzialità e pericoli della tecnologia, che volenti o nolenti colonizzerà sempre di più il nostro quotidiano. Inserire dall’oggi al domani il parental control su Instagram (per esempio), oltre a essere scarsamente efficace come sappiamo, non tiene conto del fatto che i Social sono lo strumento espressivo imprescindibile dei più giovani, in cui si riconoscono.
Se, infatti, da un lato rivitalizzare il dibattito sull’impatto dei Social Network sulla salute mentale è urgente – e il saggio di Haidt offre molti spunti interessanti in questa direzione, come il legame tra Instagram e il disturbo della dismorfia -, dall’altro, il ritratto di una generazione agonizzante, encefalicamente paralizzata dallo smartphone, è ingenuo. Cavalcare, ancora, argomentazioni retoriche secondo cui i giovani sono ammalati perché vivono il «mondo virtuale» e di conseguenza «la loro immaginazione è assorbita da zuccherini mentali invece che dal duro sforzo dell’esplorazione metodica», è il frutto di un’analisi falsa e approssimativa, che non è in grado di riconoscere come Instagram o TikTok, più che «moderni aghi ipodermici», rispondano in molti casi all’esigenza inascoltata dei più giovani di oltrepassare le barriere sociali, economiche e politiche erette a partire ben prima del 2010.
Le illustrazioni di questo articolo sono firmate dall’artista Lilianna Lasocka, ospite della nostra nuova rubrica “Art Crush”.