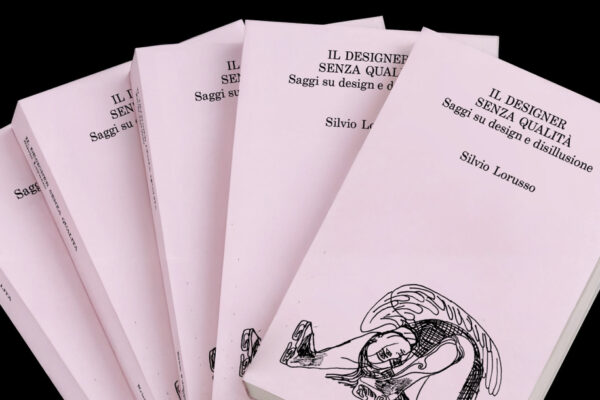Se sapete che cosa chiedere a un bambino quando vi capita di averci a che fare, bravi voi. C’erano due domande che facevano a me che però non vorrei subisse nessun altro bambino: la prima è “ce l’hai il fidanzatino/la fidanzatina?”, che a furia di chiedermela mi sono ritrovata sposata al mio compagno di asilo Marco Z. – a 30 anni dall’evento non s’è mai vista una carta per il divorzio, o un regalo per l’anniversario; la seconda è “cosa vuoi fare da grande?”, perché so che verrà posta in modo assillante intorno alle scuole medie, quando tradizione vuole che la scelta della scuola superiore comincerà a segnare la nostra strada verso i futuri 50 anni di carriera, escludendo centinaia di altre possibilità. Non sappiamo ancora mettere un assorbente interno, ma dovremmo decidere la nostra carriera.
Nel 2021 è nato un nuovo trend su YouTube, intitolato con una frase precedentemente pubblicata su altri social: “I don’t dream of labor”. Come molte frasi d’effetto, è in realtà la risposta a una domanda che certi utenti si sono fatti da soli così da poterla postare (grazie internet che ci fai parlare da soli senza sembrare matti). La prima fonte più condivisa di questa frase è in un tweet di @thetrudz dell’ottobre 2019: My “dream job” is… not working. No work. I don’t dream about labor. 38mila condivisioni, 116mila like. La seconda fonte è un audio di TikTok di Mr Hamilton datato luglio 2020, in cui mette in scena un dialogo intervistatore/intervistato: «So tell us, what’s your dream job?»
«Darling I told you several time before: I have no dream job, I do not dream of labor».
Questa frase in coda è la versione più usata dagli YouTuber che in questi giorni stanno pubblicando le loro riflessioni sul tema. Piccola nota linguistica: la parola “labor”, o “labour” per il Regno Unito, significa “lavoro di fatica” ed è anche il termine con cui si indica il travaglio del parto. Nei vocabolari si trova ancora il termine “travaglio” inteso come lavoro di fatica, ma se dicessi che esistono video dal titolo “Non sogno il travaglio” sembrerebbero gruppi di donne che non vogliono partorire – o hater del direttore del Fatto Quotidiano. Quindi la traduzione è “Non sogno il lavoro” inteso come le fatiche del lavoro, nessuna accezione positiva o neutra di termini come “job” o “work”. Nessuna delle persone che hanno pubblicato video su questo tema fanno lavori che considereremmo “di fatica”, per lo più sono impiegati in aziende – come direbbe mia nonna «non stanno mica lavorando in miniera».

In ordine cronologico, io ho voluto fare la paleontologa, l’archeologa, l’astronoma, l’endocrinologa, la stilista, la cantante (indovinate a che punto di questa lista sono apparsi i caratteri sessuali secondari femminili e i prodotti culturali annessi). In terza media ho iniziato a guardare con desiderio le riviste mensili di moda e attualità. La cosa più vicina a un vero “lavoro dei sogni” a cui ho pensato è stata “voglio stare dentro la redazione di una rivista”. Così ho scelto un generico liceo linguistico e una triennale in comunicazione, sbarrandomi le strade per qualsiasi titolo lavorativo che potesse fare colpo sui parenti. Sono entrata in una redazione nel 2010 e da quel momento ho visto chiudere la produzione di ben due riviste cartacee. Quando nel 2015 ho pensato di aggiungere “autrice TV” tra le voci del mio curriculum, le reti televisive stavano abbassando drasticamente i loro investimenti sulla produzione di nuovi programmi. Se volete sapere quali saranno i prossimi settori a fallire, seguitemi su LinkedIn.
Escludendo qualche frammento preso da TikTok del trend creato da MrHamilton e alcuni video con qualche decina di visualizzazioni, il primo video più visto del trend “I don’t dream of labor” è di Lynette Adkins, pubblicato 31 marzo 2021 – oltre 300mila visualizzazioni. Adkins è una ragazza americana che tra video cliché come gli haul (rassegne degli acquisti di un determinato brand di moda) e i Get ready with me (simili ai tutorial su come truccarsi, ma senza volontà di insegnare qualcosa, semplicemente mostrando come la persona si trucca per la giornata), pubblica alcuni consigli economici su come ripagare il debito studentesco, oppure su come trovare lavoro dopo l’università se non si hanno esperienze lavorative. Il suo video sul tema è titolato “I don’t have a dream job” e inizia con una frase in cui molti probabilmente si riconoscono: “Odio il suono della sveglia”. La sua esperienza è quella di una ragazza cresciuta con le ambizioni della upper-middle class, e che dopo il college è riuscita a trovare un posto dentro una grande azienda dell’ambito tech (in un video pubblicato il 30 giugno 2021 spiega di lavorare per Amazon Web Services prima di mostrare tutti i passaggi che l’hanno portata alle dimissioni).
Stesse premesse ha il video più visto sull’argomento, pubblicato il 12 maggio 2021 da Katherout con il titolo “I no longer aspire to have a career” – poco meno di 600mila visualizzazioni. La protagonista è una ragazza della Bay Area, un posto che da sua descrizione “imbeve i giovani della Silicon Valley di desiderio di andare in un college d’elite e di trovare un lavoro in una grande azienda”.
Per fare un velocissimo riassunto delle loro biografie: entrambe entrano nella grande azienda, entrambe sono felici di avercela fatta, entrambe si rendono conto che non solo il lavoro non è quello dei sogni, ma che i livelli di competitività e di produttività richiesta trasformano il lavoro in un incubo. Il pensiero che questa sarebbe stata la loro vita per i prossimi 40 anni ha convinto Adkins, Katherout e tutti gli altri che hanno registrato video come questo, che il concetto di “lavoro dei sogni” è sostanzialmente una truffa. Non è un caso che il trend sia nato quest’anno: nel 2020 abbiamo abbandonato i nostri uffici, e chi ha mantenuto il proprio lavoro lo ha svolto da casa, senza la dimensione sociale o le distrazioni del mondo esterno. Così anche il poco di positivo che poteva avere il lavoro è saltato, lasciandoci soli a contemplare quanto faccia schifo.
Nel 2021 è nato un nuovo trend su YouTube, intitolato con una frase precedentemente pubblicata su altri social: “I don’t dream of labor”. Un tema attorno al quale si stanno sviluppando diverse riflessioni legate al mondo del lavoro e all’illusione di trovare il lavoro dei proprio sogni.
Vi ricordate quando il lavoro è entrato nei vostri sogni? A me successe quando il primo stage part-time divenne un contratto full-time. Era pagato poco, senza veri e propri limiti di orario e richiedeva anche la presenza a una serie di attività serali organizzate dai superiori – non era una richiesta ufficiale tipo il cineforum in Fantozzi, ma nel momento in cui iniziai a chiedere un avanzamento di carriera, la mia assenza a questi eventi fu una giustificazione per farmi restare dove ero. Cominciai a sognare il mio capo, una persona estremamente aggressiva, che in uno di questi sogni cercava di lanciarmi una tarantola addosso, senza riuscirci. Il mio psicoterapeuta disse che era un ottimo segnale: inconsciamente sapevo che non poteva farmi davvero del male. Bello eh, però a me restava solo il ricordo della tachicardia alle 4 del mattino.
Quando questo capo se ne andò, il mio sogno ricorrente erano dialoghi con il signore che si occupava della contabilità, perché il lavoro creativo e divertente che credevo di avere era in realtà pieno di burocrazia. Ogni notte lui guardava le fatture dei collaboratori che gli giravo, mi diceva che non andavano bene per vari motivi, e io mi svegliavo con la tachicardia alle 4 del mattino. Poi andavo a lavoro, gli consegnavo le fatture dei collaboratori, lui mi diceva che non andavano bene per vari motivi, e io tornavo al mio posto con la tachicardia dalle 10 alle 19.
Molti video “I don’t dream of labor” sono una critica implicita alla “hustler culture”, una mentalità lavorativa che richiede la devozione verso l’azienda e in generale verso l’obiettivo di fare soldi. YouTube è stato il mezzo con cui si è celebrata l’hustler culture, presentata come l’unica via per avere lo stile di vita che certi YouTuber mostrano nei loro daily vlog, i video quotidiani girati in appartamenti bellissimi e open space luminosi dove, in modo cool e stylish e altre parole inglesi che sembrano strilli di riviste di moda, questi compilano file excel. Magari il software non è Excel, magari è Notion, Trello o Evernote, ma sempre di fogli di calcolo parliamo.
Torno un attimo a mia nonna e alla questione della miniera: nessuna di queste persone deve fare tre lavori “non qualificati” per riuscire a pagare un affitto e le bollette. Ma non fanno neppure lavori “meaningful”, un termine ampio che comprende dal medico all’autista di autobus e che David Graeber usa in contrapposizione ai “bullshit jobs”, i lavori del cazzo, non inteso come brutti e sottopagati, ma come ruoli aziendali ben pagati ma che in fondo sono completamente inutili – non creano nulla materialmente, non sono al servizio di nessun bisogno del consumatore, spesso non richiedono neppure della vera e propria attività al di là di presentarsi in ufficio. Un esempio: se il fattorino di Amazon non ci fosse, il vostro pacco non arriverebbe mai; se lo strategic account manager di Amazon non ci fosse, gli account sotto di lui lavorerebbero ugualmente, e il vostro pacco arriverebbe come previsto. Uno dei due deve scioperare per avere diritti basilari, l’altro ha un lavoro considerato dei sogni. Uno dei due è fondamentale per il servizio, l’altro è un ruolo più dimostrativo che altro.
Magari questo manager sa che il suo lavoro è inutile, e magari ha votato il suo tempo libero a dare senso al suo lavoro con attività nate con scopi diametralmente opposti. Magari fa meditazione mindful per essere più concentrato sul qui e ora del file excel che ha davanti agli occhi.

Nel tentativo di gestire la mia insofferenza per il mondo del lavoro, mi rivolsi a uno dei più grandi guru viventi: Alain de Botton, filosofo fondatore di The School of Life. Incappai nel documentario basato sul suo libro Status Anxiety, tradotto in italiano da Guanda in L’importanza di essere amati. L’ansia da status è un fenomeno nato negli Stati Uniti, una società democratica e capitalista dove è possibile – o meglio, si vende l’idea che sia possibile – cambiare la propria classe sociale attraverso il grande impegno, che sicuramente porterà al successo. Il concetto di meritocrazia ha però un lato negativo: sottintende che chi non ha raggiunto il successo è un fallito che non si è impegnato abbastanza, che non ha le capacità, senza considerare che qualcuno potrebbe non aver avuto le possibilità di realizzarsi – o anche la volontà di realizzarsi, un’opzione inaccettabile sotto il capitalismo. Facciamo un esempio: una persona fa la commessa in un negozio per ragioni che vanno dal pagare le bollette al pagare gli studi in ingegneria biomedica, non lo sappiamo. Per certi osservatori, quella posizione lavorativa rappresenta una sconfitta, uno spreco, e potrebbero dire che la persona guadagna poco perché fa un lavoro che vale poco – e di conseguenza, vale poco la persona stessa. Se facesse, dico un lavoro a caso, la guida turistica, guadagnerebbe di più e quindi varrebbe di più come individuo. Chi crede che il valore della persona sia il valore della sua posizione sociale/economica, non può che considerare una commessa una persona inferiore. E se questa persona crede a certi commenti, proverà ansia da status.
Folgorata da queste riflessioni profondissime, continuai a consumare contenuti, video, libretti e giochetti da tavolo di The school of life che mi spiegavano che ero una rosicona di merda non perché sono una brutta persona, ma per colpa di questa tremenda società. Tutto bello, ma come potevo cambiare la situazione? Alain aveva un unico consiglio praticamente per tutto: rivolgetevi all’arte per consolarvi dalle vostre sciagure.
Devo dire che pensare “Il mio lavoro è una merda sottopagata che mi provoca attacchi d’ansia quotidiani” davanti a un Hayez nella Pinacoteca di Brera era meglio che farlo davanti ai piatti da lavare, ma non mi sembrava una soluzione al problema. Poi, durante una gita al negozio di The School of Life, davanti alla brochure degli incontri per le aziende, ho avuto l’illuminazione: Alain vuole solo che io me ne faccia pacificamente una ragione. Grazie al cazzo, Alain.
Molti video “I don’t dream of labor” sono una critica implicita alla “hustler culture”, una mentalità lavorativa che richiede la devozione verso l’azienda e in generale verso l’obiettivo di fare soldi. Un’ambizione che forse su YouTube più che da qualunque altra parte su internet è stata celebrata con quantità enormi di daily vlog che spiegano come diventare ricchi grazie ai sacrifici sul lavoro.
La maggior parte dei video “I don’t dream of labor” danno la colpa della situazione al capitalismo, nominandolo continuamente. Il capitalismo che pretende tutto e non ripaga i lavoratori. Un dato che viene mostrato in molti di questi video è il “productivity-pay gap”, la distanza tra produttività e buste paga. Dal 1979 al 2019 la produttività è cresciuta del 72,2%, la retribuzione oraria solamente del 17,2%. Il profitto creato dallo scarto tra i due dati va tutto ai grandi capi d’azienda. Si lavora sempre di più, per guadagnare sempre lo stesso.
Quindi saranno questi YouTuber a fare la rivoluzione socialista? Figurati, è più probabile che se Marx fosse vivo farebbe video con la sua beauty routine.
Ogni trend su YouTube ha il suo controtrend, ovvero i video che criticano il trend. Alcuni esempi del genere sono “The I don’t dream about labor trend needs to be destroyed” di Kidology, “I don’t dream about labor: self-help scam or revolutionary concept?” di Alice Cappelle o “The ‘I don’t dream of labour’ trend is PRIVILEGE” di BlueMoonPearl. La criticità più sollevata da questi video è che hanno la prospettiva di persone privilegiate. La seconda criticità è che le soluzioni portate da questi YouTuber spesso sono tanto capitaliste e neo-liberali quanto il tema sollevato. Molti parlano di sostituire il lavoro d’ufficio con delle passive source of income, ovvero degli investimenti che permettano di guadagnare lavorando il meno possibile (ad esempio, comprando un appartamento e mettendolo in affitto), oppure di usare il capitalismo per dare ai poveri – Adkins nel suo video dice di voler diventare agente immobiliare per poter vendere appartamenti a prezzi più bassi a chi ne ha bisogno, come se il grande benefattore fosse una vera soluzione. L’ultima e più nominata soluzione è quella di creare profitti dalle proprie passioni, delle multiple source of income che rendano gli hobby delle fonti di guadagno e che permettano di non lavorare “dalle 9 alle 17” – uno di questi hobby è, ça va sans dire, monetizzare dai video per YouTube.
L’uso di termini come capitalismo o neo-liberismo in questi video fanno intuire che i protagonisti siano consci della dimensione collettiva del problema, ma le soluzioni sono solo per una persona: tutte le forme di guadagno alternative ipotizzate prevedono altri lavoratori che a loro volta probabilmente aveva un lavoro dei sogni e invece si ritrovano a ottimizzare i server dove andranno i video di questi YouTuber o a dover creare file excel dove allocare i budget delle inserzioni sponsorizzate all’interno di questi video, tutti i giorni, per 8 ore al giorno. Aggiungo che il problema del multiple source of income, ovvero dell’essere un freelance, è tra le forme più stressanti di lavoro: il procacciamento, l’assenza di limiti netti tra quando si lavora e quando no, la difficoltà a far accettare il proprio valore, per non parlare della riscossione crediti (forse un problema più italiano che americano). Oltretutto la rilevanza dei contenuti online è subordinata a cambiamenti sociali, come la moda, ma anche tecnologici, dal nuovo algoritmo al nuovo social network più rilevante del precedente. Tutto molto lontano dall’idea di togliere l’ansia dalle proprie vite.
Il problema sollevato è estremamente interessante: varie generazioni cresciute con l’idea di doversi realizzare attraverso lavori altisonanti ora si rendono conto che quando va bene sono inutili, quando va male sono sottopagati e senza sosta, e per la maggior parte di loro saranno comunque irraggiungibili. Però, com’è, come non è, la soluzione non è su YouTube. Non è neanche in un pezzo su Siamomine scritto da una che da un mese si sveglia con la tachicardia perché sta facendo cinque lavori contemporaneamente che richiedono molte più attenzioni di quelle messe nel preventivo. Se volete ci troviamo a Brera davanti al Cristo Morto del Mantegna per digrignare i denti insieme.